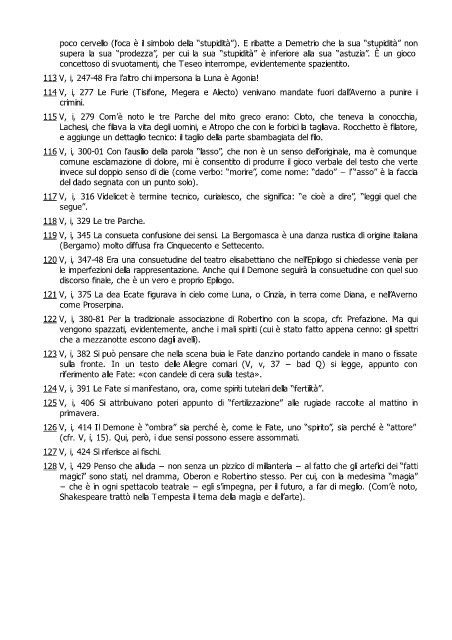Page 2723 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2723
poco cervello (l’oca è il simbolo della “stupidità”). E ribatte a Demetrio che la sua “stupidità” non
supera la sua “prodezza”, per cui la sua “stupidità” è inferiore alla sua “astuzia”. È un gioco
concettoso di svuotamenti, che Teseo interrompe, evidentemente spazientito.
113 V, i, 247-48 Fra l’altro chi impersona la Luna è Agonia!
114 V, i, 277 Le Furie (Tisifone, Megera e Alecto) venivano mandate fuori dall’Averno a punire i
crimini.
115 V, i, 279 Com’è noto le tre Parche del mito greco erano: Cloto, che teneva la conocchia,
Lachesi, che filava la vita degli uomini, e Atropo che con le forbici la tagliava. Rocchetto è filatore,
e aggiunge un dettaglio tecnico: il taglio della parte sbambagiata del filo.
116 V, i, 300-01 Con l’ausilio della parola “lasso”, che non è un senso dell’originale, ma è comunque
comune esclamazione di dolore, mi è consentito di produrre il gioco verbale del testo che verte
invece sul doppio senso di die (come verbo: “morire”, come nome: “dado” - l’ “asso” è la faccia
del dado segnata con un punto solo).
117 V, i, 316 Videlicet è termine tecnico, curialesco, che significa: “e cioè a dire”, “leggi quel che
segue”.
118 V, i, 329 Le tre Parche.
119 V, i, 345 La consueta confusione dei sensi. La Bergomasca è una danza rustica di origine italiana
(Bergamo) molto diffusa fra Cinquecento e Settecento.
120 V, i, 347-48 Era una consuetudine del teatro elisabettiano che nell’Epilogo si chiedesse venia per
le imperfezioni della rappresentazione. Anche qui il Demone seguirà la consuetudine con quel suo
discorso finale, che è un vero e proprio Epilogo.
121 V, i, 375 La dea Ecate figurava in cielo come Luna, o Cinzia, in terra come Diana, e nell’Averno
come Proserpina.
122 V, i, 380-81 Per la tradizionale associazione di Robertino con la scopa, cfr. Prefazione. Ma qui
vengono spazzati, evidentemente, anche i mali spiriti (cui è stato fatto appena cenno: gli spettri
che a mezzanotte escono dagli avelli).
123 V, i, 382 Si può pensare che nella scena buia le Fate danzino portando candele in mano o fissate
sulla fronte. In un testo delle Allegre comari (V, v, 37 - bad Q) si legge, appunto con
riferimento alle Fate: «con candele di cera sulla testa».
124 V, i, 391 Le Fate si manifestano, ora, come spiriti tutelari della “fertilità”.
125 V, i, 406 Si attribuivano poteri appunto di “fertilizzazione” alle rugiade raccolte al mattino in
primavera.
126 V, i, 414 Il Demone è “ombra” sia perché è, come le Fate, uno “spirito”, sia perché è “attore”
(cfr. V, i, 15). Qui, però, i due sensi possono essere assommati.
127 V, i, 424 Si riferisce ai fischi.
128 V, i, 429 Penso che alluda - non senza un pizzico di millanteria - al fatto che gli artefici dei “fatti
magici” sono stati, nel dramma, Oberon e Robertino stesso. Per cui, con la medesima “magia”
- che è in ogni spettacolo teatrale - egli s’impegna, per il futuro, a far di meglio. (Com’è noto,
Shakespeare trattò nella Tempesta il tema della magia e dell’arte).