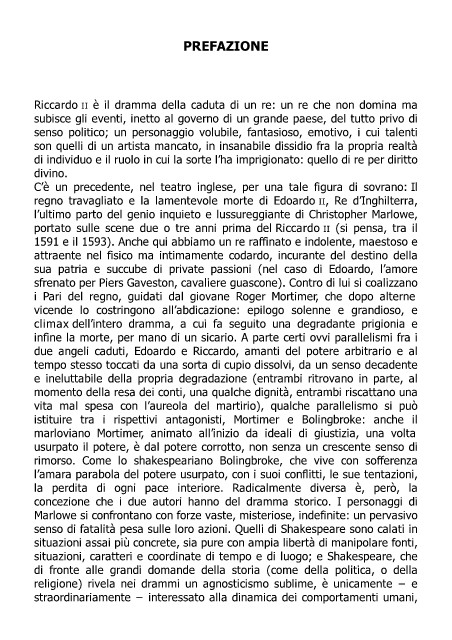Page 2725 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2725
PREFAZIONE
Riccardo II è il dramma della caduta di un re: un re che non domina ma
subisce gli eventi, inetto al governo di un grande paese, del tutto privo di
senso politico; un personaggio volubile, fantasioso, emotivo, i cui talenti
son quelli di un artista mancato, in insanabile dissidio fra la propria realtà
di individuo e il ruolo in cui la sorte l’ha imprigionato: quello di re per diritto
divino.
C’è un precedente, nel teatro inglese, per una tale figura di sovrano: Il
regno travagliato e la lamentevole morte di Edoardo II, Re d’Inghilterra,
l’ultimo parto del genio inquieto e lussureggiante di Christopher Marlowe,
portato sulle scene due o tre anni prima del Riccardo II (si pensa, tra il
1591 e il 1593). Anche qui abbiamo un re raffinato e indolente, maestoso e
attraente nel fisico ma intimamente codardo, incurante del destino della
sua patria e succube di private passioni (nel caso di Edoardo, l’amore
sfrenato per Piers Gaveston, cavaliere guascone). Contro di lui si coalizzano
i Pari del regno, guidati dal giovane Roger Mortimer, che dopo alterne
vicende lo costringono all’abdicazione: epilogo solenne e grandioso, e
climax dell’intero dramma, a cui fa seguito una degradante prigionia e
infine la morte, per mano di un sicario. A parte certi ovvi parallelismi fra i
due angeli caduti, Edoardo e Riccardo, amanti del potere arbitrario e al
tempo stesso toccati da una sorta di cupio dissolvi, da un senso decadente
e ineluttabile della propria degradazione (entrambi ritrovano in parte, al
momento della resa dei conti, una qualche dignità, entrambi riscattano una
vita mal spesa con l’aureola del martirio), qualche parallelismo si può
istituire tra i rispettivi antagonisti, Mortimer e Bolingbroke: anche il
marloviano Mortimer, animato all’inizio da ideali di giustizia, una volta
usurpato il potere, è dal potere corrotto, non senza un crescente senso di
rimorso. Come lo shakespeariano Bolingbroke, che vive con sofferenza
l’amara parabola del potere usurpato, con i suoi conflitti, le sue tentazioni,
la perdita di ogni pace interiore. Radicalmente diversa è, però, la
concezione che i due autori hanno del dramma storico. I personaggi di
Marlowe si confrontano con forze vaste, misteriose, indefinite: un pervasivo
senso di fatalità pesa sulle loro azioni. Quelli di Shakespeare sono calati in
situazioni assai più concrete, sia pure con ampia libertà di manipolare fonti,
situazioni, caratteri e coordinate di tempo e di luogo; e Shakespeare, che
di fronte alle grandi domande della storia (come della politica, o della
religione) rivela nei drammi un agnosticismo sublime, è unicamente - e
straordinariamente - interessato alla dinamica dei comportamenti umani,