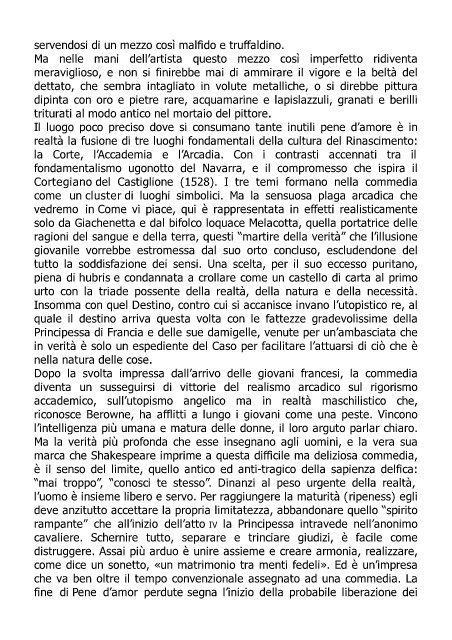Page 2237 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2237
servendosi di un mezzo così malfido e truffaldino.
Ma nelle mani dell’artista questo mezzo così imperfetto ridiventa
meraviglioso, e non si finirebbe mai di ammirare il vigore e la beltà del
dettato, che sembra intagliato in volute metalliche, o si direbbe pittura
dipinta con oro e pietre rare, acquamarine e lapislazzuli, granati e berilli
triturati al modo antico nel mortaio del pittore.
Il luogo poco preciso dove si consumano tante inutili pene d’amore è in
realtà la fusione di tre luoghi fondamentali della cultura del Rinascimento:
la Corte, l’Accademia e l’Arcadia. Con i contrasti accennati tra il
fondamentalismo ugonotto del Navarra, e il compromesso che ispira il
Cortegiano del Castiglione (1528). I tre temi formano nella commedia
come un cluster di luoghi simbolici. Ma la sensuosa plaga arcadica che
vedremo in Come vi piace, qui è rappresentata in effetti realisticamente
solo da Giachenetta e dal bifolco loquace Melacotta, quella portatrice delle
ragioni del sangue e della terra, questi “martire della verità” che l’illusione
giovanile vorrebbe estromessa dal suo orto concluso, escludendone del
tutto la soddisfazione dei sensi. Una scelta, per il suo eccesso puritano,
piena di hubris e condannata a crollare come un castello di carta al primo
urto con la triade possente della realtà, della natura e della necessità.
Insomma con quel Destino, contro cui si accanisce invano l’utopistico re, al
quale il destino arriva questa volta con le fattezze gradevolissime della
Principessa di Francia e delle sue damigelle, venute per un’ambasciata che
in verità è solo un espediente del Caso per facilitare l’attuarsi di ciò che è
nella natura delle cose.
Dopo la svolta impressa dall’arrivo delle giovani francesi, la commedia
diventa un susseguirsi di vittorie del realismo arcadico sul rigorismo
accademico, sull’utopismo angelico ma in realtà maschilistico che,
riconosce Berowne, ha afflitti a lungo i giovani come una peste. Vincono
l’intelligenza più umana e matura delle donne, il loro arguto parlar chiaro.
Ma la verità più profonda che esse insegnano agli uomini, e la vera sua
marca che Shakespeare imprime a questa difficile ma deliziosa commedia,
è il senso del limite, quello antico ed anti-tragico della sapienza delfica:
“mai troppo”, “conosci te stesso”. Dinanzi al peso urgente della realtà,
l’uomo è insieme libero e servo. Per raggiungere la maturità (ripeness) egli
deve anzitutto accettare la propria limitatezza, abbandonare quello “spirito
rampante” che all’inizio dell’atto IV la Principessa intravede nell’anonimo
cavaliere. Schernire tutto, separare e trinciare giudizi, è facile come
distruggere. Assai più arduo è unire assieme e creare armonia, realizzare,
come dice un sonetto, «un matrimonio tra menti fedeli». Ed è un’impresa
che va ben oltre il tempo convenzionale assegnato ad una commedia. La
fine di Pene d’amor perdute segna l’inizio della probabile liberazione dei