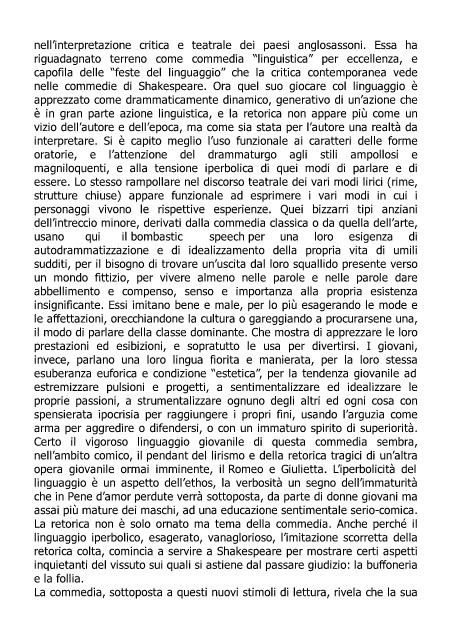Page 2234 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2234
nell’interpretazione critica e teatrale dei paesi anglosassoni. Essa ha
riguadagnato terreno come commedia “linguistica” per eccellenza, e
capofila delle “feste del linguaggio” che la critica contemporanea vede
nelle commedie di Shakespeare. Ora quel suo giocare col linguaggio è
apprezzato come drammaticamente dinamico, generativo di un’azione che
è in gran parte azione linguistica, e la retorica non appare più come un
vizio dell’autore e dell’epoca, ma come sia stata per l’autore una realtà da
interpretare. Si è capito meglio l’uso funzionale ai caratteri delle forme
oratorie, e l’attenzione del drammaturgo agli stili ampollosi e
magniloquenti, e alla tensione iperbolica di quei modi di parlare e di
essere. Lo stesso rampollare nel discorso teatrale dei vari modi lirici (rime,
strutture chiuse) appare funzionale ad esprimere i vari modi in cui i
personaggi vivono le rispettive esperienze. Quei bizzarri tipi anziani
dell’intreccio minore, derivati dalla commedia classica o da quella dell’arte,
usano qui il bombastic speech per una loro esigenza di
autodrammatizzazione e di idealizzamento della propria vita di umili
sudditi, per il bisogno di trovare un’uscita dal loro squallido presente verso
un mondo fittizio, per vivere almeno nelle parole e nelle parole dare
abbellimento e compenso, senso e importanza alla propria esistenza
insignificante. Essi imitano bene e male, per lo più esagerando le mode e
le affettazioni, orecchiandone la cultura o gareggiando a procurarsene una,
il modo di parlare della classe dominante. Che mostra di apprezzare le loro
prestazioni ed esibizioni, e sopratutto le usa per divertirsi. I giovani,
invece, parlano una loro lingua fiorita e manierata, per la loro stessa
esuberanza euforica e condizione “estetica”, per la tendenza giovanile ad
estremizzare pulsioni e progetti, a sentimentalizzare ed idealizzare le
proprie passioni, a strumentalizzare ognuno degli altri ed ogni cosa con
spensierata ipocrisia per raggiungere i propri fini, usando l’arguzia come
arma per aggredire o difendersi, o con un immaturo spirito di superiorità.
Certo il vigoroso linguaggio giovanile di questa commedia sembra,
nell’ambito comico, il pendant del lirismo e della retorica tragici di un’altra
opera giovanile ormai imminente, il Romeo e Giulietta. L’iperbolicità del
linguaggio è un aspetto dell’ethos, la verbosità un segno dell’immaturità
che in Pene d’amor perdute verrà sottoposta, da parte di donne giovani ma
assai più mature dei maschi, ad una educazione sentimentale serio-comica.
La retorica non è solo ornato ma tema della commedia. Anche perché il
linguaggio iperbolico, esagerato, vanaglorioso, l’imitazione scorretta della
retorica colta, comincia a servire a Shakespeare per mostrare certi aspetti
inquietanti del vissuto sui quali si astiene dal passare giudizio: la buffoneria
e la follia.
La commedia, sottoposta a questi nuovi stimoli di lettura, rivela che la sua