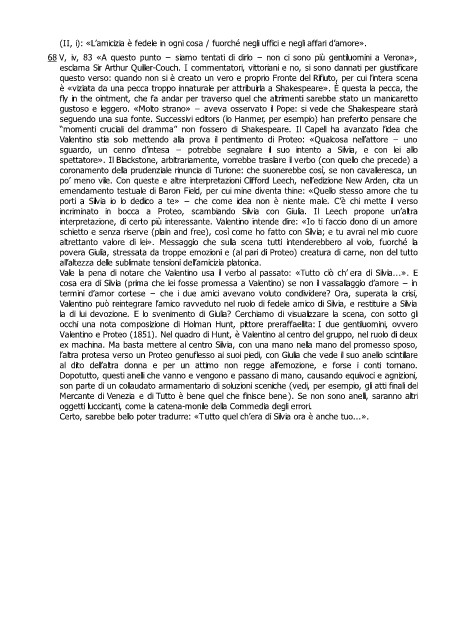Page 1991 - Shakespeare - Vol. 1
P. 1991
(II, i): «L’amicizia è fedele in ogni cosa / fuorché negli uffici e negli affari d’amore».
68 V, iv, 83 «A questo punto - siamo tentati di dirlo - non ci sono più gentiluomini a Verona»,
esclama Sir Arthur Quiller-Couch. I commentatori, vittoriani e no, si sono dannati per giustificare
questo verso: quando non si è creato un vero e proprio Fronte del Rifiuto, per cui l’intera scena
è «viziata da una pecca troppo innaturale per attribuirla a Shakespeare». È questa la pecca, the
fly in the ointment, che fa andar per traverso quel che altrimenti sarebbe stato un manicaretto
gustoso e leggero. «Molto strano» - aveva osservato il Pope: si vede che Shakespeare starà
seguendo una sua fonte. Successivi editors (lo Hanmer, per esempio) han preferito pensare che
“momenti cruciali del dramma” non fossero di Shakespeare. Il Capell ha avanzato l’idea che
Valentino stia solo mettendo alla prova il pentimento di Proteo: «Qualcosa nell’attore - uno
sguardo, un cenno d’intesa - potrebbe segnalare il suo intento a Silvia, e con lei allo
spettatore». Il Blackstone, arbitrariamente, vorrebbe traslare il verbo (con quello che precede) a
coronamento della prudenziale rinuncia di Turione: che suonerebbe così, se non cavalleresca, un
po’ meno vile. Con queste e altre interpretazioni Clifford Leech, nell’edizione New Arden, cita un
emendamento testuale di Baron Field, per cui mine diventa thine: «Quello stesso amore che tu
porti a Silvia io lo dedico a te» - che come idea non è niente male. C’è chi mette il verso
incriminato in bocca a Proteo, scambiando Silvia con Giulia. Il Leech propone un’altra
interpretazione, di certo più interessante. Valentino intende dire: «Io ti faccio dono di un amore
schietto e senza riserve (plain and free), così come ho fatto con Silvia; e tu avrai nel mio cuore
altrettanto valore di lei». Messaggio che sulla scena tutti intenderebbero al volo, fuorché la
povera Giulia, stressata da troppe emozioni e (al pari di Proteo) creatura di carne, non del tutto
all’altezza delle sublimate tensioni dell’amicizia platonica.
Vale la pena di notare che Valentino usa il verbo al passato: «Tutto ciò ch’ era di Silvia...». E
cosa era di Silvia (prima che lei fosse promessa a Valentino) se non il vassallaggio d’amore - in
termini d’amor cortese - che i due amici avevano voluto condividere? Ora, superata la crisi,
Valentino può reintegrare l’amico ravveduto nel ruolo di fedele amico di Silvia, e restituire a Silvia
la di lui devozione. E lo svenimento di Giulia? Cerchiamo di visualizzare la scena, con sotto gli
occhi una nota composizione di Holman Hunt, pittore preraffaellita: I due gentiluomini, ovvero
Valentino e Proteo (1851). Nel quadro di Hunt, è Valentino al centro del gruppo, nel ruolo di deux
ex machina. Ma basta mettere al centro Silvia, con una mano nella mano del promesso sposo,
l’altra protesa verso un Proteo genuflesso ai suoi piedi, con Giulia che vede il suo anello scintillare
al dito dell’altra donna e per un attimo non regge all’emozione, e forse i conti tornano.
Dopotutto, questi anelli che vanno e vengono e passano di mano, causando equivoci e agnizioni,
son parte di un collaudato armamentario di soluzioni sceniche (vedi, per esempio, gli atti finali del
Mercante di Venezia e di Tutto è bene quel che finisce bene ). Se non sono anelli, saranno altri
oggetti luccicanti, come la catena-monile della Commedia degli errori.
Certo, sarebbe bello poter tradurre: «Tutto quel ch’era di Silvia ora è anche tuo...».