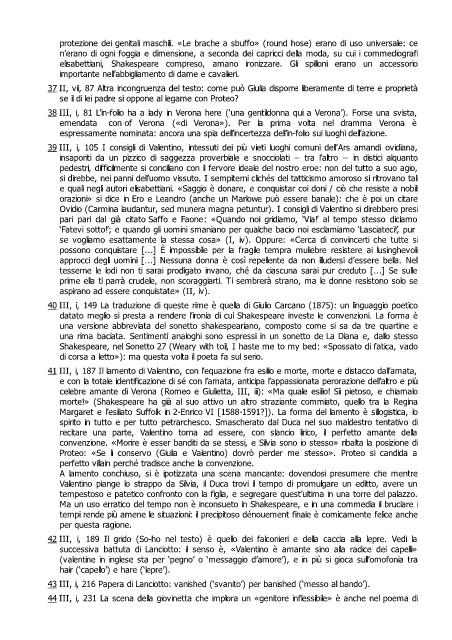Page 1988 - Shakespeare - Vol. 1
P. 1988
protezione dei genitali maschili. «Le brache a sbuffo» (round hose) erano di uso universale: ce
n’erano di ogni foggia e dimensione, a seconda dei capricci della moda, su cui i commediografi
elisabettiani, Shakespeare compreso, amano ironizzare. Gli spilloni erano un accessorio
importante nell’abbigliamento di dame e cavalieri.
37 II, vii, 87 Altra incongruenza del testo: come può Giulia disporre liberamente di terre e proprietà
se il di lei padre si oppone al legame con Proteo?
38 III, i, 81 L’in-folio ha a lady in Verona here (‘una gentildonna qui a Verona’). Forse una svista,
emendata con of Verona («di Verona»). Per la prima volta nel dramma Verona è
espressamente nominata: ancora una spia dell’incertezza dell’in-folio sui luoghi dell’azione.
39 III, i, 105 I consigli di Valentino, intessuti dei più vieti luoghi comuni dell’Ars amandi ovidiana,
insaporiti da un pizzico di saggezza proverbiale e snocciolati - tra l’altro - in distici alquanto
pedestri, difficilmente si conciliano con il fervore ideale del nostro eroe: non del tutto a suo agio,
si direbbe, nei panni dell’uomo vissuto. I sempiterni clichés del tatticismo amoroso si ritrovano tali
e quali negli autori elisabettiani. «Saggio è donare, e conquistar coi doni / ciò che resiste a nobili
orazioni» si dice in Ero e Leandro (anche un Marlowe può essere banale): che è poi un citare
Ovidio (Carmina laudantur, sed munera magna petuntur). I consigli di Valentino si direbbero presi
pari pari dal già citato Saffo e Faone: «Quando noi gridiamo, ‘Via!’ al tempo stesso diciamo
‘Fatevi sotto!’; e quando gli uomini smaniano per qualche bacio noi esclamiamo ‘Lasciateci!’, pur
se vogliamo esattamente la stessa cosa» (I, iv). Oppure: «Cerca di convincerti che tutte si
possono conquistare [...] È impossibile per la fragile tempra muliebre resistere ai lusinghevoli
approcci degli uomini [...] Nessuna donna è così repellente da non illudersi d’essere bella. Nel
tesserne le lodi non ti sarai prodigato invano, ché da ciascuna sarai pur creduto [...] Se sulle
prime ella ti parrà crudele, non scoraggiarti. Ti sembrerà strano, ma le donne resistono solo se
aspirano ad essere conquistate» (II, iv).
40 III, i, 149 La traduzione di queste rime è quella di Giulio Carcano (1875): un linguaggio poetico
datato meglio si presta a rendere l’ironia di cui Shakespeare investe le convenzioni. La forma è
una versione abbreviata del sonetto shakespeariano, composto come si sa da tre quartine e
una rima baciata. Sentimenti analoghi sono espressi in un sonetto de La Diana e, dallo stesso
Shakespeare, nel Sonetto 27 (Weary with toil, I haste me to my bed: «Spossato di fatica, vado
di corsa a letto»): ma questa volta il poeta fa sul serio.
41 III, i, 187 Il lamento di Valentino, con l’equazione fra esilio e morte, morte e distacco dall’amata,
e con la totale identificazione di sé con l’amata, anticipa l’appassionata perorazione dell’altro e più
celebre amante di Verona (Romeo e Giulietta, III, iii): «Ma quale esilio! Sii pietoso, e chiamalo
morte!» (Shakespeare ha già al suo attivo un altro straziante commiato, quello tra la Regina
Margaret e l’esiliato Suffolk in 2-Enrico VI [1588-1591?]). La forma del lamento è sillogistica, lo
spirito in tutto e per tutto petrarchesco. Smascherato dal Duca nel suo maldestro tentativo di
recitare una parte, Valentino torna ad essere, con slancio lirico, il perfetto amante della
convenzione. «Morire è esser banditi da se stessi, e Silvia sono io stesso» ribalta la posizione di
Proteo: «Se li conservo (Giulia e Valentino) dovrò perder me stesso». Proteo si candida a
perfetto villain perché tradisce anche la convenzione.
A lamento conchiuso, si è ipotizzata una scena mancante: dovendosi presumere che mentre
Valentino piange lo strappo da Silvia, il Duca trovi il tempo di promulgare un editto, avere un
tempestoso e patetico confronto con la figlia, e segregare quest’ultima in una torre del palazzo.
Ma un uso erratico del tempo non è inconsueto in Shakespeare, e in una commedia il bruciare i
tempi rende più amene le situazioni: il precipitoso dénouement finale è comicamente felice anche
per questa ragione.
42 III, i, 189 Il grido (So-ho nel testo) è quello dei falconieri e della caccia alla lepre. Vedi la
successiva battuta di Lanciotto: il senso è, «Valentino è amante sino alla radice dei capelli»
(valentine in inglese sta per ‘pegno’ o ‘messaggio d’amore’), e in più si gioca sull’omofonia tra
hair (‘capello’) e hare (‘lepre’).
43 III, i, 216 Papera di Lanciotto: vanished (‘svanito’) per banished (‘messo al bando’).
44 III, i, 231 La scena della giovinetta che implora un «genitore inflessibile» è anche nel poema di