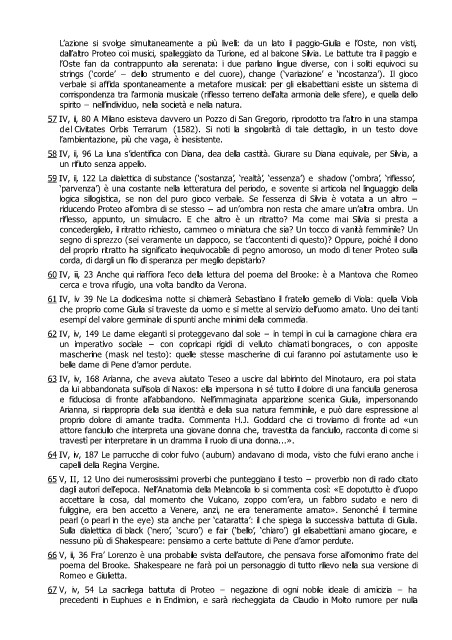Page 1990 - Shakespeare - Vol. 1
P. 1990
L’azione si svolge simultaneamente a più livelli: da un lato il paggio-Giulia e l’Oste, non visti,
dall’altro Proteo coi musici, spalleggiato da Turione, ed al balcone Silvia. Le battute tra il paggio e
l’Oste fan da contrappunto alla serenata: i due parlano lingue diverse, con i soliti equivoci su
strings (‘corde’ - dello strumento e del cuore), change (‘variazione’ e ‘incostanza’). Il gioco
verbale si affida spontaneamente a metafore musicali: per gli elisabettiani esiste un sistema di
corrispondenza tra l’armonia musicale (riflesso terreno dell’alta armonia delle sfere), e quella dello
spirito - nell’individuo, nella società e nella natura.
57 IV, ii, 80 A Milano esisteva davvero un Pozzo di San Gregorio, riprodotto tra l’altro in una stampa
de l Civitates Orbis Terrarum (1582). Si noti la singolarità di tale dettaglio, in un testo dove
l’ambientazione, più che vaga, è inesistente.
58 IV, ii, 96 La luna s’identifica con Diana, dea della castità. Giurare su Diana equivale, per Silvia, a
un rifiuto senza appello.
59 IV, ii, 122 La dialettica di substance (‘sostanza’, ‘realtà’, ‘essenza’) e shadow (‘ombra’, ‘riflesso’,
‘parvenza’) è una costante nella letteratura del periodo, e sovente si articola nel linguaggio della
logica sillogistica, se non del puro gioco verbale. Se l’essenza di Silvia è votata a un altro -
riducendo Proteo all’ombra di se stesso - ad un’ombra non resta che amare un’altra ombra. Un
riflesso, appunto, un simulacro. E che altro è un ritratto? Ma come mai Silvia si presta a
concederglielo, il ritratto richiesto, cammeo o miniatura che sia? Un tocco di vanità femminile? Un
segno di sprezzo (sei veramente un dappoco, se t’accontenti di questo)? Oppure, poiché il dono
del proprio ritratto ha significato inequivocabile di pegno amoroso, un modo di tener Proteo sulla
corda, di dargli un filo di speranza per meglio depistarlo?
60 IV, iii, 23 Anche qui riaffiora l’eco della lettura del poema del Brooke: è a Mantova che Romeo
cerca e trova rifugio, una volta bandito da Verona.
61 IV, iv 39 Ne La dodicesima notte si chiamerà Sebastiano il fratello gemello di Viola: quella Viola
che proprio come Giulia si traveste da uomo e si mette al servizio dell’uomo amato. Uno dei tanti
esempi del valore germinale di spunti anche minimi della commedia.
62 IV, iv, 149 Le dame eleganti si proteggevano dal sole - in tempi in cui la carnagione chiara era
un imperativo sociale - con copricapi rigidi di velluto chiamati bongraces, o con apposite
mascherine (mask nel testo): quelle stesse mascherine di cui faranno poi astutamente uso le
belle dame di Pene d’amor perdute.
63 IV, iv, 168 Arianna, che aveva aiutato Teseo a uscire dal labirinto del Minotauro, era poi stata
da lui abbandonata sull’isola di Naxos: ella impersona in sé tutto il dolore di una fanciulla generosa
e fiduciosa di fronte all’abbandono. Nell’immaginata apparizione scenica Giulia, impersonando
Arianna, si riappropria della sua identità e della sua natura femminile, e può dare espressione al
proprio dolore di amante tradita. Commenta H.J. Goddard che ci troviamo di fronte ad «un
attore fanciullo che interpreta una giovane donna che, travestita da fanciullo, racconta di come si
travestì per interpretare in un dramma il ruolo di una donna...».
64 IV, iv, 187 Le parrucche di color fulvo (auburn) andavano di moda, visto che fulvi erano anche i
capelli della Regina Vergine.
65 V, II, 12 Uno dei numerosissimi proverbi che punteggiano il testo - proverbio non di rado citato
dagli autori dell’epoca. Nell’Anatomia della Melancolia lo si commenta così: «E dopotutto è d’uopo
accettare la cosa, dal momento che Vulcano, zoppo com’era, un fabbro sudato e nero di
fuliggine, era ben accetto a Venere, anzi, ne era teneramente amato». Senonché il termine
pearl (o pearl in the eye) sta anche per ‘cataratta’: il che spiega la successiva battuta di Giulia.
Sulla dialettica di black (‘nero’, ‘scuro’) e fair (‘bello’, ‘chiaro’) gli elisabettiani amano giocare, e
nessuno più di Shakespeare: pensiamo a certe battute di Pene d’amor perdute.
66 V, ii, 36 Fra’ Lorenzo è una probabile svista dell’autore, che pensava forse all’omonimo frate del
poema del Brooke. Shakespeare ne farà poi un personaggio di tutto rilievo nella sua versione di
Romeo e Giulietta.
67 V, iv, 54 La sacrilega battuta di Proteo - negazione di ogni nobile ideale di amicizia - ha
precedenti in Euphues e in Endimion, e sarà riecheggiata da Claudio in Molto rumore per nulla