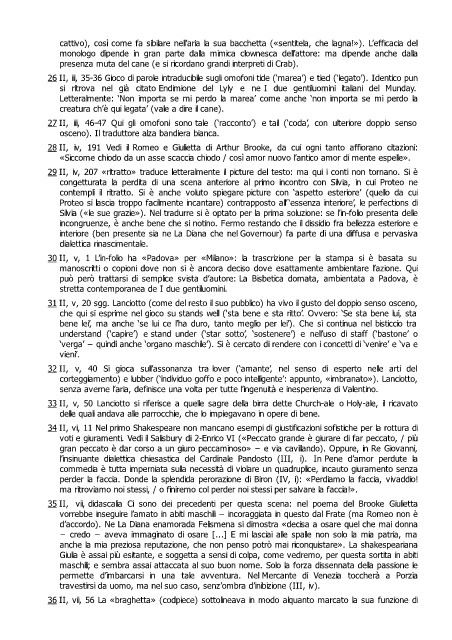Page 1987 - Shakespeare - Vol. 1
P. 1987
cattivo), così come fa sibilare nell’aria la sua bacchetta («sentitela, che lagna!»). L’efficacia del
monologo dipende in gran parte dalla mimica clownesca dell’attore: ma dipende anche dalla
presenza muta del cane (e si ricordano grandi interpreti di Crab).
26 II, iii, 35-36 Gioco di parole intraducibile sugli omofoni tide (‘marea’) e tied (‘legato’). Identico pun
si ritrova nel già citato Endimione del Lyly e ne I due gentiluomini italiani del Munday.
Letteralmente: ‘Non importa se mi perdo la marea’ come anche ‘non importa se mi perdo la
creatura ch’è qui legata’ (vale a dire il cane).
27 II, iii, 46-47 Qui gli omofoni sono tale (‘racconto’) e tail (‘coda’, con ulteriore doppio senso
osceno). Il traduttore alza bandiera bianca.
28 II, iv, 191 Vedi il Romeo e Giulietta di Arthur Brooke, da cui ogni tanto affiorano citazioni:
«Siccome chiodo da un asse scaccia chiodo / così amor nuovo l’antico amor di mente espelle».
29 II, iv, 207 «ritratto» traduce letteralmente il picture del testo: ma qui i conti non tornano. Si è
congetturata la perdita di una scena anteriore al primo incontro con Silvia, in cui Proteo ne
contempli il ritratto. Si è anche voluto spiegare picture con ‘aspetto esteriore’ (quello da cui
Proteo si lascia troppo facilmente incantare) contrapposto all’ ‘essenza interiore’, le perfections di
Silvia («le sue grazie»). Nel tradurre si è optato per la prima soluzione: se l’in-folio presenta delle
incongruenze, è anche bene che si notino. Fermo restando che il dissidio fra bellezza esteriore e
interiore (ben presente sia ne La Diana che nel Governour) fa parte di una diffusa e pervasiva
dialettica rinascimentale.
30 II, v, 1 L’in-folio ha «Padova» per «Milano»: la trascrizione per la stampa si è basata su
manoscritti o copioni dove non si è ancora deciso dove esattamente ambientare l’azione. Qui
può però trattarsi di semplice svista d’autore: La Bisbetica domata, ambientata a Padova, è
stretta contemporanea de I due gentiluomini.
31 II, v, 20 sgg. Lanciotto (come del resto il suo pubblico) ha vivo il gusto del doppio senso osceno,
che qui si esprime nel gioco su stands well (‘sta bene e sta ritto’. Ovvero: ‘Se sta bene lui, sta
bene lei’, ma anche ‘se lui ce l’ha duro, tanto meglio per lei’). Che si continua nel bisticcio tra
understand (‘capire’) e stand under (‘star sotto’, ‘sostenere’) e nell’uso di staff (‘bastone’ o
‘verga’ - quindi anche ‘organo maschile’). Si è cercato di rendere con i concetti di ‘venire’ e ‘va e
vieni’.
32 II, v, 40 Si gioca sull’assonanza tra lover (‘amante’, nel senso di esperto nelle arti del
corteggiamento) e lubber (‘individuo goffo e poco intelligente’: appunto, «imbranato»). Lanciotto,
senza averne l’aria, definisce una volta per tutte l’ingenuità e inesperienza di Valentino.
33 II, v, 50 Lanciotto si riferisce a quelle sagre della birra dette Church-ale o Holy-ale, il ricavato
delle quali andava alle parrocchie, che lo impiegavano in opere di bene.
34 II, vi, 11 Nel primo Shakespeare non mancano esempi di giustificazioni sofistiche per la rottura di
voti e giuramenti. Vedi il Salisbury di 2-Enrico VI («Peccato grande è giurare di far peccato, / più
gran peccato è dar corso a un giuro peccaminoso» - e via cavillando). Oppure, in Re Giovanni,
l’insinuante dialettica chiesastica del Cardinale Pandosto (III, i). In Pene d’amor perdute la
commedia è tutta imperniata sulla necessità di violare un quadruplice, incauto giuramento senza
perder la faccia. Donde la splendida perorazione di Biron (IV, i): «Perdiamo la faccia, vivaddio!
ma ritroviamo noi stessi, / o finiremo col perder noi stessi per salvare la faccia!».
35 II, vii, didascalia Ci sono dei precedenti per questa scena: nel poema del Brooke Giulietta
vorrebbe inseguire l’amato in abiti maschili - incoraggiata in questo dal Frate (ma Romeo non è
d’accordo). Ne La Diana enamorada Felismena si dimostra «decisa a osare quel che mai donna
- credo - aveva immaginato di osare [...] E mi lasciai alle spalle non solo la mia patria, ma
anche la mia preziosa reputazione, che non penso potrò mai riconquistare». La shakespeariana
Giulia è assai più esitante, e soggetta a sensi di colpa, come vedremo, per questa sortita in abiti
maschili; e sembra assai attaccata al suo buon nome. Solo la forza dissennata della passione le
permette d’imbarcarsi in una tale avventura. Nel Mercante di Venezia toccherà a Porzia
travestirsi da uomo, ma nel suo caso, senz’ombra d’inibizione (III, iv).
36 II, vii, 56 La «braghetta» (codpiece) sottolineava in modo alquanto marcato la sua funzione di