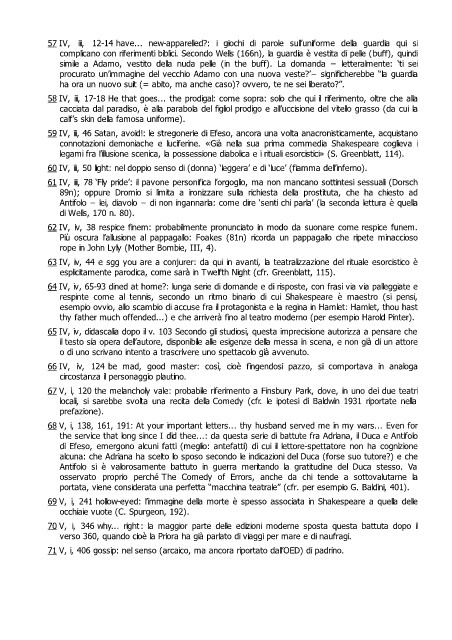Page 1739 - Shakespeare - Vol. 1
P. 1739
57 IV, iii, 12-14 have... new-apparelled?: i giochi di parole sull’uniforme della guardia qui si
complicano con riferimenti biblici. Secondo Wells (166n), la guardia è vestita di pelle (buff), quindi
simile a Adamo, vestito della nuda pelle (in the buff). La domanda - letteralmente: ‘ti sei
procurato un’immagine del vecchio Adamo con una nuova veste?’- significherebbe “la guardia
ha ora un nuovo suit (= abito, ma anche caso)? ovvero, te ne sei liberato?”.
58 IV, iii, 17-18 He that goes... the prodigal: come sopra: solo che qui il riferimento, oltre che alla
cacciata dal paradiso, è alla parabola del figliol prodigo e all’uccisione del vitello grasso (da cui la
calf’s skin della famosa uniforme).
59 IV, iii, 46 Satan, avoid!: le stregonerie di Efeso, ancora una volta anacronisticamente, acquistano
connotazioni demoniache e luciferine. «Già nella sua prima commedia Shakespeare coglieva i
legami fra l’illusione scenica, la possessione diabolica e i rituali esorcistici» (S. Greenblatt, 114).
60 IV, iii, 50 light: nel doppio senso di (donna) ‘leggera’ e di ‘luce’ (fiamma dell’inferno).
61 IV, iii, 78 ‘Fly pride’: il pavone personifica l’orgoglio, ma non mancano sottintesi sessuali (Dorsch
89n); oppure Dromio si limita a ironizzare sulla richiesta della prostituta, che ha chiesto ad
Antifolo - lei, diavolo - di non ingannarla: come dire ‘senti chi parla’ (la seconda lettura è quella
di Wells, 170 n. 80).
62 IV, iv, 38 respice finem: probabilmente pronunciato in modo da suonare come respice funem.
Più oscura l’allusione al pappagallo: Foakes (81n) ricorda un pappagallo che ripete minaccioso
rope in John Lyly (Mother Bombie, III, 4).
63 IV, iv, 44 e sgg you are a conjurer: da qui in avanti, la teatralizzazione del rituale esorcistico è
esplicitamente parodica, come sarà in Twelfth Night (cfr. Greenblatt, 115).
64 IV, iv, 65-93 dined at home?: lunga serie di domande e di risposte, con frasi via via palleggiate e
respinte come al tennis, secondo un ritmo binario di cui Shakespeare è maestro (si pensi,
esempio ovvio, allo scambio di accuse fra il protagonista e la regina in Hamlet: Hamlet, thou hast
thy father much offended...) e che arriverà fino al teatro moderno (per esempio Harold Pinter).
65 IV, iv, didascalia dopo il v. 103 Secondo gli studiosi, questa imprecisione autorizza a pensare che
il testo sia opera dell’autore, disponibile alle esigenze della messa in scena, e non già di un attore
o di uno scrivano intento a trascrivere uno spettacolo già avvenuto.
66 IV, iv, 124 be mad, good master: così, cioè fingendosi pazzo, si comportava in analoga
circostanza il personaggio plautino.
67 V, i, 120 the melancholy vale: probabile riferimento a Finsbury Park, dove, in uno dei due teatri
locali, si sarebbe svolta una recita della Comedy (cfr. le ipotesi di Baldwin 1931 riportate nella
prefazione).
68 V, i, 138, 161, 191: At your important letters... thy husband served me in my wars... Even for
the service that long since I did thee...: da questa serie di battute fra Adriana, il Duca e Antifolo
di Efeso, emergono alcuni fatti (meglio: antefatti) di cui il lettore-spettatore non ha cognizione
alcuna: che Adriana ha scelto lo sposo secondo le indicazioni del Duca (forse suo tutore?) e che
Antifolo si è valorosamente battuto in guerra meritando la gratitudine del Duca stesso. Va
osservato proprio perché The Comedy of Errors, anche da chi tende a sottovalutarne la
portata, viene considerata una perfetta “macchina teatrale” (cfr. per esempio G. Baldini, 401).
69 V, i, 241 hollow-eyed: l’immagine della morte è spesso associata in Shakespeare a quella delle
occhiaie vuote (C. Spurgeon, 192).
70 V, i, 346 why... right : la maggior parte delle edizioni moderne sposta questa battuta dopo il
verso 360, quando cioè la Priora ha già parlato di viaggi per mare e di naufragi.
71 V, i, 406 gossip: nel senso (arcaico, ma ancora riportato dall’OED) di padrino.