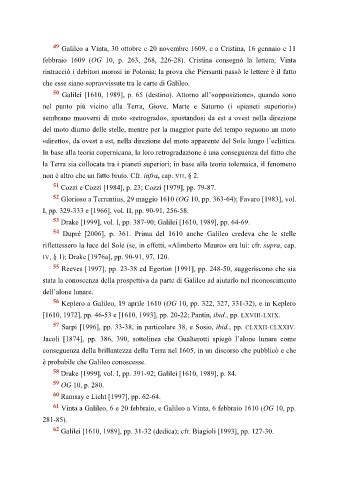Page 589 - Galileo. Scienziato e umanista.
P. 589
49 Galileo a Vinta, 30 ottobre e 20 novembre 1609, e a Cristina, 16 gennaio e 11
febbraio 1609 (OG 10, p. 263, 268, 226-28). Cristina consegnò la lettera; Vinta
rintracciò i debitori morosi in Polonia; la prova che Piersanti passò le lettere è il fatto
che esse siano sopravvissute tra le carte di Galileo.
50 Galilei [1610, 1989], p. 65 (destino). Attorno all’«opposizione», quando sono
nel punto piú vicino alla Terra, Giove, Marte e Saturno (i «pianeti superiori»)
sembrano muoversi di moto «retrogrado», spostandosi da est a ovest nella direzione
del moto diurno delle stelle, mentre per la maggior parte del tempo seguono un moto
«diretto», da ovest a est, nella direzione del moto apparente del Sole lungo l’eclittica.
In base alla teoria copernicana, la loro retrogradazione è una conseguenza del fatto che
la Terra sia collocata tra i pianeti superiori; in base alla teoria tolemaica, il fenomeno
non è altro che un fatto bruto. Cfr. infra, cap. VII, § 2.
51
Cozzi e Cozzi [1984], p. 23; Cozzi [1979], pp. 79-87.
52 Glorioso a Terrentius, 29 maggio 1610 (OG 10, pp. 363-64); Favaro [1983], vol.
I, pp. 329-333 e [1966], vol. II, pp. 90-91, 256-58.
53
Drake [1999], vol. I, pp. 387-90; Galilei [1610, 1989], pp. 64-69.
54
Dupré [2006], p. 361. Prima del 1610 anche Galileo credeva che le stelle
riflettessero la luce del Sole (se, in effetti, «Alimberto Mauro» era lui: cfr. supra, cap.
IV, § 1); Drake [1976a], pp. 90-91, 97, 120.
55 Reeves [1997], pp. 23-38 ed Egerton [1991], pp. 248-50, suggeriscono che sia
stata la conoscenza della prospettiva da parte di Galileo ad aiutarlo nel riconoscimento
dell’alone lunare.
56 Keplero a Galileo, 19 aprile 1610 (OG 10, pp. 322, 327, 331-32), e in Keplero
[1610, 1972], pp. 46-53 e [1610, 1993], pp. 20-22; Pantin, ibid., pp. LXVIII-LXIX.
57 Sarpi [1996], pp. 33-38, in particolare 38, e Sosio, ibid., pp. CLXXII-CLXXIV.
Jacoli [1874], pp. 386, 390, sottolinea che Gualterotti spiegò l’alone lunare come
conseguenza della brillantezza della Terra nel 1605, in un discorso che pubblicò e che
è probabile che Galileo conoscesse.
58
Drake [1999], vol. I, pp. 391-92; Galilei [1610, 1989], p. 84.
59 OG 10, p. 280.
60 Ramsay e Licht [1997], pp. 62-64.
61
Vinta a Galileo, 6 e 20 febbraio, e Galileo a Vinta, 6 febbraio 1610 (OG 10, pp.
281-85).
62 Galilei [1610, 1989], pp. 31-32 (dedica); cfr. Biagioli [1993], pp. 127-30.