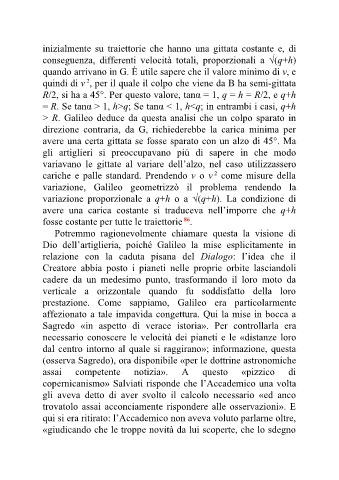Page 525 - Galileo. Scienziato e umanista.
P. 525
inizialmente su traiettorie che hanno una gittata costante e, di
conseguenza, differenti velocità totali, proporzionali a √(q+h)
quando arrivano in G. È utile sapere che il valore minimo di v, e
2
quindi di v , per il quale il colpo che viene da B ha semi-gittata
R/2, si ha a 45°. Per questo valore, tanα = 1, q = h = R/2, e q+h
= R. Se tanα > 1, h>q; Se tanα < 1, h<q; in entrambi i casi, q+h
> R. Galileo deduce da questa analisi che un colpo sparato in
direzione contraria, da G, richiederebbe la carica minima per
avere una certa gittata se fosse sparato con un alzo di 45°. Ma
gli artiglieri si preoccupavano piú di sapere in che modo
variavano le gittate al variare dell’alzo, nel caso utilizzassero
2
cariche e palle standard. Prendendo v o v come misure della
variazione, Galileo geometrizzò il problema rendendo la
variazione proporzionale a q+h o a √(q+h). La condizione di
avere una carica costante si traduceva nell’imporre che q+h
86
fosse costante per tutte le traiettorie .
Potremmo ragionevolmente chiamare questa la visione di
Dio dell’artiglieria, poiché Galileo la mise esplicitamente in
relazione con la caduta pisana del Dialogo: l’idea che il
Creatore abbia posto i pianeti nelle proprie orbite lasciandoli
cadere da un medesimo punto, trasformando il loro moto da
verticale a orizzontale quando fu soddisfatto della loro
prestazione. Come sappiamo, Galileo era particolarmente
affezionato a tale impavida congettura. Qui la mise in bocca a
Sagredo «in aspetto di verace istoria». Per controllarla era
necessario conoscere le velocità dei pianeti e le «distanze loro
dal centro intorno al quale si raggirano»; informazione, questa
(osserva Sagredo), ora disponibile «per le dottrine astronomiche
assai competente notizia». A questo «pizzico di
copernicanismo» Salviati risponde che l’Accademico una volta
gli aveva detto di aver svolto il calcolo necessario «ed anco
trovatolo assai acconciamente rispondere alle osservazioni». E
qui si era ritirato: l’Accademico non aveva voluto parlarne oltre,
«giudicando che le troppe novità da lui scoperte, che lo sdegno