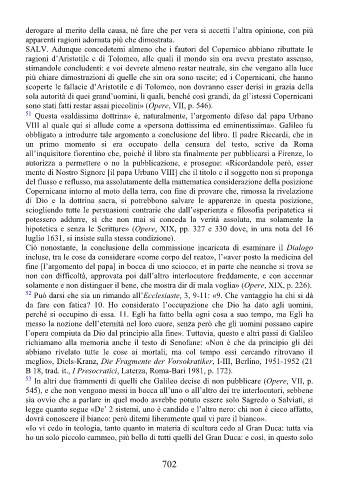Page 702 - Galileo Galilei - Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo
P. 702
derogare al merito della causa, né fare che per vera si accetti l’altra opinione, con più
apparenti ragioni adornata più che dimostrata.
SALV. Adunque concedetemi almeno che i fautori del Copernico abbiano ributtate le
ragioni d’Aristotile e di Tolomeo, alle quali il mondo sin ora aveva prestato assenso,
stimandole concludenti: e voi devrete almeno restar neutrale, sin che vengano alla luce
più chiare dimostrazioni di quelle che sin ora sono uscite; ed i Copernicani, che hanno
scoperte le fallacie d’Aristotile e di Tolomeo, non dovranno esser derisi in grazia della
sola autorità di quei grand’uomini, li quali, benché così grandi, da gl’istessi Copernicani
sono stati fatti restar assai piccolini» (Opere, VII, p. 546).
51
Questa «saldissima dottrina» è, naturalmente, l’argomento difeso dal papa Urbano
VIII al quale qui si allude come a «persona dottissima ed eminentissima». Galileo fu
obbligato a introdurre tale argomento a conclusione del libro. Il padre Riccardi, che in
un primo momento si era occupato della censura del testo, scrive da Roma
all’inquisitore fiorentino che, poiché il libro sta finalmente per pubblicarsi a Firenze, lo
autorizza a permettere o no la pubblicazione, e prosegue: «Ricordandole però, esser
mente di Nostro Signore [il papa Urbano VIII] che il titolo e il soggetto non si proponga
del flusso e reflusso, ma assolutamente della mattematica considerazione della posizione
Copernicana intorno al moto della terra, con fine di provare che, rimossa la rivelazione
di Dio e la dottrina sacra, si potrebbono salvare le apparenze in questa posizione,
sciogliendo tutte le persuasioni contrarie che dall’esperienza e filosofia peripatetica si
potessero addurre, sì che non mai si conceda la verità assoluta, ma solamente la
hipotetica e senza le Scritture» (Opere, XIX, pp. 327 e 330 dove, in una nota del 16
luglio 1631, si insiste sulla stessa condizione).
Ciò nonostante, la conclusione della commissione incaricata di esaminare il Dialogo
incluse, tra le cose da considerare «come corpo del reato», l’«aver posto la medicina del
fine [l’argomento del papa] in bocca di uno sciocco, et in parte che neanche si trova se
non con difficoltà, approvata poi dall’altro interlocutore freddamente, e con accennar
solamente e non distinguer il bene, che mostra dir di mala voglia» (Opere, XIX, p. 226).
52
Può darsi che sia un rimando all’Ecclesiaste, 3, 9-11: «9. Che vantaggio ha chi si dà
da fare con fatica? 10. Ho considerato l’occupazione che Dio ha dato agli uomini,
perché si occupino di essa. 11. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, ma Egli ha
messo la nozione dell’eternità nel loro cuore, senza però che gli uomini possano capire
l’opera compiuta da Dio dal principio alla fine». Tuttavia, questo e altri passi di Galileo
richiamano alla memoria anche il testo di Senofane: «Non è che da principio gli dèi
abbiano rivelato tutte le cose ai mortali, ma col tempo essi cercando ritrovano il
meglio», Diels-Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, I-III, Berlino, 1951-1952 (21
B 18, trad. it., I Presocratici, Laterza, Roma-Bari 1981, p. 172).
53
In altri due frammenti di quelli che Galileo decise di non pubblicare (Opere, VII, p.
545), e che non vengono messi in bocca all’uno o all’altro dei tre interlocutori, sebbene
sia ovvio che a parlare in quel modo avrebbe potuto essere solo Sagredo o Salviati, si
legge quanto segue «De’ 2 sistemi, uno è candido e l’altro nero: chi non è cieco affatto,
dovrà conoscere il bianco: però ditemi liberamente qual vi pare il bianco».
«Io vi cedo in teologia, tanto quanto in materia di scultura cedo al Gran Duca: tutta via
ho un solo piccolo cammeo, più bello di tutti quelli del Gran Duca: e così, in questo solo
702