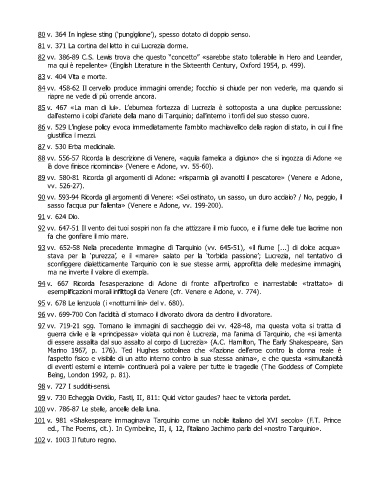Page 2341 - Shakespeare - Vol. 4
P. 2341
80 v. 364 In inglese sting (‘pungiglione’), spesso dotato di doppio senso.
81 v. 371 La cortina del letto in cui Lucrezia dorme.
82 vv. 386-89 C.S. Lewis trova che questo “concetto” «sarebbe stato tollerabile in Hero and Leander,
ma qui è repellente» (English Literature in the Sixteenth Century, Oxford 1954, p. 499).
83 v. 404 Vita e morte.
84 vv. 458-62 Il cervello produce immagini orrende; l’occhio si chiude per non vederle, ma quando si
riapre ne vede di più orrende ancora.
85 v. 467 «La man di lui». L’eburnea fortezza di Lucrezia è sottoposta a una duplice percussione:
dall’esterno i colpi d’ariete della mano di Tarquinio; dall’interno i tonfi del suo stesso cuore.
86 v. 529 L’inglese policy evoca immediatamente l’ambito machiavellico della ragion di stato, in cui il fine
giustifica i mezzi.
87 v. 530 Erba medicinale.
88 vv. 556-57 Ricorda la descrizione di Venere, «aquila famelica a digiuno» che si ingozza di Adone «e
là dove finisce ricomincia» (Venere e Adone, vv. 55-60).
89 vv. 580-81 Ricorda gli argomenti di Adone: «risparmia gli avanotti il pescatore» (Venere e Adone,
vv. 526-27).
90 vv. 593-94 Ricorda gli argomenti di Venere: «Sei ostinato, un sasso, un duro acciaio? / No, peggio, il
sasso l’acqua pur l’allenta» (Venere e Adone, vv. 199-200).
91 v. 624 Dio.
92 vv. 647-51 Il vento dei tuoi sospiri non fa che attizzare il mio fuoco, e il fiume delle tue lacrime non
fa che gonfiare il mio mare.
93 vv. 652-58 Nella precedente immagine di Tarquinio (vv. 645-51), «il fiume [...] di dolce acqua»
stava per la ‘purezza’, e il «mare» salato per la ‘torbida passione’; Lucrezia, nel tentativo di
sconfiggere dialetticamente Tarquinio con le sue stesse armi, approfitta delle medesime immagini,
ma ne inverte il valore di exempla.
94 v. 667 Ricorda l’esasperazione di Adone di fronte all’ipertrofico e inarrestabile «trattato» di
esemplificazioni morali inflittogli da Venere (cfr. Venere e Adone, v. 774).
95 v. 678 Le lenzuola (i «notturni lini» del v. 680).
96 vv. 699-700 Con l’acidità di stomaco il divorato divora da dentro il divoratore.
97 vv. 719-21 sgg. Tornano le immagini di saccheggio dei vv. 428-48, ma questa volta si tratta di
guerra civile e la «principessa» violata qui non è Lucrezia, ma l’anima di Tarquinio, che «si lamenta
di essere assalita dal suo assalto al corpo di Lucrezia» (A.C. Hamilton, The Early Shakespeare, San
Marino 1967, p. 176). Ted Hughes sottolinea che «l’azione dell’eroe contro la donna reale è
l’aspetto fisico e visibile di un atto interno contro la sua stessa anima», e che questa «simultaneità
di eventi esterni e interni» continuerà poi a valere per tutte le tragedie (The Goddess of Complete
Being, London 1992, p. 81).
98 v. 727 I sudditi-sensi.
99 v. 730 Echeggia Ovidio, Fasti, II, 811: Quid victor gaudes? haec te victoria perdet.
100 vv. 786-87 Le stelle, ancelle della luna.
101 v. 981 «Shakespeare immaginava Tarquinio come un nobile italiano del XVI secolo» (F.T. Prince
ed., The Poems, cit.). In Cymbeline, II, ii, 12, l’italiano Jachimo parla del «nostro Tarquinio».
102 v. 1003 Il futuro regno.