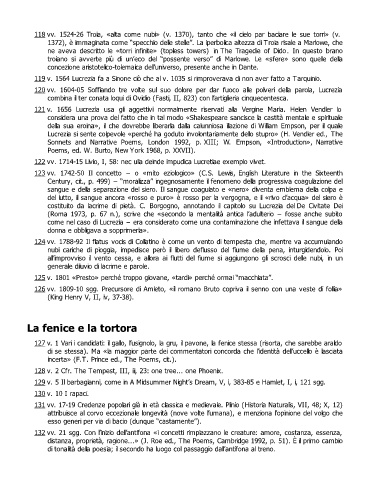Page 2343 - Shakespeare - Vol. 4
P. 2343
118 vv. 1524-26 Troia, «alta come nubi» (v. 1370), tanto che «il cielo par baciare le sue torri» (v.
1372), è immaginata come “specchio delle stelle”. La iperbolica altezza di Troia risale a Marlowe, che
ne aveva descritto le «torri infinite» (topless towers) in The Tragedie of Dido. In questo brano
troiano si avverte più di un’eco del “possente verso” di Marlowe. Le «sfere» sono quelle della
concezione aristotelico-tolemaica dell’universo, presente anche in Dante.
119 v. 1564 Lucrezia fa a Sinone ciò che al v. 1035 si rimproverava di non aver fatto a Tarquinio.
120 vv. 1604-05 Soffiando tre volte sul suo dolore per dar fuoco alle polveri della parola, Lucrezia
combina il ter conata loqui di Ovidio (Fasti, II, 823) con l’artiglieria cinquecentesca.
121 v. 1656 Lucrezia usa gli aggettivi normalmente riservati alla Vergine Maria. Helen Vendler lo
considera una prova del fatto che in tal modo «Shakespeare sancisce la castità mentale e spirituale
della sua eroina», il che dovrebbe liberarla dalla calunniosa illazione di William Empson, per il quale
Lucrezia si sente colpevole «perché ha goduto involontariamente dello stupro» (H. Vendler ed., The
Sonnets and Narrative Poems, London 1992, p. XIII; W. Empson, «Introduction», Narrative
Poems, ed. W. Burto, New York 1968, p. XXVII).
122 vv. 1714-15 Livio, I, 58: nec ulla deinde impudica Lucretiae exemplo vivet.
123 vv. 1742-50 Il concetto − o «mito eziologico» (C.S. Lewis, English Literature in the Sixteenth
Century, cit., p. 499) − “moralizza” ingegnosamente il fenomeno della progressiva coagulazione del
sangue e della separazione del siero. Il sangue coagulato e «nero» diventa emblema della colpa e
del lutto, il sangue ancora «rosso e puro» è rosso per la vergogna, e il «rivo d’acqua» del siero è
costituito da lacrime di pietà. C. Borgogno, annotando il capitolo su Lucrezia del De Civitate Dei
(Roma 1973, p. 67 n.), scrive che «secondo la mentalità antica l’adulterio − fosse anche subito
come nel caso di Lucrezia − era considerato come una contaminazione che infettava il sangue della
donna e obbligava a sopprimerla».
124 vv. 1788-92 Il flatus vocis di Collatino è come un vento di tempesta che, mentre va accumulando
nubi cariche di pioggia, impedisce però il libero deflusso del fiume della pena, inturgidendolo. Poi
all’improvviso il vento cessa, e allora ai flutti del fiume si aggiungono gli scrosci delle nubi, in un
generale diluvio di lacrime e parole.
125 v. 1801 «Presto» perché troppo giovane, «tardi» perché ormai “macchiata”.
126 vv. 1809-10 sgg. Precursore di Amleto, «il romano Bruto copriva il senno con una veste di follia»
(King Henry V, II, iv, 37-38).
La fenice e la tortora
127 v. 1 Vari i candidati: il gallo, l’usignolo, la gru, il pavone, la fenice stessa (risorta, che sarebbe araldo
di se stessa). Ma «la maggior parte dei commentatori concorda che l’identità dell’uccello è lasciata
incerta» (F.T. Prince ed., The Poems, cit.).
128 v. 2 Cfr. The Tempest, III, iii, 23: one tree... one Phoenix.
129 v. 5 Il barbagianni, come in A Midsummer Night’s Dream, V, i, 383-85 e Hamlet, I, i, 121 sgg.
130 v. 10 I rapaci.
131 vv. 17-19 Credenze popolari già in età classica e medievale. Plinio (Historia Naturalis, VII, 48; X, 12)
attribuisce al corvo eccezionale longevità (nove volte l’umana), e menziona l’opinione del volgo che
esso generi per via di bacio (dunque “castamente”).
132 vv. 21 sgg. Con l’inizio dell’antifona «i concetti rimpiazzano le creature: amore, costanza, essenza,
distanza, proprietà, ragione...» (J. Roe ed., The Poems, Cambridge 1992, p. 51). È il primo cambio
di tonalità della poesia; il secondo ha luogo col passaggio dall’antifona al treno.