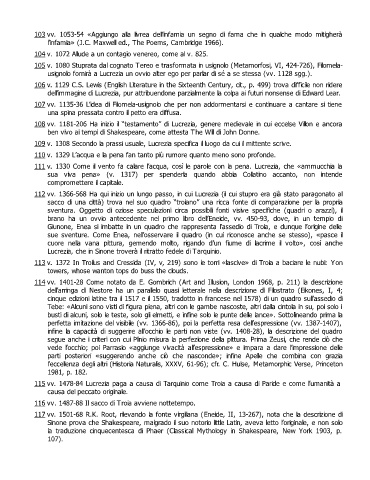Page 2342 - Shakespeare - Vol. 4
P. 2342
103 vv. 1053-54 «Aggiungo alla livrea dell’infamia un segno di fama che in qualche modo mitigherà
l’infamia» (J.C. Maxwell ed., The Poems, Cambridge 1966).
104 v. 1072 Allude a un contagio venereo, come al v. 825.
105 v. 1080 Stuprata dal cognato Tereo e trasformata in usignolo (Metamorfosi, VI, 424-726), Filomela-
usignolo fornirà a Lucrezia un ovvio alter ego per parlar di sé a se stessa (vv. 1128 sgg.).
106 v. 1129 C.S. Lewis (English Literature in the Sixteenth Century, cit., p. 499) trova difficile non ridere
dell’immagine di Lucrezia, pur attribuendone parzialmente la colpa ai futuri nonsense di Edward Lear.
107 vv. 1135-36 L’idea di Filomela-usignolo che per non addormentarsi e continuare a cantare si tiene
una spina pressata contro il petto era diffusa.
108 vv. 1181-206 Ha inizio il “testamento” di Lucrezia, genere medievale in cui eccelse Villon e ancora
ben vivo ai tempi di Shakespeare, come attesta The Will di John Donne.
109 v. 1308 Secondo la prassi usuale, Lucrezia specifica il luogo da cui il mittente scrive.
110 v. 1329 L’acqua e la pena fan tanto più rumore quanto meno sono profonde.
111 v. 1330 Come il vento fa calare l’acqua, così le parole con la pena. Lucrezia, che «ammucchia la
sua viva pena» (v. 1317) per spenderla quando abbia Collatino accanto, non intende
compromettere il capitale.
112 vv. 1366-568 Ha qui inizio un lungo passo, in cui Lucrezia (il cui stupro era già stato paragonato al
sacco di una città) trova nel suo quadro “troiano” una ricca fonte di comparazione per la propria
sventura. Oggetto di oziose speculazioni circa possibili fonti visive specifiche (quadri o arazzi), il
brano ha un ovvio antecedente nel primo libro dell’Eneide, vv. 450-93, dove, in un tempio di
Giunone, Enea si imbatte in un quadro che rappresenta l’assedio di Troia, e dunque l’origine delle
sue sventure. Come Enea, nell’osservare il quadro (in cui riconosce anche se stesso), «pasce il
cuore nella vana pittura, gemendo molto, rigando d’un fiume di lacrime il volto», così anche
Lucrezia, che in Sinone troverà il ritratto fedele di Tarquinio.
113 v. 1372 In Troilus and Cressida (IV, v, 219) sono le torri «lascive» di Troia a baciare le nubi: Yon
towers, whose wanton tops do buss the clouds.
114 vv. 1401-28 Come notato da E. Gombrich (Art and Illusion, London 1968, p. 211) la descrizione
dell’arringa di Nestore ha un parallelo quasi letterale nella descrizione di Filostrato (Eikones, I, 4;
cinque edizioni latine tra il 1517 e il 1550, tradotto in francese nel 1578) di un quadro sull’assedio di
Tebe: «Alcuni sono visti di figura piena, altri con le gambe nascoste, altri dalla cintola in su, poi solo i
busti di alcuni, solo le teste, solo gli elmetti, e infine solo le punte delle lance». Sottolineando prima la
perfetta imitazione del visibile (vv. 1366-86), poi la perfetta resa dell’espressione (vv. 1387-1407),
infine la capacità di suggerire all’occhio le parti non viste (vv. 1408-28), la descrizione del quadro
segue anche i criteri con cui Plinio misura la perfezione della pittura. Prima Zeusi, che rende ciò che
vede l’occhio; poi Parrasio «aggiunge vivacità all’espressione» e impara a dare l’impressione delle
parti posteriori «suggerendo anche ciò che nasconde»; infine Apelle che combina con grazia
l’eccellenza degli altri (Historia Naturalis, XXXV, 61-96); cfr. C. Hulse, Metamorphic Verse, Princeton
1981, p. 182.
115 vv. 1478-84 Lucrezia paga a causa di Tarquinio come Troia a causa di Paride e come l’umanità a
causa del peccato originale.
116 vv. 1487-88 Il sacco di Troia avviene nottetempo.
117 vv. 1501-68 R.K. Root, rilevando la fonte virgiliana (Eneide, II, 13-267), nota che la descrizione di
Sinone prova che Shakespeare, malgrado il suo notorio little Latin, aveva letto l’originale, e non solo
la traduzione cinquecentesca di Phaer (Classical Mythology in Shakespeare, New York 1903, p.
107).