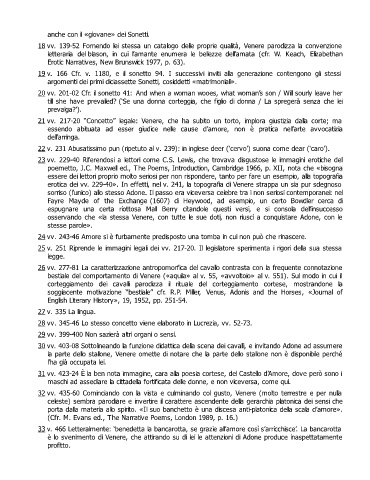Page 2337 - Shakespeare - Vol. 4
P. 2337
anche con il «giovane» dei Sonetti.
18 vv. 139-52 Fornendo lei stessa un catalogo delle proprie qualità, Venere parodizza la convenzione
letteraria del blason, in cui l’amante enumera le bellezze dell’amata (cfr. W. Keach, Elizabethan
Erotic Narratives, New Brunswick 1977, p. 63).
19 v. 166 Cfr. v. 1180, e il sonetto 94. I successivi inviti alla generazione contengono gli stessi
argomenti dei primi diciassette Sonetti, cosiddetti «matrimoniali».
20 vv. 201-02 Cfr. il sonetto 41: And when a woman wooes, what woman’s son / Will sourly leave her
till she have prevailed? (‘Se una donna corteggia, che figlio di donna / La spregerà senza che lei
prevalga?’).
21 vv. 217-20 “Concetto” legale: Venere, che ha subito un torto, implora giustizia dalla corte; ma
essendo abituata ad esser giudice nelle cause d’amore, non è pratica nell’arte avvocatizia
dell’arringa.
22 v. 231 Abusatissimo pun (ripetuto al v. 239): in inglese deer (‘cervo’) suona come dear (‘caro’).
23 vv. 229-40 Riferendosi a lettori come C.S. Lewis, che trovava disgustose le immagini erotiche del
poemetto, J.C. Maxwell ed., The Poems, Introduction, Cambridge 1966, p. XII, nota che «bisogna
essere dei lettori proprio molto seriosi per non rispondere, tanto per fare un esempio, alla topografia
erotica dei vv. 229-40». In effetti, nel v. 241, la topografia di Venere strappa un sia pur sdegnoso
sorriso (l’unico) allo stesso Adone. Il passo era viceversa celebre tra i non seriosi contemporanei: nel
Fayre Mayde of the Exchange (1607) di Heywood, ad esempio, un certo Bowdler cerca di
espugnare una certa riottosa Mall Berry citandole questi versi, e si consola dell’insuccesso
osservando che «la stessa Venere, con tutte le sue doti, non riuscì a conquistare Adone, con le
stesse parole».
24 vv. 243-46 Amore si è furbamente predisposto una tomba in cui non può che rinascere.
25 v. 251 Riprende le immagini legali dei vv. 217-20. Il legislatore sperimenta i rigori della sua stessa
legge.
26 vv. 277-81 La caratterizzazione antropomorfica del cavallo contrasta con la frequente connotazione
bestiale del comportamento di Venere («aquila» al v. 55, «avvoltoio» al v. 551). Sul modo in cui il
corteggiamento dei cavalli parodizza il rituale del corteggiamento cortese, mostrandone la
soggiacente motivazione “bestiale” cfr. R.P. Miller, Venus, Adonis and the Horses, «Journal of
English Literary History», 19, 1952, pp. 251-54.
27 v. 335 La lingua.
28 vv. 345-46 Lo stesso concetto viene elaborato in Lucrezia, vv. 52-73.
29 vv. 399-400 Non sazierà altri organi o sensi.
30 vv. 403-08 Sottolineando la funzione didattica della scena dei cavalli, e invitando Adone ad assumere
la parte dello stallone, Venere omette di notare che la parte dello stallone non è disponibile perché
l’ha già occupata lei.
31 vv. 423-24 È la ben nota immagine, cara alla poesia cortese, del Castello d’Amore, dove però sono i
maschi ad assediare la cittadella fortificata delle donne, e non viceversa, come qui.
32 vv. 435-60 Cominciando con la vista e culminando col gusto, Venere (molto terrestre e per nulla
celeste) sembra parodiare e invertire il carattere ascendente della gerarchia platonica dei sensi che
porta dalla materia allo spirito. «Il suo banchetto è una discesa anti-platonica della scala d’amore».
(Cfr. M. Evans ed., The Narrative Poems, London 1989, p. 16.)
33 v. 466 Letteralmente: ‘benedetta la bancarotta, se grazie all’amore così s’arricchisce’. La bancarotta
è lo svenimento di Venere, che attirando su di lei le attenzioni di Adone produce inaspettatamente
profitto.