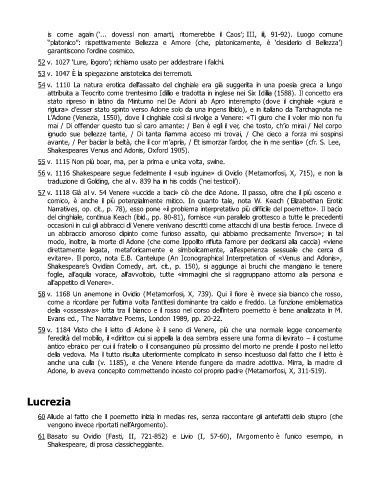Page 2339 - Shakespeare - Vol. 4
P. 2339
is come again (‘... dovessi non amarti, ritornerebbe il Caos’; III, iii, 91-92). Luogo comune
“platonico”: rispettivamente Bellezza e Amore (che, platonicamente, è ‘desiderio di Bellezza’)
garantiscono l’ordine cosmico.
52 v. 1027 ‘Lure, lògoro’; richiamo usato per addestrare i falchi.
53 v. 1047 È la spiegazione aristotelica dei terremoti.
54 v. 1110 La natura erotica dell’assalto del cinghiale era già suggerita in una poesia greca a lungo
attribuita a Teocrito come trentesimo Idillio e tradotta in inglese nei Six Idillia (1588). Il concetto era
stato ripreso in latino da Minturno nel De Adoni ab Apro interempto (dove il cinghiale «giura e
rigiura» d’esser stato spinto verso Adone solo da una ingens libido), e in italiano da Tarchagnota ne
L’Adone (Venezia, 1550), dove il cinghiale così si rivolge a Venere: «Ti giuro che il voler mio non fu
mai / Di offender questo tuo sì caro amante: / Ben è egli il ver, che tosto, ch’io mirai / Nel corpo
ignudo sue bellezze tante, / Di tanta fiamma acceso mi trovai, / Che cieco a forza mi sospinsi
avante, / Per baciar la beltà, che il cor m’apria, / Et ismorzar l’ardor, che in me sentia» (cfr. S. Lee,
Shakespeares Venus and Adonis, Oxford 1905).
55 v. 1115 Non più boar, ma, per la prima e unica volta, swine.
56 v. 1116 Shakespeare segue fedelmente il «sub inguine» di Ovidio (Metamorfosi, X, 715), e non la
traduzione di Golding, che al v. 839 ha in his codds (‘nei testicoli’).
57 v. 1118 Già al v. 54 Venere «uccide a baci» ciò che dice Adone. Il passo, oltre che il più osceno e
comico, è anche il più potenzialmente mitico. In quanto tale, nota W. Keach ( Elizabethan Erotic
Narratives, op. cit., p. 78), esso pone «il problema interpretativo più difficile del poemetto». Il bacio
del cinghiale, continua Keach (ibid., pp. 80-81), fornisce «un parallelo grottesco a tutte le precedenti
occasioni in cui gli abbracci di Venere venivano descritti come attacchi di una bestia feroce. Invece di
un abbraccio amoroso dipinto come furioso assalto, qui abbiamo precisamente l’inverso»; in tal
modo, inoltre, la morte di Adone (che come Ippolito rifiuta l’amore per dedicarsi alla caccia) «viene
direttamente legata, metaforicamente e simbolicamente, all’esperienza sessuale che cerca di
evitare». Il porco, nota E.B. Cantelupe (An Iconographical Interpretation of «Venus and Adonis»,
Shakespeare’s Ovidian Comedy, art. cit., p. 150), si aggiunge ai bruchi che mangiano le tenere
foglie, all’aquila vorace, all’avvoltoio, tutte «immagini che si raggruppano attorno alla persona e
all’appetito di Venere».
58 v. 1168 Un anemone in Ovidio (Metamorfosi, X, 739). Qui il fiore è invece sia bianco che rosso,
come a ricordare per l’ultima volta l’antitesi dominante tra caldo e freddo. La funzione emblematica
della «ossessiva» lotta tra il bianco e il rosso nel corso dell’intero poemetto è bene analizzata in M.
Evans ed., The Narrative Poems, London 1989, pp. 20-22.
59 v. 1184 Visto che il letto di Adone è il seno di Venere, più che una normale legge concernente
l’eredità del mobilio, il «diritto» cui si appella la dea sembra essere una forma di levirato − il costume
antico ebraico per cui il fratello o il consanguineo più prossimo del morto ne prende il posto nel letto
della vedova. Ma il tutto risulta ulteriormente complicato in senso incestuoso dal fatto che il letto è
anche una culla (v. 1185), e che Venere intende fungere da madre adottiva. Mirra, la madre di
Adone, lo aveva concepito commettendo incesto col proprio padre (Metamorfosi, X, 311-519).
Lucrezia
60 Allude al fatto che il poemetto inizia in medias res, senza raccontare gli antefatti dello stupro (che
vengono invece riportati nell’Argomento).
61 Basato su Ovidio (Fasti, II, 721-852) e Livio (I, 57-60), l’Argomento è l’unico esempio, in
Shakespeare, di prosa classicheggiante.