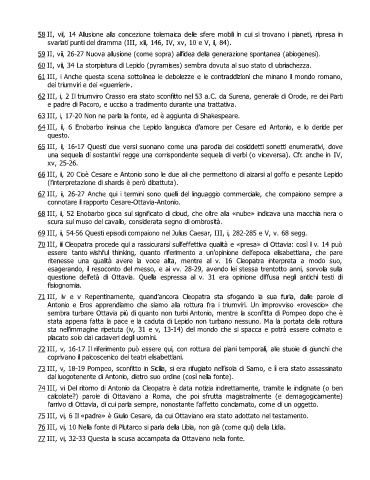Page 2573 - Shakespeare - Vol. 3
P. 2573
58 II, vii, 14 Allusione alla concezione tolemaica delle sfere mobili in cui si trovano i pianeti, ripresa in
svariati punti del dramma (III, xiii, 146, IV, xv, 10 e V, ii, 84).
59 II, vii, 26-27 Nuova allusione (come sopra) all’idea della generazione spontanea (abiogenesi).
60 II, vii, 34 La storpiatura di Lepido (pyramises) sembra dovuta al suo stato di ubriachezza.
61 III, i Anche questa scena sottolinea le debolezze e le contraddizioni che minano il mondo romano,
dei triumviri e dei «guerrieri».
62 III, i, 2 Il triumviro Crasso era stato sconfitto nel 53 a.C. da Surena, generale di Orode, re dei Parti
e padre di Pacoro, e ucciso a tradimento durante una trattativa.
63 III, i, 17-20 Non ne parla la fonte, ed è aggiunta di Shakespeare.
64 III, ii, 6 Enobarbo insinua che Lepido languisca d’amore per Cesare ed Antonio, e lo deride per
questo.
65 III, ii, 16-17 Questi due versi suonano come una parodia dei cosiddetti sonetti enumerativi, dove
una sequela di sostantivi regge una corrispondente sequela di verbi (o viceversa). Cfr. anche in IV,
xv, 25-26.
66 III, ii, 20 Cioè Cesare e Antonio sono le due ali che permettono di alzarsi al goffo e pesante Lepido
(l’interpretazione di shards è però dibattuta).
67 III, ii, 26-27 Anche qui i termini sono quelli del linguaggio commerciale, che compaiono sempre a
connotare il rapporto Cesare-Ottavia-Antonio.
68 III, ii, 52 Enobarbo gioca sul significato di cloud, che oltre alla «nube» indicava una macchia nera o
scura sul muso del cavallo, considerata segno di ombrosità.
69 III, ii, 54-56 Questi episodi compaiono nel Julius Caesar, III, i, 282-285 e V, v. 68 segg.
70 III, iii Cleopatra procede qui a rassicurarsi sull’effettiva qualità e «presa» di Ottavia: così il v. 14 può
essere tanto wishful thinking, quanto riferimento a un’opinione dell’epoca elisabettiana, che pare
ritenesse una qualità avere la voce alta, mentre al v. 16 Cleopatra interpreta a modo suo,
esagerando, il resoconto del messo, e ai vv. 28-29, avendo lei stessa trentotto anni, sorvola sulla
questione dell’età di Ottavia. Quella espressa al v. 31 era opinione diffusa negli antichi testi di
fisiognomia.
71 III, iv e v Repentinamente, quand’ancora Cleopatra sta sfogando la sua furia, dalle parole di
Antonio e Eros apprendiamo che siamo alla rottura fra i triumviri. Un improvviso «rovescio» che
sembra turbare Ottavia più di quanto non turbi Antonio, mentre la sconfitta di Pompeo dopo che è
stata appena fatta la pace e la caduta di Lepido non turbano nessuno. Ma la portata della rottura
sta nell’immagine ripetuta (iv, 31 e v, 13-14) del mondo che si spacca e potrà essere colmato e
placato solo dai cadaveri degli uomini.
72 III, v, 16-17 Il riferimento può essere qui, con rottura dei piani temporali, alle stuoie di giunchi che
coprivano il palcoscenico dei teatri elisabettiani.
73 III, v, 18-19 Pompeo, sconfitto in Sicilia, si era rifugiato nell’isola di Samo, e lì era stato assassinato
dal luogotenente di Antonio, dietro suo ordine (così nella fonte).
74 III, vi Del ritorno di Antonio da Cleopatra è data notizia indirettamente, tramite le indignate (o ben
calcolate?) parole di Ottaviano a Roma, che poi sfrutta magistralmente (e demagogicamente)
l’arrivo di Ottavia, di cui parla sempre, nonostante l’affetto conclamato, come di un oggetto.
75 III, vi, 6 Il «padre» è Giulio Cesare, da cui Ottaviano era stato adottato nel testamento.
76 III, vi, 10 Nella fonte di Plutarco si parla della Libia, non già (come qui) della Lidia.
77 III, vi, 32-33 Questa la scusa accampata da Ottaviano nella fonte.