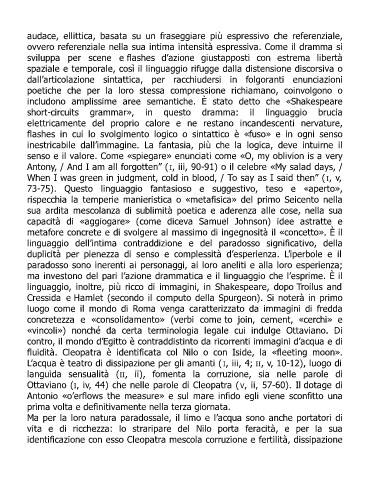Page 2198 - Shakespeare - Vol. 3
P. 2198
audace, ellittica, basata su un fraseggiare più espressivo che referenziale,
ovvero referenziale nella sua intima intensità espressiva. Come il dramma si
sviluppa per scene e flashes d’azione giustapposti con estrema libertà
spaziale e temporale, così il linguaggio rifugge dalla distensione discorsiva o
dall’articolazione sintattica, per racchiudersi in folgoranti enunciazioni
poetiche che per la loro stessa compressione richiamano, coinvolgono o
includono amplissime aree semantiche. È stato detto che «Shakespeare
short-circuits grammar», in questo dramma: il linguaggio brucia
elettricamente del proprio calore e ne restano incandescenti nervature,
flashes in cui lo svolgimento logico o sintattico è «fuso» e in ogni senso
inestricabile dall’immagine. La fantasia, più che la logica, deve intuirne il
senso e il valore. Come «spiegare» enunciati come «O, my oblivion is a very
Antony, / And I am all forgotten” ( I, iii, 90-91) o il celebre «My salad days, /
When I was green in judgment, cold in blood, / To say as I said then” ( I, v,
73-75). Questo linguaggio fantasioso e suggestivo, teso e «aperto»,
rispecchia la temperie manieristica o «metafisica» del primo Seicento nella
sua ardita mescolanza di sublimità poetica e aderenza alle cose, nella sua
capacità di «aggiogare» (come diceva Samuel Johnson) idee astratte e
metafore concrete e di svolgere al massimo di ingegnosità il «concetto». È il
linguaggio dell’intima contraddizione e del paradosso significativo, della
duplicità per pienezza di senso e complessità d’esperienza. L’iperbole e il
paradosso sono inerenti ai personaggi, ai loro aneliti e alla loro esperienza;
ma investono del pari l’azione drammatica e il linguaggio che l’esprime. È il
linguaggio, inoltre, più ricco di immagini, in Shakespeare, dopo Troilus and
Cressida e Hamlet (secondo il computo della Spurgeon). Si noterà in primo
luogo come il mondo di Roma venga caratterizzato da immagini di fredda
concretezza e «consolidamento» (verbi come to join, cement, «cerchi» e
«vincoli») nonché da certa terminologia legale cui indulge Ottaviano. Di
contro, il mondo d’Egitto è contraddistinto da ricorrenti immagini d’acqua e di
fluidità. Cleopatra è identificata col Nilo o con Iside, la «fleeting moon».
L’acqua è teatro di dissipazione per gli amanti ( I, iii, 4; II, v, 10-12), luogo di
languida sensualità (II, ii), fomenta la corruzione, sia nelle parole di
Ottaviano (I, iv, 44) che nelle parole di Cleopatra ( V, ii, 57-60). Il dotage di
Antonio «o’erflows the measure» e sul mare infido egli viene sconfitto una
prima volta e definitivamente nella terza giornata.
Ma per la loro natura paradossale, il limo e l’acqua sono anche portatori di
vita e di ricchezza: lo straripare del Nilo porta feracità, e per la sua
identificazione con esso Cleopatra mescola corruzione e fertilità, dissipazione