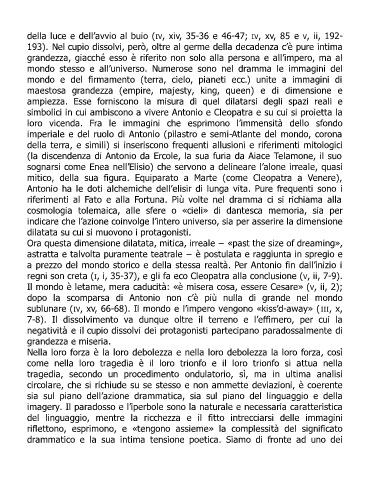Page 2200 - Shakespeare - Vol. 3
P. 2200
della luce e dell’avvio al buio (IV, xiv, 35-36 e 46-47; IV, xv, 85 e V, ii, 192-
193). Nel cupio dissolvi, però, oltre al germe della decadenza c’è pure intima
grandezza, giacché esso è riferito non solo alla persona e all’impero, ma al
mondo stesso e all’universo. Numerose sono nel dramma le immagini del
mondo e del firmamento (terra, cielo, pianeti ecc.) unite a immagini di
maestosa grandezza (empire, majesty, king, queen) e di dimensione e
ampiezza. Esse forniscono la misura di quel dilatarsi degli spazi reali e
simbolici in cui ambiscono a vivere Antonio e Cleopatra e su cui si proietta la
loro vicenda. Fra le immagini che esprimono l’immensità dello sfondo
imperiale e del ruolo di Antonio (pilastro e semi-Atlante del mondo, corona
della terra, e simili) si inseriscono frequenti allusioni e riferimenti mitologici
(la discendenza di Antonio da Ercole, la sua furia da Aiace Telamone, il suo
sognarsi come Enea nell’Elisio) che servono a delineare l’alone irreale, quasi
mitico, della sua figura. Equiparato a Marte (come Cleopatra a Venere),
Antonio ha le doti alchemiche dell’elisir di lunga vita. Pure frequenti sono i
riferimenti al Fato e alla Fortuna. Più volte nel dramma ci si richiama alla
cosmologia tolemaica, alle sfere o «cieli» di dantesca memoria, sia per
indicare che l’azione coinvolge l’intero universo, sia per asserire la dimensione
dilatata su cui si muovono i protagonisti.
Ora questa dimensione dilatata, mitica, irreale − «past the size of dreaming»,
astratta e talvolta puramente teatrale − è postulata e raggiunta in spregio e
a prezzo del mondo storico e della stessa realtà. Per Antonio fin dall’inizio i
regni son creta (I, i, 35-37), e gli fa eco Cleopatra alla conclusione (V, ii, 7-9).
Il mondo è letame, mera caducità: «è misera cosa, essere Cesare» (V, ii, 2);
dopo la scomparsa di Antonio non c’è più nulla di grande nel mondo
sublunare (IV, xv, 66-68). Il mondo e l’impero vengono «kiss’d-away» ( III, x,
7-8). Il dissolvimento va dunque oltre il terreno e l’effimero, per cui la
negatività e il cupio dissolvi dei protagonisti partecipano paradossalmente di
grandezza e miseria.
Nella loro forza è la loro debolezza e nella loro debolezza la loro forza, così
come nella loro tragedia è il loro trionfo e il loro trionfo si attua nella
tragedia, secondo un procedimento ondulatorio, sì, ma in ultima analisi
circolare, che si richiude su se stesso e non ammette deviazioni, è coerente
sia sul piano dell’azione drammatica, sia sul piano del linguaggio e della
imagery. Il paradosso e l’iperbole sono la naturale e necessaria caratteristica
del linguaggio, mentre la ricchezza e il fitto intrecciarsi delle immagini
riflettono, esprimono, e «tengono assieme» la complessità del significato
drammatico e la sua intima tensione poetica. Siamo di fronte ad uno dei