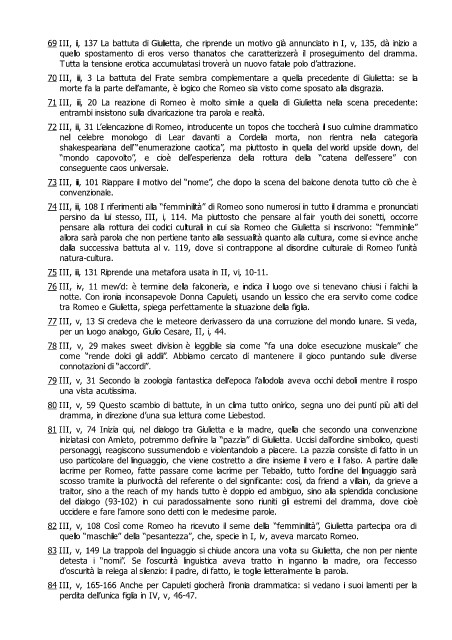Page 3262 - Shakespeare - Vol. 1
P. 3262
69 III, ii, 137 La battuta di Giulietta, che riprende un motivo già annunciato in I, v, 135, dà inizio a
quello spostamento di eros verso thanatos che caratterizzerà il proseguimento del dramma.
Tutta la tensione erotica accumulatasi troverà un nuovo fatale polo d’attrazione.
70 III, iii, 3 La battuta del Frate sembra complementare a quella precedente di Giulietta: se la
morte fa la parte dell’amante, è logico che Romeo sia visto come sposato alla disgrazia.
71 III, iii, 20 La reazione di Romeo è molto simile a quella di Giulietta nella scena precedente:
entrambi insistono sulla divaricazione tra parola e realtà.
72 III, iii, 31 L’elencazione di Romeo, introducente un topos che toccherà il suo culmine drammatico
nel celebre monologo di Lear davanti a Cordelia morta, non rientra nella categoria
shakespeariana dell’ “enumerazione caotica”, ma piuttosto in quella del world upside down, del
“mondo capovolto”, e cioè dell’esperienza della rottura della “catena dell’essere” con
conseguente caos universale.
73 III, iii, 101 Riappare il motivo del “nome”, che dopo la scena del balcone denota tutto ciò che è
convenzionale.
74 III, iii, 108 I riferimenti alla “femminilità” di Romeo sono numerosi in tutto il dramma e pronunciati
persino da lui stesso, III, i, 114. Ma piuttosto che pensare al fair youth dei sonetti, occorre
pensare alla rottura dei codici culturali in cui sia Romeo che Giulietta si inscrivono: “femminile”
allora sarà parola che non pertiene tanto alla sessualità quanto alla cultura, come si evince anche
dalla successiva battuta al v. 119, dove si contrappone al disordine culturale di Romeo l’unità
natura-cultura.
75 III, iii, 131 Riprende una metafora usata in II, vi, 10-11.
76 III, iv, 11 mew’d: è termine della falconeria, e indica il luogo ove si tenevano chiusi i falchi la
notte. Con ironia inconsapevole Donna Capuleti, usando un lessico che era servito come codice
tra Romeo e Giulietta, spiega perfettamente la situazione della figlia.
77 III, v, 13 Si credeva che le meteore derivassero da una corruzione del mondo lunare. Si veda,
per un luogo analogo, Giulio Cesare, II, i, 44.
78 III, v, 29 makes sweet division è leggibile sia come “fa una dolce esecuzione musicale” che
come “rende dolci gli addii”. Abbiamo cercato di mantenere il gioco puntando sulle diverse
connotazioni di “accordi”.
79 III, v, 31 Secondo la zoologia fantastica dell’epoca l’allodola aveva occhi deboli mentre il rospo
una vista acutissima.
80 III, v, 59 Questo scambio di battute, in un clima tutto onirico, segna uno dei punti più alti del
dramma, in direzione d’una sua lettura come Liebestod.
81 III, v, 74 Inizia qui, nel dialogo tra Giulietta e la madre, quella che secondo una convenzione
iniziatasi con Amleto, potremmo definire la “pazzia” di Giulietta. Uccisi dall’ordine simbolico, questi
personaggi, reagiscono sussumendolo e violentandolo a piacere. La pazzia consiste di fatto in un
uso particolare del linguaggio, che viene costretto a dire insieme il vero e il falso. A partire dalle
lacrime per Romeo, fatte passare come lacrime per Tebaldo, tutto l’ordine del linguaggio sarà
scosso tramite la plurivocità del referente o del significante: così, da friend a villain, da grieve a
traitor, sino a the reach of my hands tutto è doppio ed ambiguo, sino alla splendida conclusione
del dialogo (93-102) in cui paradossalmente sono riuniti gli estremi del dramma, dove cioè
uccidere e fare l’amore sono detti con le medesime parole.
82 III, v, 108 Così come Romeo ha ricevuto il seme della “femminilità”, Giulietta partecipa ora di
quello “maschile” della “pesantezza”, che, specie in I, iv, aveva marcato Romeo.
83 III, v, 149 La trappola del linguaggio si chiude ancora una volta su Giulietta, che non per niente
detesta i “nomi”. Se l’oscurità linguistica aveva tratto in inganno la madre, ora l’eccesso
d’oscurità la relega al silenzio: il padre, di fatto, le toglie letteralmente la parola.
84 III, v, 165-166 Anche per Capuleti giocherà l’ironia drammatica: si vedano i suoi lamenti per la
perdita dell’unica figlia in IV, v, 46-47.