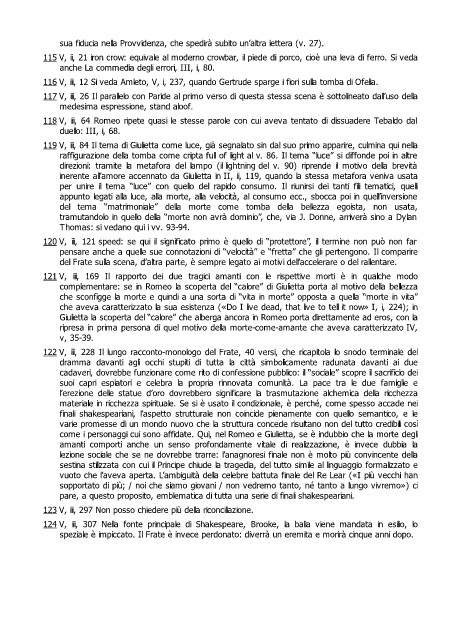Page 3265 - Shakespeare - Vol. 1
P. 3265
sua fiducia nella Provvidenza, che spedirà subito un’altra lettera (v. 27).
115 V, ii, 21 iron crow: equivale al moderno crowbar, il piede di porco, cioè una leva di ferro. Si veda
anche La commedia degli errori, III, i, 80.
116 V, iii, 12 Si veda Amleto, V, i, 237, quando Gertrude sparge i fiori sulla tomba di Ofelia.
117 V, iii, 26 Il parallelo con Paride al primo verso di questa stessa scena è sottolineato dall’uso della
medesima espressione, stand aloof.
118 V, iii, 64 Romeo ripete quasi le stesse parole con cui aveva tentato di dissuadere Tebaldo dal
duello: III, i, 68.
119 V, iii, 84 Il tema di Giulietta come luce, già segnalato sin dal suo primo apparire, culmina qui nella
raffigurazione della tomba come cripta full of light al v. 86. Il tema “luce” si diffonde poi in altre
direzioni: tramite la metafora del lampo (il lightning del v. 90) riprende il motivo della brevità
inerente all’amore accennato da Giulietta in II, ii, 119, quando la stessa metafora veniva usata
per unire il tema “luce” con quello del rapido consumo. Il riunirsi dei tanti fili tematici, quelli
appunto legati alla luce, alla morte, alla velocità, al consumo ecc., sbocca poi in quell’inversione
del tema “matrimoniale” della morte come tomba della bellezza egoista, non usata,
tramutandolo in quello della “morte non avrà dominio”, che, via J. Donne, arriverà sino a Dylan
Thomas: si vedano qui i vv. 93-94.
120 V, iii, 121 speed: se qui il significato primo è quello di “protettore”, il termine non può non far
pensare anche a quelle sue connotazioni di “velocità” e “fretta” che gli pertengono. Il comparire
del Frate sulla scena, d’altra parte, è sempre legato ai motivi dell’accelerare o del rallentare.
121 V, iii, 169 Il rapporto dei due tragici amanti con le rispettive morti è in qualche modo
complementare: se in Romeo la scoperta del “calore” di Giulietta porta al motivo della bellezza
che sconfigge la morte e quindi a una sorta di “vita in morte” opposta a quella “morte in vita”
che aveva caratterizzato la sua esistenza («Do I live dead, that live to tell it now» I, i, 224); in
Giulietta la scoperta del “calore” che alberga ancora in Romeo porta direttamente ad eros, con la
ripresa in prima persona di quel motivo della morte-come-amante che aveva caratterizzato IV,
v, 35-39.
122 V, iii, 228 Il lungo racconto-monologo del Frate, 40 versi, che ricapitola lo snodo terminale del
dramma davanti agli occhi stupiti di tutta la città simbolicamente radunata davanti ai due
cadaveri, dovrebbe funzionare come rito di confessione pubblico: il “sociale” scopre il sacrificio dei
suoi capri espiatori e celebra la propria rinnovata comunità. La pace tra le due famiglie e
l’erezione delle statue d’oro dovrebbero significare la trasmutazione alchemica della ricchezza
materiale in ricchezza spirituale. Se si è usato il condizionale, è perché, come spesso accade nei
finali shakespeariani, l’aspetto strutturale non coincide pienamente con quello semantico, e le
varie promesse di un mondo nuovo che la struttura concede risultano non del tutto credibili così
come i personaggi cui sono affidate. Qui, nel Romeo e Giulietta, se è indubbio che la morte degli
amanti comporti anche un senso profondamente vitale di realizzazione, è invece dubbia la
lezione sociale che se ne dovrebbe trarre: l’anagnoresi finale non è molto più convincente della
sestina stilizzata con cui il Principe chiude la tragedia, del tutto simile al linguaggio formalizzato e
vuoto che l’aveva aperta. L’ambiguità della celebre battuta finale del Re Lear («I più vecchi han
sopportato di più; / noi che siamo giovani / non vedremo tanto, né tanto a lungo vivremo») ci
pare, a questo proposito, emblematica di tutta una serie di finali shakespeariani.
123 V, iii, 297 Non posso chiedere più della riconciliazione.
124 V, iii, 307 Nella fonte principale di Shakespeare, Brooke, la balia viene mandata in esilio, lo
speziale è impiccato. Il Frate è invece perdonato: diverrà un eremita e morirà cinque anni dopo.