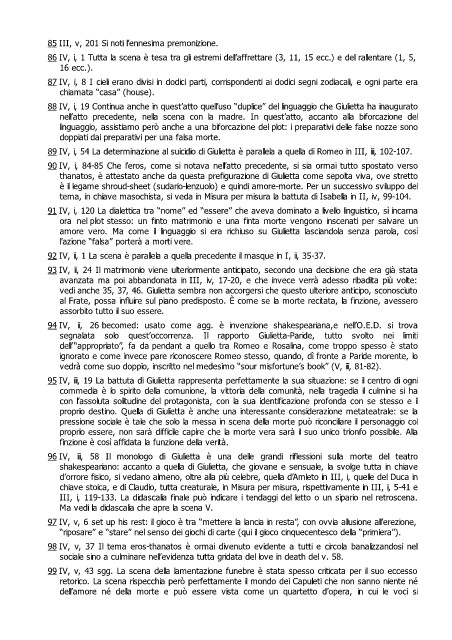Page 3263 - Shakespeare - Vol. 1
P. 3263
85 III, v, 201 Si noti l’ennesima premonizione.
86 IV, i, 1 Tutta la scena è tesa tra gli estremi dell’affrettare (3, 11, 15 ecc.) e del rallentare (1, 5,
16 ecc.).
87 IV, i, 8 I cieli erano divisi in dodici parti, corrispondenti ai dodici segni zodiacali, e ogni parte era
chiamata “casa” (house).
88 IV, i, 19 Continua anche in quest’atto quell’uso “duplice” del linguaggio che Giulietta ha inaugurato
nell’atto precedente, nella scena con la madre. In quest’atto, accanto alla biforcazione del
linguaggio, assistiamo però anche a una biforcazione del plot: i preparativi delle false nozze sono
doppiati dai preparativi per una falsa morte.
89 IV, i, 54 La determinazione al suicidio di Giulietta è parallela a quella di Romeo in III, iii, 102-107.
90 IV, i, 84-85 Che l’eros, come si notava nell’atto precedente, si sia ormai tutto spostato verso
thanatos, è attestato anche da questa prefigurazione di Giulietta come sepolta viva, ove stretto
è il legame shroud-sheet (sudario-lenzuolo) e quindi amore-morte. Per un successivo sviluppo del
tema, in chiave masochista, si veda in Misura per misura la battuta di Isabella in II, iv, 99-104.
91 IV, i, 120 La dialettica tra “nome” ed “essere” che aveva dominato a livello linguistico, sì incarna
ora nel plot stesso: un finto matrimonio e una finta morte vengono inscenati per salvare un
amore vero. Ma come il linguaggio si era richiuso su Giulietta lasciandola senza parola, così
l’azione “falsa” porterà a morti vere.
92 IV, ii, 1 La scena è parallela a quella precedente il masque in I, ii, 35-37.
93 IV, ii, 24 Il matrimonio viene ulteriormente anticipato, secondo una decisione che era già stata
avanzata ma poi abbandonata in III, iv, 17-20, e che invece verrà adesso ribadita più volte:
vedi anche 35, 37, 46. Giulietta sembra non accorgersi che questo ulteriore anticipo, sconosciuto
al Frate, possa influire sul piano predisposto. È come se la morte recitata, la finzione, avessero
assorbito tutto il suo essere.
94 IV, ii, 26 becomed: usato come agg. è invenzione shakespeariana,e nell’O.E.D. si trova
segnalata solo quest’occorrenza. Il rapporto Giulietta-Paride, tutto svolto nei limiti
dell’ “appropriato”, fa da pendant a quello tra Romeo e Rosalina, come troppo spesso è stato
ignorato e come invece pare riconoscere Romeo stesso, quando, dì fronte a Paride morente, lo
vedrà come suo doppio, inscritto nel medesimo “sour misfortune’s book” (V, iii, 81-82).
95 IV, iii, 19 La battuta di Giulietta rappresenta perfettamente la sua situazione: se il centro di ogni
commedia è lo spirito della comunione, la vittoria della comunità, nella tragedia il culmine si ha
con l’assoluta solitudine del protagonista, con la sua identificazione profonda con se stesso e il
proprio destino. Quella di Giulietta è anche una interessante considerazione metateatrale: se la
pressione sociale è tale che solo la messa in scena della morte può riconciliare il personaggio col
proprio essere, non sarà difficile capire che la morte vera sarà il suo unico trionfo possibile. Alla
finzione è così affidata la funzione della verità.
96 IV, iii, 58 Il monologo di Giulietta è una delle grandi riflessioni sulla morte del teatro
shakespeariano: accanto a quella di Giulietta, che giovane e sensuale, la svolge tutta in chiave
d’orrore fisico, si vedano almeno, oltre alla più celebre, quella d’Amleto in III, i, quelle del Duca in
chiave stoica, e di Claudio, tutta creaturale, in Misura per misura, rispettivamente in III, i, 5-41 e
III, i, 119-133. La didascalia finale può indicare i tendaggi del letto o un sipario nel retroscena.
Ma vedi la didascalia che apre la scena V.
97 IV, v, 6 set up his rest: il gioco è tra “mettere la lancia in resta”, con ovvia allusione all’erezione,
“riposare” e “stare” nel senso dei giochi di carte (qui il gioco cinquecentesco della “primiera”).
98 IV, v, 37 Il tema eros-thanatos è ormai divenuto evidente a tutti e circola banalizzandosi nel
sociale sino a culminare nell’evidenza tutta gridata del love in death del v. 58.
99 IV, v, 43 sgg. La scena della lamentazione funebre è stata spesso criticata per il suo eccesso
retorico. La scena rispecchia però perfettamente il mondo dei Capuleti che non sanno niente né
dell’amore né della morte e può essere vista come un quartetto d’opera, in cui le voci si