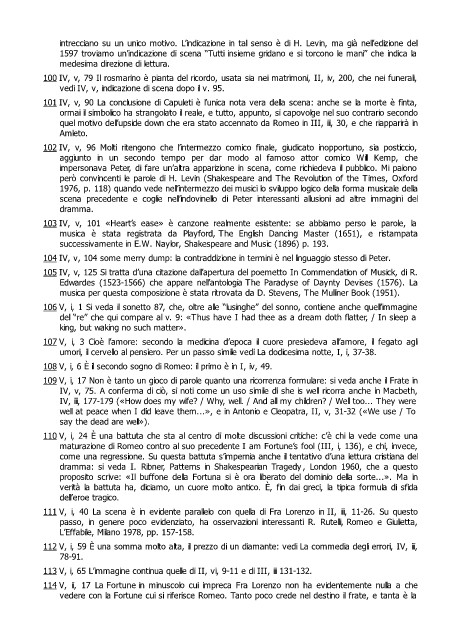Page 3264 - Shakespeare - Vol. 1
P. 3264
intrecciano su un unico motivo. L’indicazione in tal senso è di H. Levin, ma già nell’edizione del
1597 troviamo un’indicazione di scena “Tutti insieme gridano e si torcono le mani” che indica la
medesima direzione di lettura.
100 IV, v, 79 Il rosmarino è pianta del ricordo, usata sia nei matrimoni, II, iv, 200, che nei funerali,
vedi IV, v, indicazione di scena dopo il v. 95.
101 IV, v, 90 La conclusione di Capuleti è l’unica nota vera della scena: anche se la morte è finta,
ormai il simbolico ha strangolato il reale, e tutto, appunto, si capovolge nel suo contrario secondo
quel motivo dell’upside down che era stato accennato da Romeo in III, iii, 30, e che riapparirà in
Amleto.
102 IV, v, 96 Molti ritengono che l’intermezzo comico finale, giudicato inopportuno, sia posticcio,
aggiunto in un secondo tempo per dar modo al famoso attor comico Will Kemp, che
impersonava Peter, di fare un’altra apparizione in scena, come richiedeva il pubblico. Mi paiono
però convincenti le parole di H. Levin (Shakespeare and The Revolution of the Times, Oxford
1976, p. 118) quando vede nell’intermezzo dei musici lo sviluppo logico della forma musicale della
scena precedente e coglie nell’indovinello di Peter interessanti allusioni ad altre immagini del
dramma.
103 IV, v, 101 «Heart’s ease» è canzone realmente esistente: se abbiamo perso le parole, la
musica è stata registrata da Playford, The English Dancing Master (1651), e ristampata
successivamente in E.W. Naylor, Shakespeare and Music (1896) p. 193.
104 IV, v, 104 some merry dump: la contraddizione in termini è nel linguaggio stesso di Peter.
105 IV, v, 125 Si tratta d’una citazione dall’apertura del poemetto In Commendation of Musick, di R.
Edwardes (1523-1566) che appare nell’antologia The Paradyse of Daynty Devises (1576). La
musica per questa composizione è stata ritrovata da D. Stevens, The Mulliner Book (1951).
106 V, i, 1 Si veda il sonetto 87, che, oltre alle “lusinghe” del sonno, contiene anche quell’immagine
del “re” che qui compare al v. 9: «Thus have I had thee as a dream doth flatter, / In sleep a
king, but waking no such matter».
107 V, i, 3 Cioè l’amore: secondo la medicina d’epoca il cuore presiedeva all’amore, il fegato agli
umori, il cervello al pensiero. Per un passo simile vedi La dodicesima notte, I, i, 37-38.
108 V, i, 6 È il secondo sogno di Romeo: il primo è in I, iv, 49.
109 V, i, 17 Non è tanto un gioco di parole quanto una ricorrenza formulare: si veda anche il Frate in
IV, v, 75. A conferma di ciò, si noti come un uso simile di she is well ricorra anche in Macbeth,
IV, iii, 177-179 («How does my wife? / Why, well. / And all my children? / Well too... They were
well at peace when I did leave them...», e in Antonio e Cleopatra, II, v, 31-32 («We use / To
say the dead are well»).
110 V, i, 24 È una battuta che sta al centro di molte discussioni critiche: c’è chi la vede come una
maturazione di Romeo contro al suo precedente I am Fortune’s fool (III, i, 136), e chi, invece,
come una regressione. Su questa battuta s’impernia anche il tentativo d’una lettura cristiana del
dramma: si veda I. Ribner, Patterns in Shakespearian Tragedy , London 1960, che a questo
proposito scrive: «Il buffone della Fortuna si è ora liberato del dominio della sorte...». Ma in
verità la battuta ha, diciamo, un cuore molto antico. È, fin dai greci, la tipica formula di sfida
dell’eroe tragico.
111 V, i, 40 La scena è in evidente parallelo con quella di Fra Lorenzo in II, iii, 11-26. Su questo
passo, in genere poco evidenziato, ha osservazioni interessanti R. Rutelli, Romeo e Giulietta,
L’Effabile, Milano 1978, pp. 157-158.
112 V, i, 59 È una somma molto alta, il prezzo di un diamante: vedi La commedia degli errori, IV, iii,
78-91.
113 V, i, 65 L’immagine continua quelle di II, vi, 9-11 e di III, iii 131-132.
114 V, ii, 17 La Fortune in minuscolo cui impreca Fra Lorenzo non ha evidentemente nulla a che
vedere con la Fortune cui si riferisce Romeo. Tanto poco crede nel destino il frate, e tanta è la