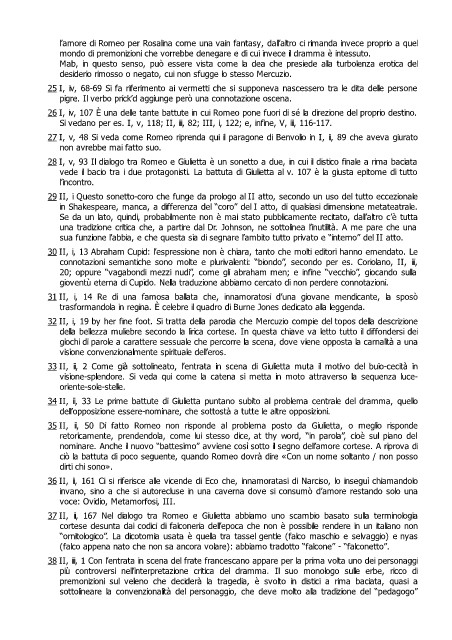Page 3259 - Shakespeare - Vol. 1
P. 3259
l’amore di Romeo per Rosalina come una vain fantasy, dall’altro ci rimanda invece proprio a quel
mondo di premonizioni che vorrebbe denegare e di cui invece il dramma è intessuto.
Mab, in questo senso, può essere vista come la dea che presiede alla turbolenza erotica del
desiderio rimosso o negato, cui non sfugge lo stesso Mercuzio.
25 I, iv, 68-69 Si fa riferimento ai vermetti che si supponeva nascessero tra le dita delle persone
pigre. Il verbo prick’d aggiunge però una connotazione oscena.
26 I, iv, 107 È una delle tante battute in cui Romeo pone fuori di sé la direzione del proprio destino.
Si vedano per es. I, v, 118; II, iii, 82; III, i, 122; e, infine, V, iii, 116-117.
27 I, v, 48 Si veda come Romeo riprenda qui il paragone di Benvolio in I, ii, 89 che aveva giurato
non avrebbe mai fatto suo.
28 I, v, 93 Il dialogo tra Romeo e Giulietta è un sonetto a due, in cui il distico finale a rima baciata
vede il bacio tra i due protagonisti. La battuta di Giulietta al v. 107 è la giusta epitome di tutto
l’incontro.
29 II, i Questo sonetto-coro che funge da prologo al II atto, secondo un uso del tutto eccezionale
in Shakespeare, manca, a differenza del “coro” del I atto, di qualsiasi dimensione metateatrale.
Se da un lato, quindi, probabilmente non è mai stato pubblicamente recitato, dall’altro c’è tutta
una tradizione critica che, a partire dal Dr. Johnson, ne sottolinea l’inutilità. A me pare che una
sua funzione l’abbia, e che questa sia di segnare l’ambito tutto privato e “interno” del II atto.
30 II, i, 13 Abraham Cupid: l’espressione non è chiara, tanto che molti editori hanno emendato. Le
connotazioni semantiche sono molte e plurivalenti: “biondo”, secondo per es. Coriolano, II, iii,
20; oppure “vagabondi mezzi nudi”, come gli abraham men; e infine “vecchio”, giocando sulla
gioventù eterna di Cupido. Nella traduzione abbiamo cercato di non perdere connotazioni.
31 II, i, 14 Re di una famosa ballata che, innamoratosi d’una giovane mendicante, la sposò
trasformandola in regina. È celebre il quadro di Burne Jones dedicato alla leggenda.
32 II, i, 19 by her fine foot. Si tratta della parodia che Mercuzio compie del topos della descrizione
della bellezza muliebre secondo la lirica cortese. In questa chiave va letto tutto il diffondersi dei
giochi di parole a carattere sessuale che percorre la scena, dove viene opposta la carnalità a una
visione convenzionalmente spirituale dell’eros.
33 II, ii, 2 Come già sottolineato, l’entrata in scena di Giulietta muta il motivo del buio-cecità in
visione-splendore. Si veda qui come la catena si metta in moto attraverso la sequenza luce-
oriente-sole-stelle.
34 II, ii, 33 Le prime battute di Giulietta puntano subito al problema centrale del dramma, quello
dell’opposizione essere-nominare, che sottostà a tutte le altre opposizioni.
35 II, ii, 50 Di fatto Romeo non risponde al problema posto da Giulietta, o meglio risponde
retoricamente, prendendola, come lui stesso dice, at thy word, “in parola”, cioè sul piano del
nominare. Anche il nuovo “battesimo” avviene così sotto il segno dell’amore cortese. A riprova di
ciò la battuta di poco seguente, quando Romeo dovrà dire «Con un nome soltanto / non posso
dirti chi sono».
36 II, ii, 161 Ci si riferisce alle vicende di Eco che, innamoratasi di Narciso, lo inseguì chiamandolo
invano, sino a che si autorecluse in una caverna dove si consumò d’amore restando solo una
voce: Ovidio, Metamorfosi, III.
37 II, ii, 167 Nel dialogo tra Romeo e Giulietta abbiamo uno scambio basato sulla terminologia
cortese desunta dai codici di falconeria dell’epoca che non è possibile rendere in un italiano non
“ornitologico”. La dicotomia usata è quella tra tassel gentle (falco maschio e selvaggio) e nyas
(falco appena nato che non sa ancora volare): abbiamo tradotto “falcone” - “falconetto”.
38 II, iii, 1 Con l’entrata in scena del frate francescano appare per la prima volta uno dei personaggi
più controversi nell’interpretazione critica del dramma. Il suo monologo sulle erbe, ricco di
premonizioni sul veleno che deciderà la tragedia, è svolto in distici a rima baciata, quasi a
sottolineare la convenzionalità del personaggio, che deve molto alla tradizione del “pedagogo”