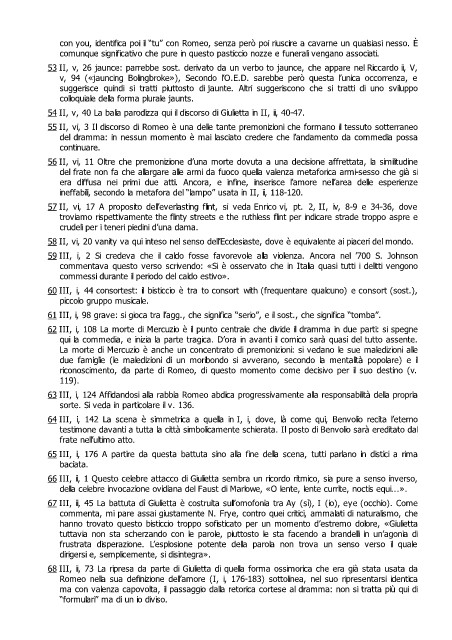Page 3261 - Shakespeare - Vol. 1
P. 3261
con you, identifica poi il “tu” con Romeo, senza però poi riuscire a cavarne un qualsiasi nesso. È
comunque significativo che pure in questo pasticcio nozze e funerali vengano associati.
53 II, v, 26 jaunce: parrebbe sost. derivato da un verbo to jaunce, che appare nel Riccardo ii, V,
v, 94 («jauncing Bolingbroke»), Secondo l’O.E.D. sarebbe però questa l’unica occorrenza, e
suggerisce quindi si tratti piuttosto di jaunte. Altri suggeriscono che si tratti di uno sviluppo
colloquiale della forma plurale jaunts.
54 II, v, 40 La balia parodizza qui il discorso di Giulietta in II, ii, 40-47.
55 II, vi, 3 Il discorso di Romeo è una delle tante premonizioni che formano il tessuto sotterraneo
del dramma: in nessun momento è mai lasciato credere che l’andamento da commedia possa
continuare.
56 II, vi, 11 Oltre che premonizione d’una morte dovuta a una decisione affrettata, la similitudine
del frate non fa che allargare alle armi da fuoco quella valenza metaforica armi-sesso che già si
era diffusa nei primi due atti. Ancora, e infine, inserisce l’amore nell’area delle esperienze
ineffabili, secondo la metafora del “lampo” usata in II, ii, 118-120.
57 II, vi, 17 A proposito dell’everlasting flint, si veda Enrico vi, pt. 2, II, iv, 8-9 e 34-36, dove
troviamo rispettivamente the flinty streets e the ruthless flint per indicare strade troppo aspre e
crudeli per i teneri piedini d’una dama.
58 II, vi, 20 vanity va qui inteso nel senso dell’Ecclesiaste, dove è equivalente ai piaceri del mondo.
59 III, i, 2 Si credeva che il caldo fosse favorevole alla violenza. Ancora nel ’700 S. Johnson
commentava questo verso scrivendo: «Si è osservato che in Italia quasi tutti i delitti vengono
commessi durante il periodo del caldo estivo».
60 III, i, 44 consortest: il bisticcio è tra to consort with (frequentare qualcuno) e consort (sost.),
piccolo gruppo musicale.
61 III, i, 98 grave: si gioca tra l’agg., che significa “serio”, e il sost., che significa “tomba”.
62 III, i, 108 La morte di Mercuzio è il punto centrale che divide il dramma in due parti: si spegne
qui la commedia, e inizia la parte tragica. D’ora in avanti il comico sarà quasi del tutto assente.
La morte di Mercuzio è anche un concentrato di premonizioni: si vedano le sue maledizioni alle
due famiglie (le maledizioni di un moribondo si avverano, secondo la mentalità popolare) e il
riconoscimento, da parte di Romeo, di questo momento come decisivo per il suo destino (v.
119).
63 III, i, 124 Affidandosi alla rabbia Romeo abdica progressivamente alla responsabilità della propria
sorte. Si veda in particolare il v. 136.
64 III, i, 142 La scena è simmetrica a quella in I, i, dove, là come qui, Benvolio recita l’eterno
testimone davanti a tutta la città simbolicamente schierata. Il posto di Benvolio sarà ereditato dal
frate nell’ultimo atto.
65 III, i, 176 A partire da questa battuta sino alla fine della scena, tutti parlano in distici a rima
baciata.
66 III, ii, 1 Questo celebre attacco di Giulietta sembra un ricordo ritmico, sia pure a senso inverso,
della celebre invocazione ovidiana del Faust di Marlowe, «O lente, lente currite, noctis equi...».
67 III, ii, 45 La battuta dì Giulietta è costruita sull’omofonia tra Ay (sì), I (io), eye (occhio). Come
commenta, mi pare assai giustamente N. Frye, contro quei critici, ammalati di naturalismo, che
hanno trovato questo bisticcio troppo sofisticato per un momento d’estremo dolore, «Giulietta
tuttavia non sta scherzando con le parole, piuttosto le sta facendo a brandelli in un’agonia di
frustrata disperazione. L’esplosione potente della parola non trova un senso verso il quale
dirigersi e, semplicemente, si disintegra».
68 III, ii, 73 La ripresa da parte di Giulietta di quella forma ossimorica che era già stata usata da
Romeo nella sua definizione dell’amore (I, i, 176-183) sottolinea, nel suo ripresentarsi identica
ma con valenza capovolta, il passaggio dalla retorica cortese al dramma: non si tratta più qui di
“formulari” ma di un io diviso.