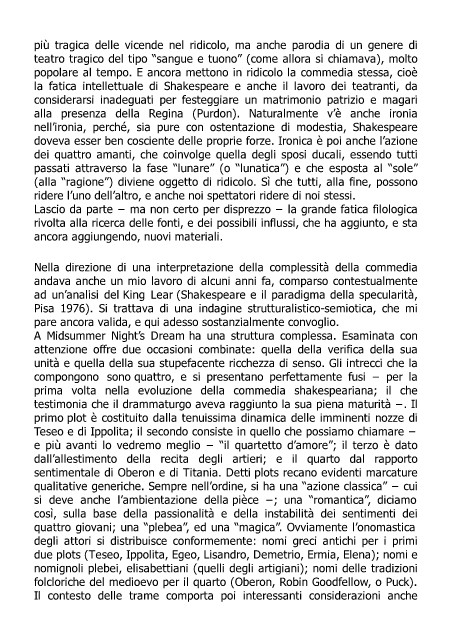Page 2511 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2511
più tragica delle vicende nel ridicolo, ma anche parodia di un genere di
teatro tragico del tipo “sangue e tuono” (come allora si chiamava), molto
popolare al tempo. E ancora mettono in ridicolo la commedia stessa, cioè
la fatica intellettuale di Shakespeare e anche il lavoro dei teatranti, da
considerarsi inadeguati per festeggiare un matrimonio patrizio e magari
alla presenza della Regina (Purdon). Naturalmente v’è anche ironia
nell’ironia, perché, sia pure con ostentazione di modestia, Shakespeare
doveva esser ben cosciente delle proprie forze. Ironica è poi anche l’azione
dei quattro amanti, che coinvolge quella degli sposi ducali, essendo tutti
passati attraverso la fase “lunare” (o “lunatica”) e che esposta al “sole”
(alla “ragione”) diviene oggetto di ridicolo. Sì che tutti, alla fine, possono
ridere l’uno dell’altro, e anche noi spettatori ridere di noi stessi.
Lascio da parte - ma non certo per disprezzo - la grande fatica filologica
rivolta alla ricerca delle fonti, e dei possibili influssi, che ha aggiunto, e sta
ancora aggiungendo, nuovi materiali.
Nella direzione di una interpretazione della complessità della commedia
andava anche un mio lavoro di alcuni anni fa, comparso contestualmente
ad un’analisi del King Lear (Shakespeare e il paradigma della specularità,
Pisa 1976). Si trattava di una indagine strutturalistico-semiotica, che mi
pare ancora valida, e qui adesso sostanzialmente convoglio.
A Midsummer Night’s Dream ha una struttura complessa. Esaminata con
attenzione offre due occasioni combinate: quella della verifica della sua
unità e quella della sua stupefacente ricchezza di senso. Gli intrecci che la
compongono sono quattro, e si presentano perfettamente fusi - per la
prima volta nella evoluzione della commedia shakespeariana; il che
testimonia che il drammaturgo aveva raggiunto la sua piena maturità -. Il
primo plot è costituito dalla tenuissima dinamica delle imminenti nozze di
Teseo e di Ippolita; il secondo consiste in quello che possiamo chiamare -
e più avanti lo vedremo meglio - “il quartetto d’amore”; il terzo è dato
dall’allestimento della recita degli artieri; e il quarto dal rapporto
sentimentale di Oberon e di Titania. Detti plots recano evidenti marcature
qualitative generiche. Sempre nell’ordine, si ha una “azione classica” - cui
si deve anche l’ambientazione della pièce -; una “romantica”, diciamo
così, sulla base della passionalità e della instabilità dei sentimenti dei
quattro giovani; una “plebea”, ed una “magica”. Ovviamente l’onomastica
degli attori si distribuisce conformemente: nomi greci antichi per i primi
due plots (Teseo, Ippolita, Egeo, Lisandro, Demetrio, Ermia, Elena); nomi e
nomignoli plebei, elisabettiani (quelli degli artigiani); nomi delle tradizioni
folcloriche del medioevo per il quarto (Oberon, Robin Goodfellow, o Puck).
Il contesto delle trame comporta poi interessanti considerazioni anche