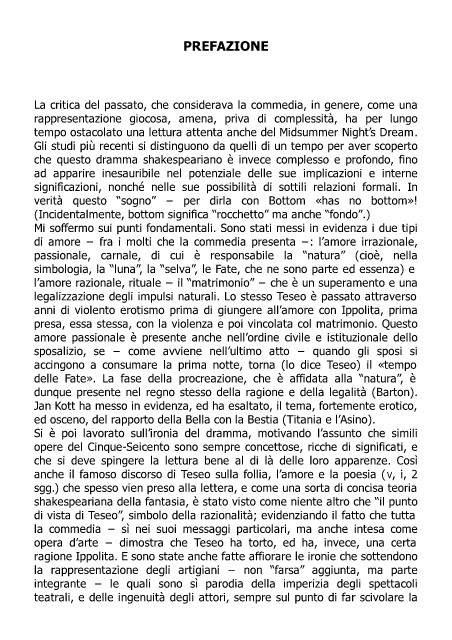Page 2510 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2510
PREFAZIONE
La critica del passato, che considerava la commedia, in genere, come una
rappresentazione giocosa, amena, priva di complessità, ha per lungo
tempo ostacolato una lettura attenta anche del Midsummer Night’s Dream.
Gli studi più recenti si distinguono da quelli di un tempo per aver scoperto
che questo dramma shakespeariano è invece complesso e profondo, fino
ad apparire inesauribile nel potenziale delle sue implicazioni e interne
significazioni, nonché nelle sue possibilità di sottili relazioni formali. In
verità questo “sogno” - per dirla con Bottom «has no bottom»!
(Incidentalmente, bottom significa “rocchetto” ma anche “fondo”.)
Mi soffermo sui punti fondamentali. Sono stati messi in evidenza i due tipi
di amore - fra i molti che la commedia presenta -: l’amore irrazionale,
passionale, carnale, di cui è responsabile la “natura” (cioè, nella
simbologia, la “luna”, la “selva”, le Fate, che ne sono parte ed essenza) e
l’amore razionale, rituale - il “matrimonio” - che è un superamento e una
legalizzazione degli impulsi naturali. Lo stesso Teseo è passato attraverso
anni di violento erotismo prima di giungere all’amore con Ippolita, prima
presa, essa stessa, con la violenza e poi vincolata col matrimonio. Questo
amore passionale è presente anche nell’ordine civile e istituzionale dello
sposalizio, se - come avviene nell’ultimo atto - quando gli sposi si
accingono a consumare la prima notte, torna (lo dice Teseo) il «tempo
delle Fate». La fase della procreazione, che è affidata alla “natura”, è
dunque presente nel regno stesso della ragione e della legalità (Barton).
Jan Kott ha messo in evidenza, ed ha esaltato, il tema, fortemente erotico,
ed osceno, del rapporto della Bella con la Bestia (Titania e l’Asino).
Si è poi lavorato sull’ironia del dramma, motivando l’assunto che simili
opere del Cinque-Seicento sono sempre concettose, ricche di significati, e
che si deve spingere la lettura bene al di là delle loro apparenze. Così
anche il famoso discorso di Teseo sulla follia, l’amore e la poesia ( V, i, 2
sgg.) che spesso vien preso alla lettera, e come una sorta di concisa teoria
shakespeariana della fantasia, è stato visto come niente altro che “il punto
di vista di Teseo”, simbolo della razionalità; evidenziando il fatto che tutta
la commedia - sì nei suoi messaggi particolari, ma anche intesa come
opera d’arte - dimostra che Teseo ha torto, ed ha, invece, una certa
ragione Ippolita. E sono state anche fatte affiorare le ironie che sottendono
la rappresentazione degli artigiani - non “farsa” aggiunta, ma parte
integrante - le quali sono sì parodia della imperizia degli spettacoli
teatrali, e delle ingenuità degli attori, sempre sul punto di far scivolare la