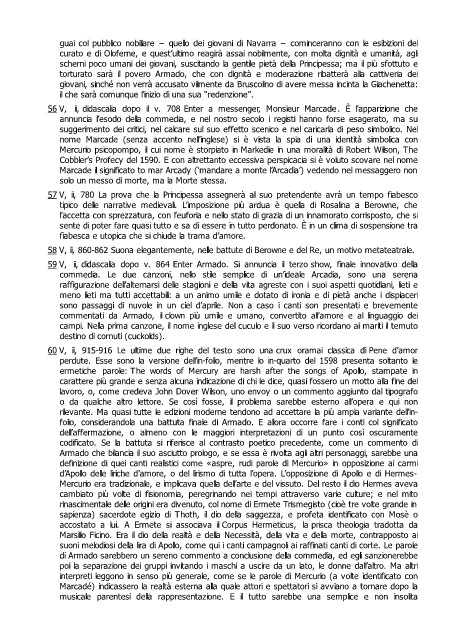Page 2507 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2507
guai col pubblico nobiliare - quello dei giovani di Navarra - cominceranno con le esibizioni del
curato e di Oloferne, e quest’ultimo reagirà assai nobilmente, con molta dignità e umanità, agli
scherni poco umani dei giovani, suscitando la gentile pietà della Principessa; ma il più sfottuto e
torturato sarà il povero Armado, che con dignità e moderazione ribatterà alla cattiveria dei
giovani, sinché non verrà accusato vilmente da Bruscolino di avere messa incinta la Giachenetta:
il che sarà comunque l’inizio di una sua “redenzione”.
56 V, ii, didascalia dopo il v. 708 Enter a messenger, Monsieur Marcade . È l’apparizione che
annuncia l’esodo della commedia, e nel nostro secolo i registi hanno forse esagerato, ma su
suggerimento dei critici, nel calcare sul suo effetto scenico e nel caricarla di peso simbolico. Nel
nome Marcade (senza accento nell’inglese) si è vista la spia di una identità simbolica con
Mercurio psicopompo, il cui nome è storpiato in Markedie in una moralità di Robert Wilson, The
Cobbler’s Profecy del 1590. E con altrettanto eccessiva perspicacia si è voluto scovare nel nome
Marcade il significato to mar Arcady (‘mandare a monte l’Arcadia’) vedendo nel messaggero non
solo un messo di morte, ma la Morte stessa.
57 V, ii, 780 La prova che la Principessa assegnerà al suo pretendente avrà un tempo fiabesco
tipico delle narrative medievali. L’imposizione più ardua è quella di Rosalina a Berowne, che
l’accetta con sprezzatura, con l’euforia e nello stato di grazia di un innamorato corrisposto, che si
sente di poter fare quasi tutto e sa di essere in tutto perdonato. È in un clima di sospensione tra
fiabesca e utopica che si chiude la trama d’amore.
58 V, ii, 860-862 Suona elegantemente, nelle battute di Berowne e del Re, un motivo metateatrale.
59 V, ii, didascalia dopo v. 864 Enter Armado. Si annuncia il terzo show, finale innovativo della
commedia. Le due canzoni, nello stile semplice di un’ideale Arcadia, sono una serena
raffigurazione dell’alternarsi delle stagioni e della vita agreste con i suoi aspetti quotidiani, lieti e
meno lieti ma tutti accettabili: a un animo umile e dotato di ironia e di pietà anche i dispiaceri
sono passaggi di nuvole in un ciel d’aprile. Non a caso i canti son presentati e brevemente
commentati da Armado, il clown più umile e umano, convertito all’amore e al linguaggio dei
campi. Nella prima canzone, il nome inglese del cuculo e il suo verso ricordano ai mariti il temuto
destino di cornuti (cuckolds).
60 V, ii, 915-916 Le ultime due righe del testo sono una crux oramai classica di Pene d’amor
perdute. Esse sono la versione dell’in-folio, mentre lo in-quarto del 1598 presenta soltanto le
ermetiche parole: The words of Mercury are harsh after the songs of Apollo, stampate in
carattere più grande e senza alcuna indicazione di chi le dice, quasi fossero un motto alla fine del
lavoro, o, come credeva John Dover Wilson, uno envoy o un commento aggiunto dal tipografo
o da qualche altro lettore. Se così fosse, il problema sarebbe esterno all’opera e qui non
rilevante. Ma quasi tutte le edizioni moderne tendono ad accettare la più ampia variante dell’in-
folio, considerandola una battuta finale di Armado. E allora occorre fare i conti col significato
dell’affermazione, o almeno con le maggiori interpretazioni di un punto così oscuramente
codificato. Se la battuta si riferisce al contrasto poetico precedente, come un commento di
Armado che bilancia il suo asciutto prologo, e se essa è rivolta agli altri personaggi, sarebbe una
definizione di quei canti realistici come «aspre, rudi parole di Mercurio» in opposizione ai carmi
d’Apollo delle liriche d’amore, o del lirismo di tutta l’opera. L’opposizione di Apollo e di Hermes-
Mercurio era tradizionale, e implicava quella dell’arte e del vissuto. Del resto il dio Hermes aveva
cambiato più volte di fisionomia, peregrinando nei tempi attraverso varie culture; e nel mito
rinascimentale delle origini era divenuto, col nome di Ermete Trismegisto (cioè tre volte grande in
sapienza) sacerdote egizio di Thoth, il dio della saggezza, e profeta identificato con Mosè o
accostato a lui. A Ermete si associava il Corpus Hermeticus, la prisca theologia tradotta da
Marsilio Ficino. Era il dio della realtà e della Necessità, della vita e della morte, contrapposto ai
suoni melodiosi della lira di Apollo, come qui i canti campagnoli ai raffinati canti di corte. Le parole
di Armado sarebbero un sereno commento a conclusione della commedia, ed egli sanzionerebbe
poi la separazione dei gruppi invitando i maschi a uscire da un lato, le donne dall’altro. Ma altri
interpreti leggono in senso più generale, come se le parole di Mercurio (a volte identificato con
Marcadé) indicassero la realtà esterna alla quale attori e spettatori si avviano a tornare dopo la
musicale parentesi della rappresentazione. E il tutto sarebbe una semplice e non insolita