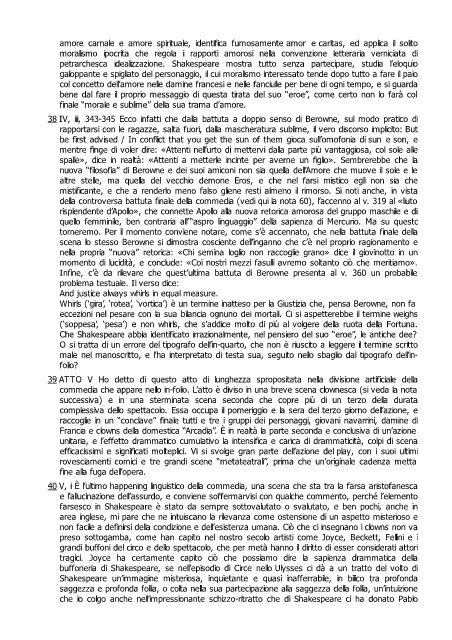Page 2504 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2504
amore carnale e amore spirituale, identifica fumosamente amor e caritas, ed applica il solito
moralismo ipocrita che regola i rapporti amorosi nella convenzione letteraria verniciata di
petrarchesca idealizzazione. Shakespeare mostra tutto senza partecipare, studia l’eloquio
galoppante e spigliato del personaggio, il cui moralismo interessato tende dopo tutto a fare il paio
col concetto dell’amore nelle damine francesi e nelle fanciulle per bene di ogni tempo, e si guarda
bene dal fare il proprio messaggio di questa tirata del suo “eroe”, come certo non lo farà col
finale “morale e sublime” della sua trama d’amore.
38 IV, iii, 343-345 Ecco infatti che dalla battuta a doppio senso di Berowne, sul modo pratico di
rapportarsi con le ragazze, salta fuori, dalla mascheratura sublime, il vero discorso implicito: But
be first advised / In conflict that you get the sun of them gioca sull’omofonia di sun e son, e
mentre finge di voler dire: «Attenti nell’urto di mettervi dalla parte più vantaggiosa, col sole alle
spalle», dice in realtà: «Attenti a metterle incinte per averne un figlio». Sembrerebbe che la
nuova “filosofia” di Berowne e dei suoi amiconi non sia quella dell’Amore che muove il sole e le
altre stelle, ma quella del vecchio demone Eros, e che nel farsi mistico egli non sia che
mistificante, e che a renderlo meno falso gliene resti almeno il rimorso. Si noti anche, in vista
della controversa battuta finale della commedia (vedi qui la nota 60), l’accenno al v. 319 al «liuto
risplendente d’Apollo», che connette Apollo alla nuova retorica amorosa del gruppo maschile e di
quello femminile, ben contraria all’ “aspro linguaggio” della sapienza di Mercurio. Ma su questo
torneremo. Per il momento conviene notare, come s’è accennato, che nella battuta finale della
scena lo stesso Berowne si dimostra cosciente dell’inganno che c’è nel proprio ragionamento e
nella propria “nuova” retorica: «Chi semina loglio non raccoglie grano» dice il giovinotto in un
momento di lucidità, e conclude: «Coi nostri mezzi fasulli avremo soltanto ciò che meritiamo».
Infine, c’è da rilevare che quest’ultima battuta di Berowne presenta al v. 360 un probabile
problema testuale. Il verso dice:
And justice always whirls in equal measure.
Whirls (‘gira’, ‘rotea’, ‘vortica’) è un termine inatteso per la Giustizia che, pensa Berowne, non fa
eccezioni nel pesare con la sua bilancia ognuno dei mortali. Ci si aspetterebbe il termine weighs
(‘soppesa’, ‘pesa’) e non whirls, che s’addice molto di più al volgere della ruota della Fortuna.
Che Shakespeare abbia identificato irrazionalmente, nel pensiero del suo “eroe”, le antiche dee?
O si tratta di un errore del tipografo dell’in-quarto, che non è riuscito a leggere il termine scritto
male nel manoscritto, e l’ha interpretato di testa sua, seguito nello sbaglio dal tipografo dell’in-
folio?
39 ATTO V Ho detto di questo atto di lunghezza spropositata nella divisione artificiale della
commedia che appare nello in-folio. L’atto è diviso in una breve scena clownesca (si veda la nota
successiva) e in una sterminata scena seconda che copre più di un terzo della durata
complessiva dello spettacolo. Essa occupa il pomeriggio e la sera del terzo giorno dell’azione, e
raccoglie in un “conclave” finale tutti e tre i gruppi dei personaggi, giovani navarrini, damine di
Francia e clowns della domestica “Arcadia”. È in realtà la parte seconda e conclusiva di un’azione
unitaria, e l’effetto drammatico cumulativo la intensifica e carica di drammaticità, colpi di scena
efficacissimi e significati molteplici. Vi si svolge gran parte dell’azione del play, con i suoi ultimi
rovesciamenti comici e tre grandi scene “metateatrali”, prima che un’originale cadenza metta
fine alla fuga dell’opera.
40 V, i È l’ultimo happening linguistico della commedia, una scena che sta tra la farsa aristofanesca
e l’allucinazione dell’assurdo, e conviene soffermarvisi con qualche commento, perché l’elemento
farsesco in Shakespeare è stato da sempre sottovalutato o svalutato, e ben pochi, anche in
area inglese, mi pare che ne intuiscano la rilevanza come ostensione di un aspetto misterioso e
non facile a definirsi della condizione e dell’esistenza umana. Ciò che ci insegnano i clowns non va
preso sottogamba, come han capito nel nostro secolo artisti come Joyce, Beckett, Fellini e i
grandi buffoni del circo e dello spettacolo, che per metà hanno il diritto di esser considerati attori
tragici. Joyce ha certamente capito ciò che possiamo dire la sapienza drammatica della
buffoneria di Shakespeare, se nell’episodio di Circe nello Ulysses ci dà a un tratto del volto di
Shakespeare un’immagine misteriosa, inquietante e quasi inafferrabile, in bilico tra profonda
saggezza e profonda follia, o colta nella sua partecipazione alla saggezza della follia, un’intuizione
che io colgo anche nell’impressionante schizzo-ritratto che di Shakespeare ci ha donato Pablo