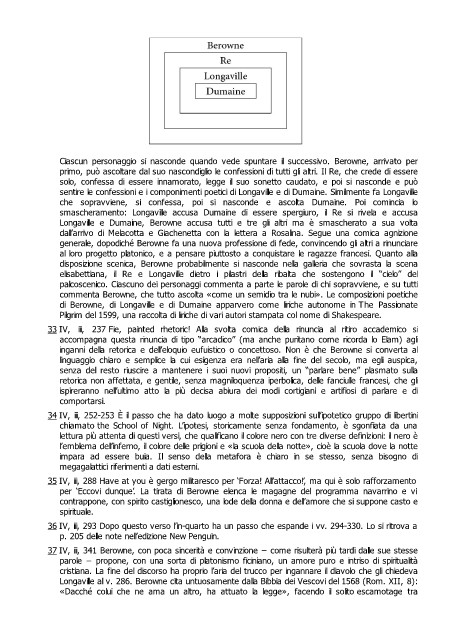Page 2503 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2503
Ciascun personaggio si nasconde quando vede spuntare il successivo. Berowne, arrivato per
primo, può ascoltare dal suo nascondiglio le confessioni di tutti gli altri. Il Re, che crede di essere
solo, confessa di essere innamorato, legge il suo sonetto caudato, e poi si nasconde e può
sentire le confessioni e i componimenti poetici di Longaville e di Dumaine. Similmente fa Longaville
che sopravviene, si confessa, poi si nasconde e ascolta Dumaine. Poi comincia lo
smascheramento: Longaville accusa Dumaine di essere spergiuro, il Re si rivela e accusa
Longaville e Dumaine, Berowne accusa tutti e tre gli altri ma è smascherato a sua volta
dall’arrivo di Melacotta e Giachenetta con la lettera a Rosalina. Segue una comica agnizione
generale, dopodiché Berowne fa una nuova professione di fede, convincendo gli altri a rinunciare
al loro progetto platonico, e a pensare piuttosto a conquistare le ragazze francesi. Quanto alla
disposizione scenica, Berowne probabilmente si nasconde nella galleria che sovrasta la scena
elisabettiana, il Re e Longaville dietro i pilastri della ribalta che sostengono il “cielo” del
palcoscenico. Ciascuno dei personaggi commenta a parte le parole di chi sopravviene, e su tutti
commenta Berowne, che tutto ascolta «come un semidio tra le nubi». Le composizioni poetiche
di Berowne, di Longaville e di Dumaine apparvero come liriche autonome in The Passionate
Pilgrim del 1599, una raccolta di liriche di vari autori stampata col nome di Shakespeare.
33 IV, iii, 237 Fie, painted rhetoric! Alla svolta comica della rinuncia al ritiro accademico si
accompagna questa rinuncia di tipo “arcadico” (ma anche puritano come ricorda lo Elam) agli
inganni della retorica e dell’eloquio eufuistico o concettoso. Non è che Berowne si converta al
linguaggio chiaro e semplice la cui esigenza era nell’aria alla fine del secolo, ma egli auspica,
senza del resto riuscire a mantenere i suoi nuovi propositi, un “parlare bene” plasmato sulla
retorica non affettata, e gentile, senza magniloquenza iperbolica, delle fanciulle francesi, che gli
ispireranno nell’ultimo atto la più decisa abiura dei modi cortigiani e artifiosi di parlare e di
comportarsi.
34 IV, iii, 252-253 È il passo che ha dato luogo a molte supposizioni sull’ipotetico gruppo di libertini
chiamato the School of Night. L’ipotesi, storicamente senza fondamento, è sgonfiata da una
lettura più attenta di questi versi, che qualificano il colore nero con tre diverse definizioni: il nero è
l’emblema dell’inferno, il colore delle prigioni e «la scuola della notte», cioè la scuola dove la notte
impara ad essere buia. Il senso della metafora è chiaro in se stesso, senza bisogno di
megagalattici riferimenti a dati esterni.
35 IV, iii, 288 Have at you è gergo militaresco per ‘Forza! All’attacco!’, ma qui è solo rafforzamento
per ‘Eccovi dunque’. La tirata di Berowne elenca le magagne del programma navarrino e vi
contrappone, con spirito castiglionesco, una lode della donna e dell’amore che si suppone casto e
spirituale.
36 IV, iii, 293 Dopo questo verso l’in-quarto ha un passo che espande i vv. 294-330. Lo si ritrova a
p. 205 delle note nell’edizione New Penguin.
37 IV, iii, 341 Berowne, con poca sincerità e convinzione - come risulterà più tardi dalle sue stesse
parole - propone, con una sorta di platonismo ficiniano, un amore puro e intriso di spiritualità
cristiana. La fine del discorso ha proprio l’aria del trucco per ingannare il diavolo che gli chiedeva
Longaville al v. 286. Berowne cita untuosamente dalla Bibbia dei Vescovi del 1568 (Rom. XII, 8):
«Dacché colui che ne ama un altro, ha attuato la legge», facendo il solito escamotage tra