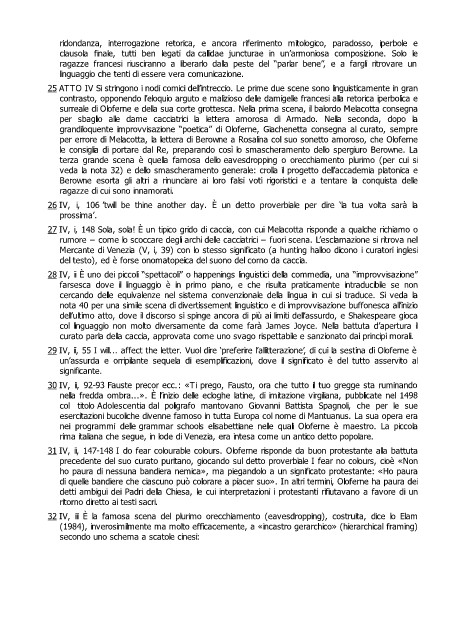Page 2502 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2502
ridondanza, interrogazione retorica, e ancora riferimento mitologico, paradosso, iperbole e
clausola finale, tutti ben legati da callidae juncturae in un’armoniosa composizione. Solo le
ragazze francesi riusciranno a liberarlo dalla peste del “parlar bene”, e a fargli ritrovare un
linguaggio che tenti di essere vera comunicazione.
25 ATTO IV Si stringono i nodi comici dell’intreccio. Le prime due scene sono linguisticamente in gran
contrasto, opponendo l’eloquio arguto e malizioso delle damigelle francesi alla retorica iperbolica e
surreale di Oloferne e della sua corte grottesca. Nella prima scena, il balordo Melacotta consegna
per sbaglio alle dame cacciatrici la lettera amorosa di Armado. Nella seconda, dopo la
grandiloquente improvvisazione “poetica” di Oloferne, Giachenetta consegna al curato, sempre
per errore di Melacotta, la lettera di Berowne a Rosalina col suo sonetto amoroso, che Oloferne
le consiglia di portare dal Re, preparando così lo smascheramento dello spergiuro Berowne. La
terza grande scena è quella famosa dello eavesdropping o orecchiamento plurimo (per cui si
veda la nota 32) e dello smascheramento generale: crolla il progetto dell’accademia platonica e
Berowne esorta gli altri a rinunciare ai loro falsi voti rigoristici e a tentare la conquista delle
ragazze di cui sono innamorati.
26 IV, i, 106 ’twill be thine another day. È un detto proverbiale per dire ‘la tua volta sarà la
prossima’.
27 IV, i, 148 Sola, sola! È un tipico grido di caccia, con cui Melacotta risponde a qualche richiamo o
rumore - come lo scoccare degli archi delle cacciatrici - fuori scena. L’esclamazione si ritrova nel
Mercante di Venezia (V, i, 39) con lo stesso significato (a hunting halloo dicono i curatori inglesi
del testo), ed è forse onomatopeica del suono del corno da caccia.
28 IV, ii È uno dei piccoli “spettacoli” o happenings linguistici della commedia, una “improvvisazione”
farsesca dove il linguaggio è in primo piano, e che risulta praticamente intraducibile se non
cercando delle equivalenze nel sistema convenzionale della lingua in cui si traduce. Si veda la
nota 40 per una simile scena di divertissement linguistico e di improvvisazione buffonesca all’inizio
dell’ultimo atto, dove il discorso si spinge ancora di più ai limiti dell’assurdo, e Shakespeare gioca
col linguaggio non molto diversamente da come farà James Joyce. Nella battuta d’apertura il
curato parla della caccia, approvata come uno svago rispettabile e sanzionato dai principi morali.
29 IV, ii, 55 I will... affect the letter. Vuol dire ‘preferire l’allitterazione’, di cui la sestina di Oloferne è
un’assurda e orripilante sequela di esemplificazioni, dove il significato è del tutto asservito al
significante.
30 IV, ii, 92-93 Fauste precor ecc.: «Ti prego, Fausto, ora che tutto il tuo gregge sta ruminando
nella fredda ombra...». È l’inizio delle ecloghe latine, di imitazione virgiliana, pubblicate nel 1498
col titolo Adolescentia dal poligrafo mantovano Giovanni Battista Spagnoli, che per le sue
esercitazioni bucoliche divenne famoso in tutta Europa col nome di Mantuanus. La sua opera era
nei programmi delle grammar schools elisabettiane nelle quali Oloferne è maestro. La piccola
rima italiana che segue, in lode di Venezia, era intesa come un antico detto popolare.
31 IV, ii, 147-148 I do fear colourable colours. Oloferne risponde da buon protestante alla battuta
precedente del suo curato puritano, giocando sul detto proverbiale I fear no colours, cioè «Non
ho paura di nessuna bandiera nemica», ma piegandolo a un significato protestante: «Ho paura
di quelle bandiere che ciascuno può colorare a piacer suo». In altri termini, Oloferne ha paura dei
detti ambigui dei Padri della Chiesa, le cui interpretazioni i protestanti rifiutavano a favore di un
ritorno diretto ai testi sacri.
32 IV, iii È la famosa scena del plurimo orecchiamento (eavesdropping), costruita, dice lo Elam
(1984), inverosimilmente ma molto efficacemente, a «incastro gerarchico» (hierarchical framing)
secondo uno schema a scatole cinesi: