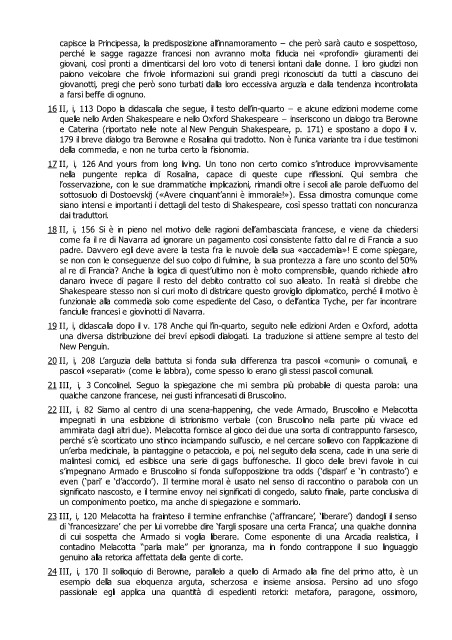Page 2501 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2501
capisce la Principessa, la predisposizione all’innamoramento - che però sarà cauto e sospettoso,
perché le sagge ragazze francesi non avranno molta fiducia nei «profondi» giuramenti dei
giovani, così pronti a dimenticarsi del loro voto di tenersi lontani dalle donne. I loro giudizi non
paiono veicolare che frivole informazioni sui grandi pregi riconosciuti da tutti a ciascuno dei
giovanotti, pregi che però sono turbati dalla loro eccessiva arguzia e dalla tendenza incontrollata
a farsi beffe di ognuno.
16 II, i, 113 Dopo la didascalia che segue, il testo dell’in-quarto - e alcune edizioni moderne come
quelle nello Arden Shakespeare e nello Oxford Shakespeare - inseriscono un dialogo tra Berowne
e Caterina (riportato nelle note al New Penguin Shakespeare, p. 171) e spostano a dopo il v.
179 il breve dialogo tra Berowne e Rosalina qui tradotto. Non è l’unica variante tra i due testimoni
della commedia, e non ne turba certo la fisionomia.
17 II, i, 126 And yours from long living. Un tono non certo comico s’introduce improvvisamente
nella pungente replica di Rosalina, capace di queste cupe riflessioni. Qui sembra che
l’osservazione, con le sue drammatiche implicazioni, rimandi oltre i secoli alle parole dell’uomo del
sottosuolo di Dostoevskij («Avere cinquant’anni è immorale!»). Essa dimostra comunque come
siano intensi e importanti i dettagli del testo di Shakespeare, così spesso trattati con noncuranza
dai traduttori.
18 II, i, 156 Si è in pieno nel motivo delle ragioni dell’ambasciata francese, e viene da chiedersi
come fa il re di Navarra ad ignorare un pagamento così consistente fatto dal re di Francia a suo
padre. Davvero egli deve avere la testa fra le nuvole della sua «accademia»! E come spiegare,
se non con le conseguenze del suo colpo di fulmine, la sua prontezza a fare uno sconto del 50%
al re di Francia? Anche la logica di quest’ultimo non è molto comprensibile, quando richiede altro
danaro invece di pagare il resto del debito contratto col suo alleato. In realtà si direbbe che
Shakespeare stesso non si curi molto di districare questo groviglio diplomatico, perché il motivo è
funzionale alla commedia solo come espediente del Caso, o dell’antica Tyche, per far incontrare
fanciulle francesi e giovinotti di Navarra.
19 II, i, didascalia dopo il v. 178 Anche qui l’in-quarto, seguito nelle edizioni Arden e Oxford, adotta
una diversa distribuzione dei brevi episodi dialogati. La traduzione si attiene sempre al testo del
New Penguin.
20 II, i, 208 L’arguzia della battuta si fonda sulla differenza tra pascoli «comuni» o comunali, e
pascoli «separati» (come le labbra), come spesso lo erano gli stessi pascoli comunali.
21 III, i, 3 Concolinel. Seguo la spiegazione che mi sembra più probabile di questa parola: una
qualche canzone francese, nei gusti infrancesati di Bruscolino.
22 III, i, 82 Siamo al centro di una scena-happening, che vede Armado, Bruscolino e Melacotta
impegnati in una esibizione di istrionismo verbale (con Bruscolino nella parte più vivace ed
ammirata dagli altri due). Melacotta fornisce al gioco dei due una sorta di contrappunto farsesco,
perché s’è scorticato uno stinco inciampando sull’uscio, e nel cercare sollievo con l’applicazione di
un’erba medicinale, la piantaggine o petacciola, e poi, nel seguito della scena, cade in una serie di
malintesi comici, ed esibisce una serie di gags buffonesche. Il gioco delle brevi favole in cui
s’impegnano Armado e Bruscolino si fonda sull’opposizione tra odds (‘dispari’ e ‘in contrasto’) e
even (‘pari’ e ‘d’accordo’). Il termine moral è usato nel senso di raccontino o parabola con un
significato nascosto, e il termine envoy nei significati di congedo, saluto finale, parte conclusiva di
un componimento poetico, ma anche di spiegazione e sommario.
23 III, i, 120 Melacotta ha frainteso il termine enfranchise (‘affrancare’, ‘liberare’) dandogli il senso
di ‘francesizzare’ che per lui vorrebbe dire ‘fargli sposare una certa Franca’, una qualche donnina
di cui sospetta che Armado si voglia liberare. Come esponente di una Arcadia realistica, il
contadino Melacotta “parla male” per ignoranza, ma in fondo contrappone il suo linguaggio
genuino alla retorica affettata della gente di corte.
24 III, i, 170 Il soliloquio di Berowne, parallelo a quello di Armado alla fine del primo atto, è un
esempio della sua eloquenza arguta, scherzosa e insieme ansiosa. Persino ad uno sfogo
passionale egli applica una quantità di espedienti retorici: metafora, paragone, ossimoro,