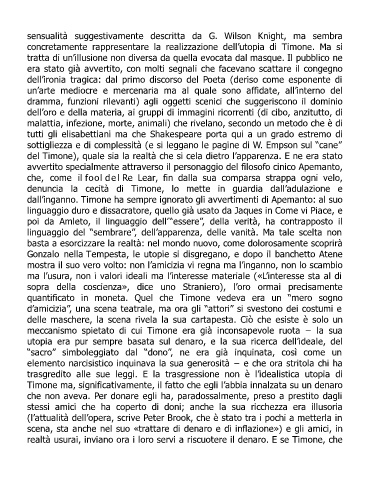Page 2950 - Shakespeare - Vol. 3
P. 2950
sensualità suggestivamente descritta da G. Wilson Knight, ma sembra
concretamente rappresentare la realizzazione dell’utopia di Timone. Ma si
tratta di un’illusione non diversa da quella evocata dal masque. Il pubblico ne
era stato già avvertito, con molti segnali che facevano scattare il congegno
dell’ironia tragica: dal primo discorso del Poeta (deriso come esponente di
un’arte mediocre e mercenaria ma al quale sono affidate, all’interno del
dramma, funzioni rilevanti) agli oggetti scenici che suggeriscono il dominio
dell’oro e della materia, ai gruppi di immagini ricorrenti (di cibo, anzitutto, di
malattia, infezione, morte, animali) che rivelano, secondo un metodo che è di
tutti gli elisabettiani ma che Shakespeare porta qui a un grado estremo di
sottigliezza e di complessità (e si leggano le pagine di W. Empson sul “cane”
del Timone), quale sia la realtà che si cela dietro l’apparenza. E ne era stato
avvertito specialmente attraverso il personaggio del filosofo cinico Apemanto,
che, come il fool del Re Lear, fin dalla sua comparsa strappa ogni velo,
denuncia la cecità di Timone, lo mette in guardia dall’adulazione e
dall’inganno. Timone ha sempre ignorato gli avvertimenti di Apemanto: al suo
linguaggio duro e dissacratore, quello già usato da Jaques in Come vi Piace, e
poi da Amleto, il linguaggio dell’“essere”, della verità, ha contrapposto il
linguaggio del “sembrare”, dell’apparenza, delle vanità. Ma tale scelta non
basta a esorcizzare la realtà: nel mondo nuovo, come dolorosamente scoprirà
Gonzalo nella Tempesta, le utopie si disgregano, e dopo il banchetto Atene
mostra il suo vero volto: non l’amicizia vi regna ma l’inganno, non lo scambio
ma l’usura, non i valori ideali ma l’interesse materiale («L’interesse sta al di
sopra della coscienza», dice uno Straniero), l’oro ormai precisamente
quantificato in moneta. Quel che Timone vedeva era un “mero sogno
d’amicizia”, una scena teatrale, ma ora gli “attori” si svestono dei costumi e
delle maschere, la scena rivela la sua cartapesta. Ciò che esiste è solo un
meccanismo spietato di cui Timone era già inconsapevole ruota − la sua
utopia era pur sempre basata sul denaro, e la sua ricerca dell’ideale, del
“sacro” simboleggiato dal “dono”, ne era già inquinata, così come un
elemento narcisistico inquinava la sua generosità − e che ora stritola chi ha
trasgredito alle sue leggi. E la trasgressione non è l’idealistica utopia di
Timone ma, significativamente, il fatto che egli l’abbia innalzata su un denaro
che non aveva. Per donare egli ha, paradossalmente, preso a prestito dagli
stessi amici che ha coperto di doni; anche la sua ricchezza era illusoria
(l’attualità dell’opera, scrive Peter Brook, che è stato tra i pochi a metterla in
scena, sta anche nel suo «trattare di denaro e di inflazione») e gli amici, in
realtà usurai, inviano ora i loro servi a riscuotere il denaro. E se Timone, che