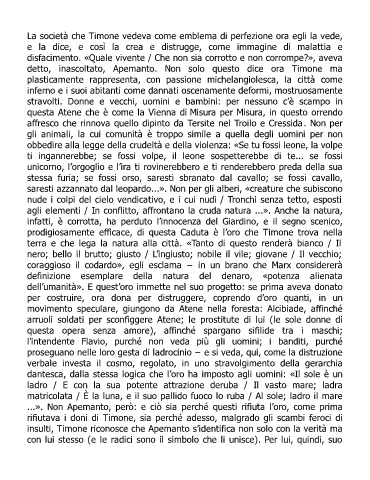Page 2952 - Shakespeare - Vol. 3
P. 2952
La società che Timone vedeva come emblema di perfezione ora egli la vede,
e la dice, e così la crea e distrugge, come immagine di malattia e
disfacimento. «Quale vivente / Che non sia corrotto e non corrompe?», aveva
detto, inascoltato, Apemanto. Non solo questo dice ora Timone ma
plasticamente rappresenta, con passione michelangiolesca, la città come
inferno e i suoi abitanti come dannati oscenamente deformi, mostruosamente
stravolti. Donne e vecchi, uomini e bambini: per nessuno c’è scampo in
questa Atene che è come la Vienna di Misura per Misura, in questo orrendo
affresco che rinnova quello dipinto da Tersite nel Troilo e Cressida. Non per
gli animali, la cui comunità è troppo simile a quella degli uomini per non
obbedire alla legge della crudeltà e della violenza: «Se tu fossi leone, la volpe
ti ingannerebbe; se fossi volpe, il leone sospetterebbe di te... se fossi
unicorno, l’orgoglio e l’ira ti rovinerebbero e ti renderebbero preda della sua
stessa furia; se fossi orso, saresti sbranato dal cavallo; se fossi cavallo,
saresti azzannato dal leopardo...». Non per gli alberi, «creature che subiscono
nude i colpi del cielo vendicativo, e i cui nudi / Tronchi senza tetto, esposti
agli elementi / In conflitto, affrontano la cruda natura ...». Anche la natura,
infatti, è corrotta, ha perduto l’innocenza del Giardino, e il segno scenico,
prodigiosamente efficace, di questa Caduta è l’oro che Timone trova nella
terra e che lega la natura alla città. «Tanto di questo renderà bianco / Il
nero; bello il brutto; giusto / L’ingiusto; nobile il vile; giovane / Il vecchio;
coraggioso il codardo», egli esclama − in un brano che Marx considererà
definizione esemplare della natura del denaro, «potenza alienata
dell’umanità». E quest’oro immette nel suo progetto: se prima aveva donato
per costruire, ora dona per distruggere, coprendo d’oro quanti, in un
movimento speculare, giungono da Atene nella foresta: Alcibiade, affinché
arruoli soldati per sconfiggere Atene; le prostitute di lui (le sole donne di
questa opera senza amore), affinché spargano sifilide tra i maschi;
l’intendente Flavio, purché non veda più gli uomini; i banditi, purché
proseguano nelle loro gesta di ladrocinio − e si veda, qui, come la distruzione
verbale investa il cosmo, regolato, in uno stravolgimento della gerarchia
dantesca, dalla stessa logica che l’oro ha imposto agli uomini: «Il sole è un
ladro / E con la sua potente attrazione deruba / Il vasto mare; ladra
matricolata / È la luna, e il suo pallido fuoco lo ruba / Al sole; ladro il mare
...». Non Apemanto, però: e ciò sia perché questi rifiuta l’oro, come prima
rifiutava i doni di Timone, sia perché adesso, malgrado gli scambi feroci di
insulti, Timone riconosce che Apemanto s’identifica non solo con la verità ma
con lui stesso (e le radici sono il simbolo che li unisce). Per lui, quindi, suo