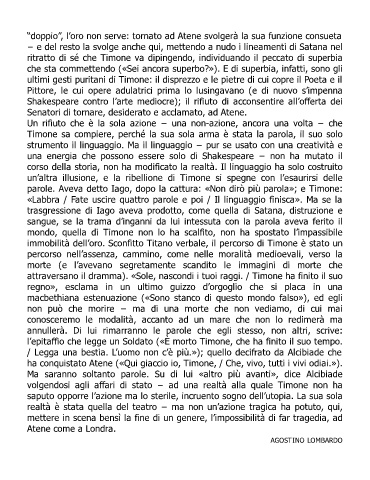Page 2953 - Shakespeare - Vol. 3
P. 2953
“doppio”, l’oro non serve: tornato ad Atene svolgerà la sua funzione consueta
− e del resto la svolge anche qui, mettendo a nudo i lineamenti di Satana nel
ritratto di sé che Timone va dipingendo, individuando il peccato di superbia
che sta commettendo («Sei ancora superbo?»). E di superbia, infatti, sono gli
ultimi gesti puritani di Timone: il disprezzo e le pietre di cui copre il Poeta e il
Pittore, le cui opere adulatrici prima lo lusingavano (e di nuovo s’impenna
Shakespeare contro l’arte mediocre); il rifiuto di acconsentire all’offerta dei
Senatori di tornare, desiderato e acclamato, ad Atene.
Un rifiuto che è la sola azione − una non-azione, ancora una volta − che
Timone sa compiere, perché la sua sola arma è stata la parola, il suo solo
strumento il linguaggio. Ma il linguaggio − pur se usato con una creatività e
una energia che possono essere solo di Shakespeare − non ha mutato il
corso della storia, non ha modificato la realtà. Il linguaggio ha solo costruito
un’altra illusione, e la ribellione di Timone si spegne con l’esaurirsi delle
parole. Aveva detto Iago, dopo la cattura: «Non dirò più parola»; e Timone:
«Labbra / Fate uscire quattro parole e poi / Il linguaggio finisca». Ma se la
trasgressione di Iago aveva prodotto, come quella di Satana, distruzione e
sangue, se la trama d’inganni da lui intessuta con la parola aveva ferito il
mondo, quella di Timone non lo ha scalfito, non ha spostato l’impassibile
immobilità dell’oro. Sconfitto Titano verbale, il percorso di Timone è stato un
percorso nell’assenza, cammino, come nelle moralità medioevali, verso la
morte (e l’avevano segretamente scandito le immagini di morte che
attraversano il dramma). «Sole, nascondi i tuoi raggi. / Timone ha finito il suo
regno», esclama in un ultimo guizzo d’orgoglio che si placa in una
macbethiana estenuazione («Sono stanco di questo mondo falso»), ed egli
non può che morire − ma di una morte che non vediamo, di cui mai
conosceremo le modalità, accanto ad un mare che non lo redimerà ma
annullerà. Di lui rimarranno le parole che egli stesso, non altri, scrive:
l’epitaffio che legge un Soldato («È morto Timone, che ha finito il suo tempo.
/ Legga una bestia. L’uomo non c’è più.»); quello decifrato da Alcibiade che
ha conquistato Atene («Qui giaccio io, Timone, / Che, vivo, tutti i vivi odiai.»).
Ma saranno soltanto parole. Su di lui «altro più avanti», dice Alcibiade
volgendosi agli affari di stato − ad una realtà alla quale Timone non ha
saputo opporre l’azione ma lo sterile, incruento sogno dell’utopia. La sua sola
realtà è stata quella del teatro − ma non un’azione tragica ha potuto, qui,
mettere in scena bensì la fine di un genere, l’impossibilità di far tragedia, ad
Atene come a Londra.
AGOSTINO LOMBARDO