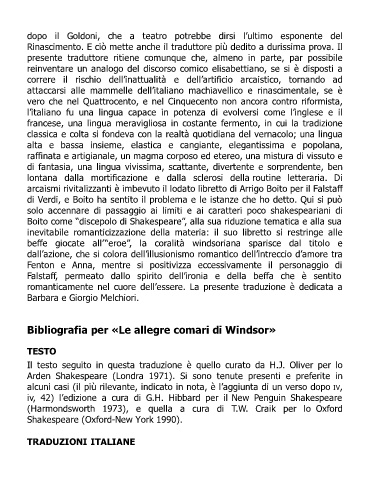Page 2310 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2310
dopo il Goldoni, che a teatro potrebbe dirsi l’ultimo esponente del
Rinascimento. E ciò mette anche il traduttore più dedito a durissima prova. Il
presente traduttore ritiene comunque che, almeno in parte, par possibile
reinventare un analogo del discorso comico elisabettiano, se si è disposti a
correre il rischio dell’inattualità e dell’artificio arcaistico, tornando ad
attaccarsi alle mammelle dell’italiano machiavellico e rinascimentale, se è
vero che nel Quattrocento, e nel Cinquecento non ancora contro riformista,
l’italiano fu una lingua capace in potenza di evolversi come l’inglese e il
francese, una lingua meravigliosa in costante fermento, in cui la tradizione
classica e colta si fondeva con la realtà quotidiana del vernacolo; una lingua
alta e bassa insieme, elastica e cangiante, elegantissima e popolana,
raffinata e artigianale, un magma corposo ed etereo, una mistura di vissuto e
di fantasia, una lingua vivissima, scattante, divertente e sorprendente, ben
lontana dalla mortificazione e dalla sclerosi della routine letteraria. Di
arcaismi rivitalizzanti è imbevuto il lodato libretto di Arrigo Boito per il Falstaff
di Verdi, e Boito ha sentito il problema e le istanze che ho detto. Qui si può
solo accennare di passaggio ai limiti e ai caratteri poco shakespeariani di
Boito come “discepolo di Shakespeare”, alla sua riduzione tematica e alla sua
inevitabile romanticizzazione della materia: il suo libretto si restringe alle
beffe giocate all’“eroe”, la coralità windsoriana sparisce dal titolo e
dall’azione, che si colora dell’illusionismo romantico dell’intreccio d’amore tra
Fenton e Anna, mentre si positivizza eccessivamente il personaggio di
Falstaff, permeato dallo spirito dell’ironia e della beffa che è sentito
romanticamente nel cuore dell’essere. La presente traduzione è dedicata a
Barbara e Giorgio Melchiori.
Bibliografia per «Le allegre comari di Windsor»
TESTO
Il testo seguito in questa traduzione è quello curato da H.J. Oliver per lo
Arden Shakespeare (Londra 1971). Si sono tenute presenti e preferite in
alcuni casi (il più rilevante, indicato in nota, è l’aggiunta di un verso dopo IV,
iv, 42) l’edizione a cura di G.H. Hibbard per il New Penguin Shakespeare
(Harmondsworth 1973), e quella a cura di T.W. Craik per lo Oxford
Shakespeare (Oxford-New York 1990).
TRADUZIONI ITALIANE