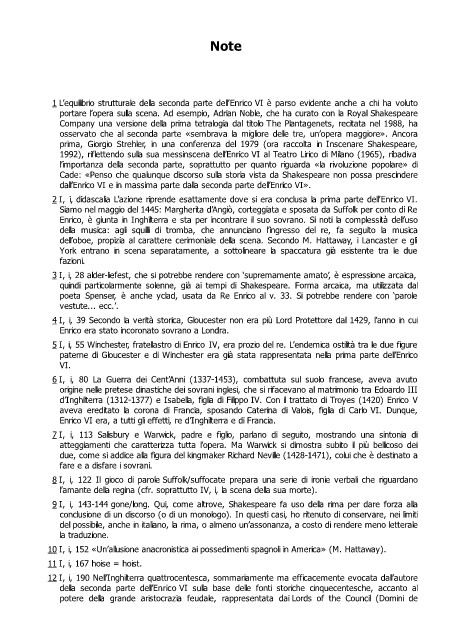Page 617 - Shakespeare - Vol. 1
P. 617
Note
1 L’equilibrio strutturale della seconda parte dell’Enrico VI è parso evidente anche a chi ha voluto
portare l’opera sulla scena. Ad esempio, Adrian Noble, che ha curato con la Royal Shakespeare
Company una versione della prima tetralogia dal titolo The Plantagenets, recitata nel 1988, ha
osservato che al seconda parte «sembrava la migliore delle tre, un’opera maggiore». Ancora
prima, Giorgio Strehler, in una conferenza del 1979 (ora raccolta in Inscenare Shakespeare,
1992), riflettendo sulla sua messinscena dell’Enrico VI al Teatro Lirico di Milano (1965), ribadiva
l’importanza della seconda parte, soprattutto per quanto riguarda «la rivoluzione popolare» di
Cade: «Penso che qualunque discorso sulla storia vista da Shakespeare non possa prescindere
dall’Enrico VI e in massima parte dalla seconda parte dell’Enrico VI».
2 I, i, didascalia L’azione riprende esattamente dove si era conclusa la prima parte dell’Enrico VI.
Siamo nel maggio del 1445: Margherita d’Angiò, corteggiata e sposata da Suffolk per conto di Re
Enrico, è giunta in Inghilterra e sta per incontrare il suo sovrano. Si noti la complessità dell’uso
della musica: agli squilli di tromba, che annunciano l’ingresso del re, fa seguito la musica
dell’oboe, propizia al carattere cerimoniale della scena. Secondo M. Hattaway, i Lancaster e gli
York entrano in scena separatamente, a sottolineare la spaccatura già esistente tra le due
fazioni.
3 I, i, 28 alder-liefest, che si potrebbe rendere con ‘supremamente amato’, è espressione arcaica,
quindi particolarmente solenne, già ai tempi di Shakespeare. Forma arcaica, ma utilizzata dal
poeta Spenser, è anche yclad, usata da Re Enrico al v. 33. Si potrebbe rendere con ‘parole
vestute... ecc.’.
4 I, i, 39 Secondo la verità storica, Gloucester non era più Lord Protettore dal 1429, l’anno in cui
Enrico era stato incoronato sovrano a Londra.
5 I, i, 55 Winchester, fratellastro di Enrico IV, era prozio del re. L’endemica ostilità tra le due figure
paterne di Gloucester e di Winchester era già stata rappresentata nella prima parte dell’Enrico
VI.
6 I, i, 80 La Guerra dei Cent’Anni (1337-1453), combattuta sul suolo francese, aveva avuto
origine nelle pretese dinastiche dei sovrani inglesi, che si rifacevano al matrimonio tra Edoardo III
d’Inghilterra (1312-1377) e Isabella, figlia di Filippo IV. Con il trattato di Troyes (1420) Enrico V
aveva ereditato la corona di Francia, sposando Caterina di Valois, figlia di Carlo VI. Dunque,
Enrico VI era, a tutti gli effetti, re d’Inghilterra e di Francia.
7 I, i, 113 Salisbury e Warwick, padre e figlio, parlano di seguito, mostrando una sintonia di
atteggiamenti che caratterizza tutta l’opera. Ma Warwick si dimostra subito il più bellicoso dei
due, come si addice alla figura del kingmaker Richard Neville (1428-1471), colui che è destinato a
fare e a disfare i sovrani.
8 I, i, 122 Il gioco di parole Suffolk/suffocate prepara una serie di ironie verbali che riguardano
l’amante della regina (cfr. soprattutto IV, i, la scena della sua morte).
9 I, i, 143-144 gone/long. Qui, come altrove, Shakespeare fa uso della rima per dare forza alla
conclusione di un discorso (o di un monologo). In questi casi, ho ritenuto di conservare, nei limiti
del possibile, anche in italiano, la rima, o almeno un’assonanza, a costo di rendere meno letterale
la traduzione.
10 I, i, 152 «Un’allusione anacronistica ai possedimenti spagnoli in America» (M. Hattaway).
11 I, i, 167 hoise = hoist.
12 I, i, 190 Nell’Inghilterra quattrocentesca, sommariamente ma efficacemente evocata dall’autore
della seconda parte dell’Enrico VI sulla base delle fonti storiche cinquecentesche, accanto al
potere della grande aristocrazia feudale, rappresentata dai Lords of the Council (Domini de