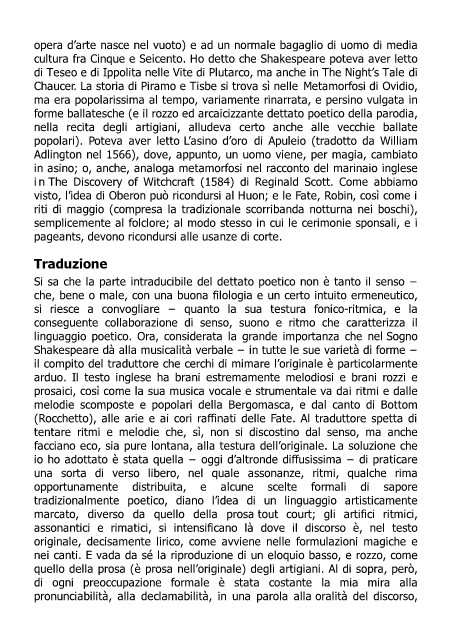Page 2536 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2536
opera d’arte nasce nel vuoto) e ad un normale bagaglio di uomo di media
cultura fra Cinque e Seicento. Ho detto che Shakespeare poteva aver letto
di Teseo e di Ippolita nelle Vite di Plutarco, ma anche in The Night’s Tale di
Chaucer. La storia di Piramo e Tisbe si trova sì nelle Metamorfosi di Ovidio,
ma era popolarissima al tempo, variamente rinarrata, e persino vulgata in
forme ballatesche (e il rozzo ed arcaicizzante dettato poetico della parodia,
nella recita degli artigiani, alludeva certo anche alle vecchie ballate
popolari). Poteva aver letto L’asino d’oro di Apuleio (tradotto da William
Adlington nel 1566), dove, appunto, un uomo viene, per magia, cambiato
in asino; o, anche, analoga metamorfosi nel racconto del marinaio inglese
i n The Discovery of Witchcraft (1584) di Reginald Scott. Come abbiamo
visto, l’idea di Oberon può ricondursi al Huon; e le Fate, Robin, così come i
riti di maggio (compresa la tradizionale scorribanda notturna nei boschi),
semplicemente al folclore; al modo stesso in cui le cerimonie sponsali, e i
pageants, devono ricondursi alle usanze di corte.
Traduzione
Si sa che la parte intraducibile del dettato poetico non è tanto il senso -
che, bene o male, con una buona filologia e un certo intuito ermeneutico,
si riesce a convogliare - quanto la sua testura fonico-ritmica, e la
conseguente collaborazione di senso, suono e ritmo che caratterizza il
linguaggio poetico. Ora, considerata la grande importanza che nel Sogno
Shakespeare dà alla musicalità verbale - in tutte le sue varietà di forme -
il compito del traduttore che cerchi di mimare l’originale è particolarmente
arduo. Il testo inglese ha brani estremamente melodiosi e brani rozzi e
prosaici, così come la sua musica vocale e strumentale va dai ritmi e dalle
melodie scomposte e popolari della Bergomasca, e dal canto di Bottom
(Rocchetto), alle arie e ai cori raffinati delle Fate. Al traduttore spetta di
tentare ritmi e melodie che, sì, non si discostino dal senso, ma anche
facciano eco, sia pure lontana, alla testura dell’originale. La soluzione che
io ho adottato è stata quella - oggi d’altronde diffusissima - di praticare
una sorta di verso libero, nel quale assonanze, ritmi, qualche rima
opportunamente distribuita, e alcune scelte formali di sapore
tradizionalmente poetico, diano l’idea di un linguaggio artisticamente
marcato, diverso da quello della prosa tout court; gli artifici ritmici,
assonantici e rimatici, si intensificano là dove il discorso è, nel testo
originale, decisamente lirico, come avviene nelle formulazioni magiche e
nei canti. E vada da sé la riproduzione di un eloquio basso, e rozzo, come
quello della prosa (è prosa nell’originale) degli artigiani. Al di sopra, però,
di ogni preoccupazione formale è stata costante la mia mira alla
pronunciabilità, alla declamabilità, in una parola alla oralità del discorso,