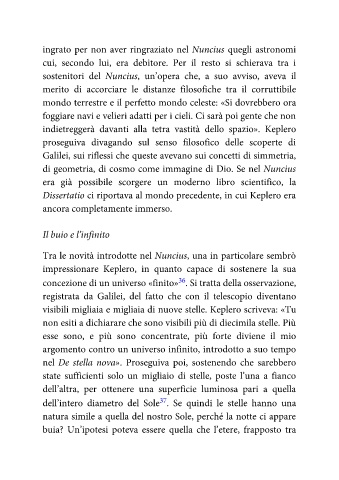Page 158 - Keplero. Una biografia scientifica
P. 158
ingrato per non aver ringraziato nel Nuncius quegli astronomi
cui, secondo lui, era debitore. Per il resto si schierava tra i
sostenitori del Nuncius, un’opera che, a suo avviso, aveva il
merito di accorciare le distanze filosofiche tra il corruttibile
mondo terrestre e il perfetto mondo celeste: «Si dovrebbero ora
foggiare navi e velieri adatti per i cieli. Ci sarà poi gente che non
indietreggerà davanti alla tetra vastità dello spazio». Keplero
proseguiva divagando sul senso filosofico delle scoperte di
Galilei, sui riflessi che queste avevano sui concetti di simmetria,
di geometria, di cosmo come immagine di Dio. Se nel Nuncius
era già possibile scorgere un moderno libro scientifico, la
Dissertatio ci riportava al mondo precedente, in cui Keplero era
ancora completamente immerso.
Il buio e l’infinito
Tra le novità introdotte nel Nuncius, una in particolare sembrò
impressionare Keplero, in quanto capace di sostenere la sua
36
concezione di un universo «finito» . Si tratta della osservazione,
registrata da Galilei, del fatto che con il telescopio diventano
visibili migliaia e migliaia di nuove stelle. Keplero scriveva: «Tu
non esiti a dichiarare che sono visibili più di diecimila stelle. Più
esse sono, e più sono concentrate, più forte diviene il mio
argomento contro un universo infinito, introdotto a suo tempo
nel De stella nova». Proseguiva poi, sostenendo che sarebbero
state sufficienti solo un migliaio di stelle, poste l’una a fianco
dell’altra, per ottenere una superficie luminosa pari a quella
37
dell’intero diametro del Sole . Se quindi le stelle hanno una
natura simile a quella del nostro Sole, perché la notte ci appare
buia? Un’ipotesi poteva essere quella che l’etere, frapposto tra