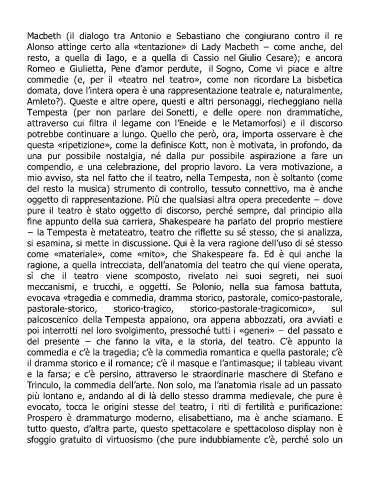Page 885 - Shakespeare - Vol. 4
P. 885
Macbeth (il dialogo tra Antonio e Sebastiano che congiurano contro il re
Alonso attinge certo alla «tentazione» di Lady Macbeth − come anche, del
resto, a quella di Iago, e a quella di Cassio nel Giulio Cesare); e ancora
Romeo e Giulietta, Pene d’amor perdute, il Sogno, Come vi piace e altre
commedie (e, per il «teatro nel teatro», come non ricordare La bisbetica
domata, dove l’intera opera è una rappresentazione teatrale e, naturalmente,
Amleto?). Queste e altre opere, questi e altri personaggi, riecheggiano nella
Tempesta (per non parlare dei Sonetti, e delle opere non drammatiche,
attraverso cui filtra il legame con l’Eneide e le Metamorfosi) e il discorso
potrebbe continuare a lungo. Quello che però, ora, importa osservare è che
questa «ripetizione», come la definisce Kott, non è motivata, in profondo, da
una pur possibile nostalgia, né dalla pur possibile aspirazione a fare un
compendio, e una celebrazione, del proprio lavoro. La vera motivazione, a
mio avviso, sta nel fatto che il teatro, nella Tempesta, non è soltanto (come
del resto la musica) strumento di controllo, tessuto connettivo, ma è anche
oggetto di rappresentazione. Più che qualsiasi altra opera precedente − dove
pure il teatro è stato oggetto di discorso, perché sempre, dal principio alla
fine appunto della sua carriera, Shakespeare ha parlato del proprio mestiere
− la Tempesta è metateatro, teatro che riflette su sé stesso, che si analizza,
si esamina, si mette in discussione. Qui è la vera ragione dell’uso di sé stesso
come «materiale», come «mito», che Shakespeare fa. Ed è qui anche la
ragione, a quella intrecciata, dell’anatomia del teatro che qui viene operata,
sì che il teatro viene scomposto, rivelato nei suoi segreti, nei suoi
meccanismi, e trucchi, e oggetti. Se Polonio, nella sua famosa battuta,
evocava «tragedia e commedia, dramma storico, pastorale, comico-pastorale,
pastorale-storico, storico-tragico, storico-pastorale-tragicomico», sul
palcoscenico della Tempesta appaiono, ora appena abbozzati, ora avviati e
poi interrotti nel loro svolgimento, pressoché tutti i «generi» − del passato e
del presente − che fanno la vita, e la storia, del teatro. C’è appunto la
commedia e c’è la tragedia; c’è la commedia romantica e quella pastorale; c’è
il dramma storico e il romance; c’è il masque e l’antimasque; il tableau vivant
e la farsa; e c’è persino, attraverso le straordinarie maschere di Stefano e
Trinculo, la commedia dell’arte. Non solo, ma l’anatomia risale ad un passato
più lontano e, andando al di là dello stesso dramma medievale, che pure è
evocato, tocca le origini stesse del teatro, i riti di fertilità e purificazione:
Prospero è drammaturgo moderno, elisabettiano, ma è anche sciamano. E
tutto questo, d’altra parte, questo spettacolare e spettacoloso display non è
sfoggio gratuito di virtuosismo (che pure indubbiamente c’è, perché solo un