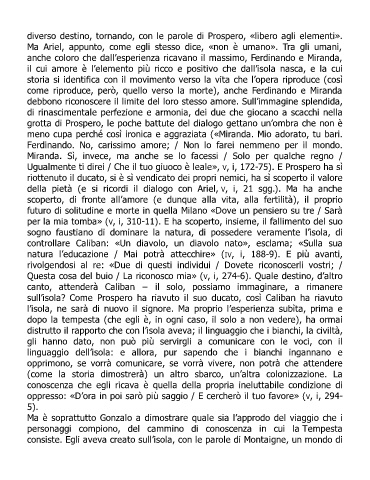Page 890 - Shakespeare - Vol. 4
P. 890
diverso destino, tornando, con le parole di Prospero, «libero agli elementi».
Ma Ariel, appunto, come egli stesso dice, «non è umano». Tra gli umani,
anche coloro che dall’esperienza ricavano il massimo, Ferdinando e Miranda,
il cui amore è l’elemento più ricco e positivo che dall’isola nasca, e la cui
storia si identifica con il movimento verso la vita che l’opera riproduce (così
come riproduce, però, quello verso la morte), anche Ferdinando e Miranda
debbono riconoscere il limite del loro stesso amore. Sull’immagine splendida,
di rinascimentale perfezione e armonia, dei due che giocano a scacchi nella
grotta di Prospero, le poche battute del dialogo gettano un’ombra che non è
meno cupa perché così ironica e aggraziata («Miranda. Mio adorato, tu bari.
Ferdinando. No, carissimo amore; / Non lo farei nemmeno per il mondo.
Miranda. Sì, invece, ma anche se lo facessi / Solo per qualche regno /
Ugualmente ti direi / Che il tuo giuoco è leale», V, i, 172-75). E Prospero ha sì
riottenuto il ducato, si è sì vendicato dei propri nemici, ha sì scoperto il valore
della pietà (e si ricordi il dialogo con Ariel, V, i, 21 sgg.). Ma ha anche
scoperto, di fronte all’amore (e dunque alla vita, alla fertilità), il proprio
futuro di solitudine e morte in quella Milano «Dove un pensiero su tre / Sarà
per la mia tomba» (V, i, 310-11). E ha scoperto, insieme, il fallimento del suo
sogno faustiano di dominare la natura, di possedere veramente l’isola, di
controllare Caliban: «Un diavolo, un diavolo nato», esclama; «Sulla sua
natura l’educazione / Mai potrà attecchire» (IV, i, 188-9). E più avanti,
rivolgendosi al re: «Due di questi individui / Dovete riconoscerli vostri; /
Questa cosa del buio / La riconosco mia» (V, i, 274-6). Quale destino, d’altro
canto, attenderà Caliban − il solo, possiamo immaginare, a rimanere
sull’isola? Come Prospero ha riavuto il suo ducato, così Caliban ha riavuto
l’isola, ne sarà di nuovo il signore. Ma proprio l’esperienza subìta, prima e
dopo la tempesta (che egli è, in ogni caso, il solo a non vedere), ha ormai
distrutto il rapporto che con l’isola aveva; il linguaggio che i bianchi, la civiltà,
gli hanno dato, non può più servirgli a comunicare con le voci, con il
linguaggio dell’isola: e allora, pur sapendo che i bianchi ingannano e
opprimono, se vorrà comunicare, se vorrà vivere, non potrà che attendere
(come la storia dimostrerà) un altro sbarco, un’altra colonizzazione. La
conoscenza che egli ricava è quella della propria ineluttabile condizione di
oppresso: «D’ora in poi sarò più saggio / E cercherò il tuo favore» (V, i, 294-
5).
Ma è soprattutto Gonzalo a dimostrare quale sia l’approdo del viaggio che i
personaggi compiono, del cammino di conoscenza in cui la Tempesta
consiste. Egli aveva creato sull’isola, con le parole di Montaigne, un mondo di