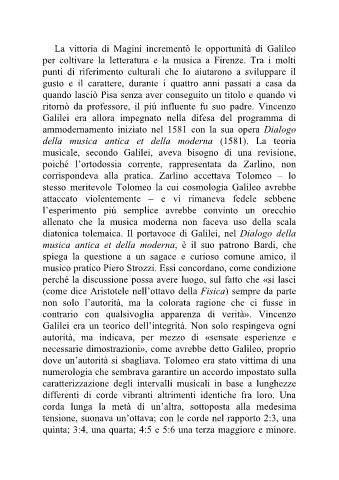Page 31 - Galileo. Scienziato e umanista.
P. 31
La vittoria di Magini incrementò le opportunità di Galileo
per coltivare la letteratura e la musica a Firenze. Tra i molti
punti di riferimento culturali che lo aiutarono a sviluppare il
gusto e il carattere, durante i quattro anni passati a casa da
quando lasciò Pisa senza aver conseguito un titolo e quando vi
ritornò da professore, il piú influente fu suo padre. Vincenzo
Galilei era allora impegnato nella difesa del programma di
ammodernamento iniziato nel 1581 con la sua opera Dialogo
della musica antica et della moderna (1581). La teoria
musicale, secondo Galilei, aveva bisogno di una revisione,
poiché l’ortodossia corrente, rappresentata da Zarlino, non
corrispondeva alla pratica. Zarlino accettava Tolomeo – lo
stesso meritevole Tolomeo la cui cosmologia Galileo avrebbe
attaccato violentemente – e vi rimaneva fedele sebbene
l’esperimento piú semplice avrebbe convinto un orecchio
allenato che la musica moderna non faceva uso della scala
diatonica tolemaica. Il portavoce di Galilei, nel Dialogo della
musica antica et della moderna, è il suo patrono Bardi, che
spiega la questione a un sagace e curioso comune amico, il
musico pratico Piero Strozzi. Essi concordano, come condizione
perché la discussione possa avere luogo, sul fatto che «si lasci
(come dice Aristotele nell’ottavo della Fisica) sempre da parte
non solo l’autorità, ma la colorata ragione che ci fusse in
contrario con qualsivoglia apparenza di verità». Vincenzo
Galilei era un teorico dell’integrità. Non solo respingeva ogni
autorità, ma indicava, per mezzo di «sensate esperienze e
necessarie dimostrazioni», come avrebbe detto Galileo, proprio
dove un’autorità si sbagliava. Tolomeo era stato vittima di una
numerologia che sembrava garantire un accordo impostato sulla
caratterizzazione degli intervalli musicali in base a lunghezze
differenti di corde vibranti altrimenti identiche fra loro. Una
corda lunga la metà di un’altra, sottoposta alla medesima
tensione, suonava un’ottava; con le corde nel rapporto 2:3, una
quinta; 3:4, una quarta; 4:5 e 5:6 una terza maggiore e minore.