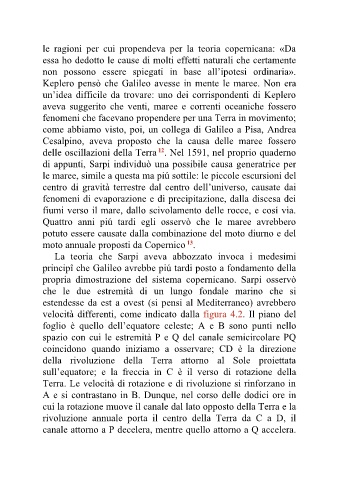Page 185 - Galileo. Scienziato e umanista.
P. 185
le ragioni per cui propendeva per la teoria copernicana: «Da
essa ho dedotto le cause di molti effetti naturali che certamente
non possono essere spiegati in base all’ipotesi ordinaria».
Keplero pensò che Galileo avesse in mente le maree. Non era
un’idea difficile da trovare: uno dei corrispondenti di Keplero
aveva suggerito che venti, maree e correnti oceaniche fossero
fenomeni che facevano propendere per una Terra in movimento;
come abbiamo visto, poi, un collega di Galileo a Pisa, Andrea
Cesalpino, aveva proposto che la causa delle maree fossero
12
delle oscillazioni della Terra . Nel 1591, nel proprio quaderno
di appunti, Sarpi individuò una possibile causa generatrice per
le maree, simile a questa ma piú sottile: le piccole escursioni del
centro di gravità terrestre dal centro dell’universo, causate dai
fenomeni di evaporazione e di precipitazione, dalla discesa dei
fiumi verso il mare, dallo scivolamento delle rocce, e cosí via.
Quattro anni piú tardi egli osservò che le maree avrebbero
potuto essere causate dalla combinazione del moto diurno e del
13
moto annuale proposti da Copernico .
La teoria che Sarpi aveva abbozzato invoca i medesimi
principî che Galileo avrebbe piú tardi posto a fondamento della
propria dimostrazione del sistema copernicano. Sarpi osservò
che le due estremità di un lungo fondale marino che si
estendesse da est a ovest (si pensi al Mediterraneo) avrebbero
velocità differenti, come indicato dalla figura 4.2. Il piano del
foglio è quello dell’equatore celeste; A e B sono punti nello
spazio con cui le estremità P e Q del canale semicircolare PQ
coincidono quando iniziamo a osservare; CD è la direzione
della rivoluzione della Terra attorno al Sole proiettata
sull’equatore; e la freccia in C è il verso di rotazione della
Terra. Le velocità di rotazione e di rivoluzione si rinforzano in
A e si contrastano in B. Dunque, nel corso delle dodici ore in
cui la rotazione muove il canale dal lato opposto della Terra e la
rivoluzione annuale porta il centro della Terra da C a D, il
canale attorno a P decelera, mentre quello attorno a Q accelera.