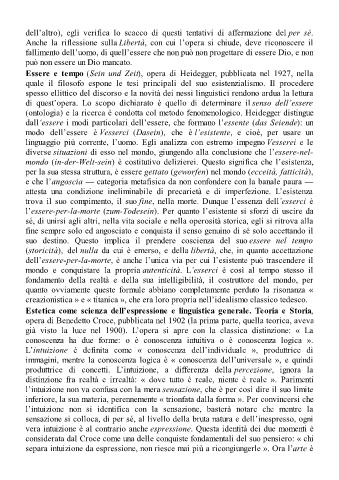Page 919 - Dizionario di Filosofia
P. 919
dell’altro), egli verifica lo scacco di questi tentativi di affermazione del per sé.
Anche la riflessione sulla Libertà, con cui l’opera si chiude, deve riconoscere il
fallimento dell’uomo, di quell’essere che non può non progettare di essere Dio, e non
può non essere un Dio mancato.
Essere e tempo (Sein und Zeit), opera di Heidegger, pubblicata nel 1927, nella
quale il filosofo espone le tesi principali del suo esistenzialismo. Il procedere
spesso ellittico del discorso e la novità dei nessi linguistici rendono ardua la lettura
di quest’opera. Lo scopo dichiarato è quello di determinare il senso dell’essere
(ontologia) e la ricerca è condotta col metodo fenomenologico. Heidegger distingue
dall‘essere i modi particolari dell’essere, che formano l’essente (das Seiende): un
modo dell’essere è Vesserci (Dasein), che è l’esistente, e cioè, per usare un
linguaggio più corrente, l’uomo. Egli analizza con estremo impegno Vesserei e le
diverse situazioni di esso nel mondo, giungendo alla conclusione che l’essere-nel-
mondo (in-der-Welt-sein) è costitutivo delizierei. Questo significa che l’esistenza,
per la sua stessa struttura, è essere gettato (geworfen) nel mondo (ecceità, fatticità),
e che l’angoscia — categoria metafisica da non confondere con la banale paura —
attesta una condizione ineliminabile di precarietà e di imperfezione. L’esistenza
trova il suo compimento, il suo fine, nella morte. Dunque l’essenza dell’esserci è
l’essere-per-la-morte (zum-Todesein). Per quanto l’esistente si sforzi di uscire da
sé, di unirsi agli altri, nella vita sociale e nella operosità storica, egli si ritrova alla
fine sempre solo ed angosciato e conquista il senso genuino di sé solo accettando il
suo destino. Questo implica il prendere coscienza del suo essere nel tempo
(storicità), del nulla da cui è emerso, e della libertà, che, in quanto accettazione
dell’essere-per-la-morte, è anche l’unica via per cui l’esistente può trascendere il
mondo e conquistare la propria autenticità. L’esserci è così al tempo stesso il
fondamento della realtà e della sua intelligibilità, il costruttore del mondo, per
quanto ovviamente queste formule abbiano completamente perduto la risonanza «
creazionistica » e « titanica », che era loro propria nell’idealismo classico tedesco.
Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale. Teoria e Storia,
opera di Benedetto Croce, pubblicata nel 1902 (la prima parte, quella teorica, aveva
già visto la luce nel 1900). L’opera si apre con la classica distinzione: « La
conoscenza ha due forme: o è conoscenza intuitiva o è conoscenza logica ».
L’intuizione è definita come « conoscenza dell’individuale », produttrice di
immagini, mentre la conoscenza logica è « conoscenza dell’universale », e quindi
produttrice di concetti. L’intuizione, a differenza della percezione, ignora la
distinzione fra realtà e irrealtà: « dove tutto è reale, niente è reale ». Parimenti
l’intuizione non va confusa con la mera sensazione, che è per così dire il suo limite
inferiore, la sua materia, perennemente « trionfata dalla forma ». Per convincersi che
l’intuizione non si identifica con la sensazione, basterà notare che mentre la
sensazione si colloca, di per sé, al livello della bruta natura e dell’inespresso, ogni
vera intuizione è al contrario anche espressione. Questa identità dei due momenti è
considerata dal Croce come una delle conquiste fondamentali del suo pensiero: « chi
separa intuizione da espressione, non riesce mai più a ricongiungerle ». Ora l’arte è