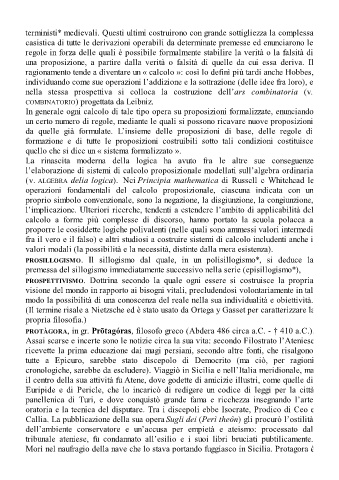Page 678 - Dizionario di Filosofia
P. 678
terministi* medievali. Questi ultimi costruirono con grande sottigliezza la complessa
casistica di tutte le derivazioni operabili da determinate premesse ed enunciarono le
regole in forza delle quali è possibile formalmente stabilire la verità o la falsità di
una proposizione, a partire dalla verità o falsità di quelle da cui essa deriva. Il
ragionamento tende a diventare un « calcolo »: così lo definì più tardi anche Hobbes,
individuando come sue operazioni l’addizione e la sottrazione (delle idee fra loro), e
nella stessa prospettiva si colloca la costruzione dell’ars combinatoria (v.
COMBINATORIO) progettata da Leibniz.
In generale ogni calcolo di tale tipo opera su proposizioni formalizzate, enunciando
un certo numero di regole, mediante le quali si possono ricavare nuove proposizioni
da quelle già formulate. L’insieme delle proposizioni di base, delle regole di
formazione e di tutte le proposizioni costruibili sotto tali condizioni costituisce
quello che si dice un « sistema formalizzato ».
La rinascita moderna della logica ha avuto fra le altre sue conseguenze
l’elaborazione di sistemi di calcolo proposizionale modellati sull’algebra ordinaria
(v. ALGEBRA delia logica). Nei Principia mathematica di Russell e Whitehead le
operazioni fondamentali del calcolo proposizionale, ciascuna indicata con un
proprio simbolo convenzionale, sono la negazione, la disgiunzione, la congiunzione,
l’implicazione. Ulteriori ricerche, tendenti a estendere l’ambito di applicabilità del
calcolo a forme più complesse di discorso, hanno portato la scuola polacca a
proporre le cosiddette logiche polivalenti (nelle quali sono ammessi valori intermedi
fra il vero e il falso) e altri studiosi a costruire sistemi di calcolo includenti anche i
valori modali (la possibilità e la necessità, distinte dalla mera esistenza).
PROSILLOGISMO. Il sillogismo dal quale, in un polisillogismo*, si deduce la
premessa del sillogismo immediatamente successivo nella serie (episillogismo*),
PROSPETTIVISMO. Dottrina secondo la quale ogni essere si costruisce la propria
visione del mondo in rapporto ai bisogni vitali, precludendosi volontariamente in tal
modo la possibilità di una conoscenza del reale nella sua individualità e obiettività.
(Il termine risale a Nietzsche ed è stato usato da Ortega y Gasset per caratterizzare la
propria filosofia.)
PROTÀGORA, in gr. Prōtagóras, filosofo greco (Abdera 486 circa a.C. - † 410 a.C.).
Assai scarse e incerte sono le notizie circa la sua vita: secondo Filostrato l’Ateniese
ricevette la prima educazione dai magi persiani, secondo altre fonti, che risalgono
tutte a Epicuro, sarebbe stato discepolo di Democrito (ma ciò, per ragioni
cronologiche, sarebbe da escludere). Viaggiò in Sicilia e nell’Italia meridionale, ma
il centro della sua attività fu Atene, dove godette di amicizie illustri, come quelle di
Euripide e di Pericle, che lo incaricò di redigere un codice di leggi per la città
panellenica di Turi, e dove conquistò grande fama e ricchezza insegnando l’arte
oratoria e la tecnica del disputare. Tra i discepoli ebbe Isocrate, Prodico di Ceo e
Callia. La pubblicazione della sua opera Sugli dei (Perì theôn) gli procurò l’ostilità
dell’ambiente conservatore e un’accusa per empietà e ateismo: processato dal
tribunale ateniese, fu condannato all’esilio e i suoi libri bruciati pubtilicamente.
Morì nel naufragio della nave che lo stava portando fuggiasco in Sicilia. Protagora è