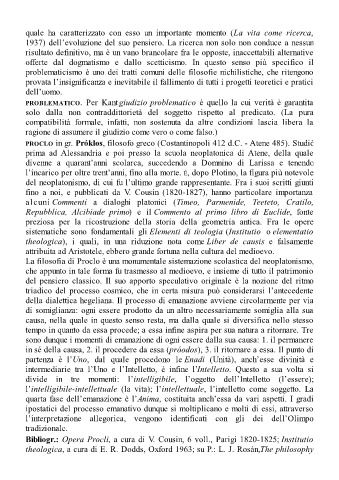Page 674 - Dizionario di Filosofia
P. 674
quale ha caratterizzato con esso un importante momento (La vita come ricerca,
1937) dell’evoluzione del suo pensiero. La ricerca non solo non conduce a nessun
risultato definitivo, ma è un vano brancolare fra le opposte, inaccettabili alternative
offerte dal dogmatismo e dallo scetticismo. In questo senso più specifico il
problematicismo è uno dei tratti comuni delle filosofie nichilistiche, che ritengono
provata l’insignificanza e inevitabile il fallimento di tutti i progetti teoretici e pratici
dell’uomo.
PROBLEMATICO. Per Kant giudizio problematico è quello la cui verità è garantita
solo dalla non contraddittorietà del soggetto rispetto al predicato. (La pura
compatibilità formale, infatti, non sostenuta da altre condizioni lascia libera la
ragione di assumere il giudizio come vero o come falso.)
PROCLO in gr. Próklos, filosofo greco (Costantinopoli 412 d.C. - Atene 485). Studiò
prima ad Alessandria e poi presso la scuola neoplatonica di Atene, della quale
divenne a quarant’anni scolarca, succedendo a Domnino di Larissa e tenendo
l’incarico per oltre trent’anni, fino alla morte. È, dopo Plotino, la figura più notevole
del neoplatonismo, di cui fu l’ultimo grande rappresentante. Fra i suoi scritti giunti
fino a noi, e pubblicati da V. Cousin (1820-1827), hanno particolare importanza
alcuni Commenti a dialoghi platonici (Timeo, Parmenide, Teeteto, Cratilo,
Repubblica, Alcibiade primo) e il Commento al primo libro di Euclide, fonte
preziosa per la ricostruzione della storia della geometria antica. Fra le opere
sistematiche sono fondamentali gli Elementi di teologia (Institutio o elementatio
theologica), i quali, in una riduzione nota come Liber de causis e falsamente
attribuita ad Aristotele, ebbero grande fortuna nella cultura del medioevo.
La filosofia di Proclo è una monumentale sistemazione scolastica del neoplatonismo,
che appunto in tale forma fu trasmesso al medioevo, e insieme di tutto il patrimonio
del pensiero classico. Il suo apporto speculativo originale è la nozione del ritmo
triadico del processo cosmico, che in certa misura può considerarsi l’antecedente
della dialettica hegeliana. Il processo di emanazione avviene circolarmente per via
di somiglianza: ogni essere prodotto da un altro necessariamente somiglia alla sua
causa, nella quale in questo senso resta, ma dalla quale si diversifica nello stesso
tempo in quanto da essa procede; a essa infine aspira per sua natura a ritornare. Tre
sono dunque i momenti di emanazione di ogni essere dalla sua causa: 1. il permanere
in sé della causa, 2. il procedere da essa (próodos), 3. il ritornare a essa. Il punto di
partenza è l’Uno, dal quale procedono le Enadi (Unità), anch’esse divinità e
intermediarie tra l’Uno e l’Intelletto, è infine l’Intelletto. Questo a sua volta si
divide in tre momenti: l’intelligibile, l’oggetto dell’Intelletto (l’essere);
l’intelligibile-intellettuale (la vita); l’intellettuale, l’intelletto come soggetto. La
quarta fase dell’emanazione è l’Anima, costituita anch’essa da vari aspetti. I gradi
ipostatici del processo emanativo dunque si moltiplicano e molti di essi, attraverso
l’interpretazione allegorica, vengono identificati con gli dei dell’Olimpo
tradizionale.
Bibliogr.: Opera Procli, a cura di V. Cousin, 6 voll., Parigi 1820-1825; Institutio
theologica, a cura di E. R. Dodds, Oxford 1963; su P.: L. J. Rosàn, The philosophy