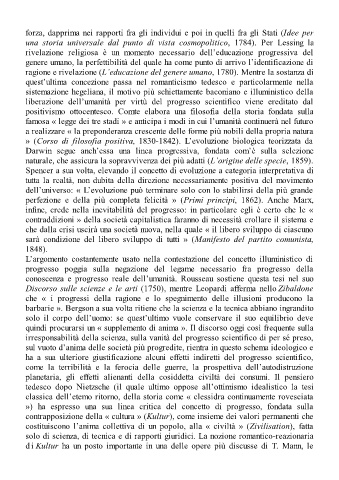Page 676 - Dizionario di Filosofia
P. 676
forza, dapprima nei rapporti fra gli individui e poi in quelli fra gli Stati (Idee per
una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, 1784). Per Lessing la
rivelazione religiosa è un momento necessario dell’educazione progressiva del
genere umano, la perfettibilità del quale ha come punto di arrivo l’identificazione di
ragione e rivelazione (L’educazione del genere umano, 1780). Mentre la sostanza di
quest’ultima concezione passa nel romanticismo tedesco e particolarmente nella
sistemazione hegeliana, il motivo più schiettamente baconiano e illuministico della
liberazione dell’umanità per virtù del progresso scientifico viene ereditato dal
positivismo ottocentesco. Comte elabora una filosofia della storia fondata sulla
famosa « legge dei tre stadi » e anticipa i modi in cui l’umanità continuerà nel futuro
a realizzare « la preponderanza crescente delle forme più nobili della propria natura
» (Corso di filosofia positiva, 1830-1842). L’evoluzione biologica teorizzata da
Darwin segue anch’essa una linea progressiva, fondata com’è sulla selezione
naturale, che assicura la sopravvivenza dei più adatti (L’origine delle specie, 1859).
Spencer a sua volta, elevando il concetto di evoluzione a categoria interpretativa di
tutta la realtà, non dubita della direzione necessariamente positiva del movimento
dell’universo: « L’evoluzione può terminare solo con lo stabilirsi della più grande
perfezione e della più completa felicità » (Primi principi, 1862). Anche Marx,
infine, crede nella inevitabilità del progresso: in particolare egli è certo che le «
contraddizioni » della società capitalistica faranno di necessità crollare il sistema e
che dalla crisi uscirà una società nuova, nella quale « il libero sviluppo di ciascuno
sarà condizione del libero sviluppo di tutti » (Manifesto del partito comunista,
1848).
L’argomento costantemente usato nella contestazione del concetto illuministico di
progresso poggia sulla negazione del legame necessario fra progresso della
conoscenza e progresso reale dell’umanità. Rousseau sostiene questa tesi nel suo
Discorso sulle scienze e le arti (1750), mentre Leopardi afferma nello Zibaldone
che « i progressi della ragione e lo spegnimento delle illusioni producono la
barbarie ». Bergson a sua volta ritiene che la scienza e la tecnica abbiano ingrandito
solo il corpo dell’uomo: se quest’ultimo vuole conservare il suo equilibrio deve
quindi procurarsi un « supplemento di anima ». Il discorso oggi così frequente sulla
irresponsabilità della scienza, sulla vanità del progresso scientifico di per sé preso,
sul vuoto d’anima delle società più progredite, rientra in questo schema ideologico e
ha a sua ulteriore giustificazione alcuni effetti indiretti del progresso scientifico,
come la terribilità e la ferocia delle guerre, la prospettiva dell’autodistruzione
planetaria, gli effetti alienanti della cosiddetta civiltà dei consumi. Il pensiero
tedesco dopo Nietzsche (il quale ultimo oppose all’ottimismo idealistico la tesi
classica dell’etemo ritorno, della storia come « clessidra continuamente rovesciata
») ha espresso una sua linea critica del concetto di progresso, fondata sulla
contrapposizione della « cultura » (Kultur), come insieme dei valori permanenti che
costituiscono l’anima collettiva di un popolo, alla « civiltà » (Zivilisation), fatta
solo di scienza, di tecnica e di rapporti giuridici. La nozione romantico-reazionaria
di Kultur ha un posto importante in una delle opere più discusse di T. Mann, le