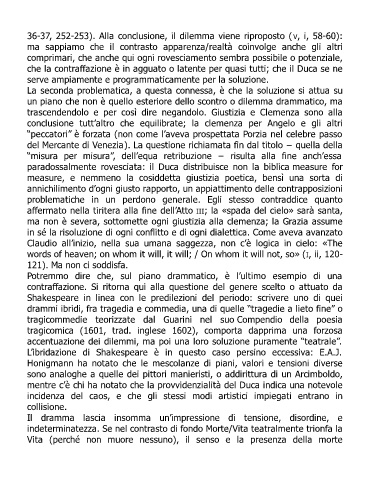Page 941 - Shakespeare - Vol. 3
P. 941
36-37, 252-253). Alla conclusione, il dilemma viene riproposto ( V, i, 58-60):
ma sappiamo che il contrasto apparenza/realtà coinvolge anche gli altri
comprimari, che anche qui ogni rovesciamento sembra possibile o potenziale,
che la contraffazione è in agguato o latente per quasi tutti; che il Duca se ne
serve ampiamente e programmaticamente per la soluzione.
La seconda problematica, a questa connessa, è che la soluzione si attua su
un piano che non è quello esteriore dello scontro o dilemma drammatico, ma
trascendendolo e per così dire negandolo. Giustizia e Clemenza sono alla
conclusione tutt’altro che equilibrate; la clemenza per Angelo e gli altri
“peccatori” è forzata (non come l’aveva prospettata Porzia nel celebre passo
del Mercante di Venezia). La questione richiamata fin dal titolo − quella della
“misura per misura”, dell’equa retribuzione − risulta alla fine anch’essa
paradossalmente rovesciata: il Duca distribuisce non la biblica measure for
measure, e nemmeno la cosiddetta giustizia poetica, bensì una sorta di
annichilimento d’ogni giusto rapporto, un appiattimento delle contrapposizioni
problematiche in un perdono generale. Egli stesso contraddice quanto
affermato nella tiritera alla fine dell’Atto III; la «spada del cielo» sarà santa,
ma non è severa, sottomette ogni giustizia alla clemenza; la Grazia assume
in sé la risoluzione di ogni conflitto e di ogni dialettica. Come aveva avanzato
Claudio all’inizio, nella sua umana saggezza, non c’è logica in cielo: «The
words of heaven; on whom it will, it will; / On whom it will not, so» (I, ii, 120-
121). Ma non ci soddisfa.
Potremmo dire che, sul piano drammatico, è l’ultimo esempio di una
contraffazione. Si ritorna qui alla questione del genere scelto o attuato da
Shakespeare in linea con le predilezioni del periodo: scrivere uno di quei
drammi ibridi, fra tragedia e commedia, una di quelle “tragedie a lieto fine” o
tragicommedie teorizzate dal Guarini nel suo Compendio della poesia
tragicomica (1601, trad. inglese 1602), comporta dapprima una forzosa
accentuazione dei dilemmi, ma poi una loro soluzione puramente “teatrale”.
L’ibridazione di Shakespeare è in questo caso persino eccessiva: E.A.J.
Honigmann ha notato che le mescolanze di piani, valori e tensioni diverse
sono analoghe a quelle dei pittori manieristi, o addirittura di un Arcimboldo,
mentre c’è chi ha notato che la provvidenzialità del Duca indica una notevole
incidenza del caos, e che gli stessi modi artistici impiegati entrano in
collisione.
Il dramma lascia insomma un’impressione di tensione, disordine, e
indeterminatezza. Se nel contrasto di fondo Morte/Vita teatralmente trionfa la
Vita (perché non muore nessuno), il senso e la presenza della morte