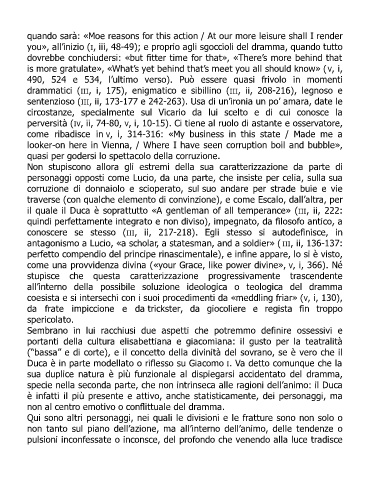Page 930 - Shakespeare - Vol. 3
P. 930
quando sarà: «Moe reasons for this action / At our more leisure shall I render
you», all’inizio (I, iii, 48-49); e proprio agli sgoccioli del dramma, quando tutto
dovrebbe conchiudersi: «but fitter time for that», «There’s more behind that
is more gratulate», «What’s yet behind that’s meet you all should know» ( V, i,
490, 524 e 534, l’ultimo verso). Può essere quasi frivolo in momenti
drammatici (III, i, 175), enigmatico e sibillino (III, ii, 208-216), legnoso e
sentenzioso (III, ii, 173-177 e 242-263). Usa di un’ironia un po’ amara, date le
circostanze, specialmente sul Vicario da lui scelto e di cui conosce la
perversità (IV, ii, 74-80, V, i, 10-15). Ci tiene al ruolo di astante e osservatore,
come ribadisce in V, i, 314-316: «My business in this state / Made me a
looker-on here in Vienna, / Where I have seen corruption boil and bubble»,
quasi per godersi lo spettacolo della corruzione.
Non stupiscono allora gli estremi della sua caratterizzazione da parte di
personaggi opposti come Lucio, da una parte, che insiste per celia, sulla sua
corruzione di donnaiolo e scioperato, sul suo andare per strade buie e vie
traverse (con qualche elemento di convinzione), e come Escalo, dall’altra, per
il quale il Duca è soprattutto «A gentleman of all temperance» (III, ii, 222:
quindi perfettamente integrato e non diviso), impegnato, da filosofo antico, a
conoscere se stesso (III, ii, 217-218). Egli stesso si autodefinisce, in
antagonismo a Lucio, «a scholar, a statesman, and a soldier» ( III, ii, 136-137:
perfetto compendio del principe rinascimentale), e infine appare, lo si è visto,
come una provvidenza divina («your Grace, like power divine», V, i, 366). Né
stupisce che questa caratterizzazione progressivamente trascendente
all’interno della possibile soluzione ideologica o teologica del dramma
coesista e si intersechi con i suoi procedimenti da «meddling friar» (V, i, 130),
da frate impiccione e da trickster, da giocoliere e regista fin troppo
spericolato.
Sembrano in lui racchiusi due aspetti che potremmo definire ossessivi e
portanti della cultura elisabettiana e giacomiana: il gusto per la teatralità
(“bassa” e di corte), e il concetto della divinità del sovrano, se è vero che il
Duca è in parte modellato o riflesso su Giacomo I. Va detto comunque che la
sua duplice natura è più funzionale al dispiegarsi accidentato del dramma,
specie nella seconda parte, che non intrinseca alle ragioni dell’animo: il Duca
è infatti il più presente e attivo, anche statisticamente, dei personaggi, ma
non al centro emotivo o conflittuale del dramma.
Qui sono altri personaggi, nei quali le divisioni e le fratture sono non solo o
non tanto sul piano dell’azione, ma all’interno dell’animo, delle tendenze o
pulsioni inconfessate o inconsce, del profondo che venendo alla luce tradisce